
Una particolarità che si riscontra in modo pressoché universale nelle più varie culture preistoriche, protostoriche e antiche (in una parola, tradizionali) è l’allineamento di importanti strutture di tipo sacrale o civile impostato su particolari orientamenti astronomici.
Le suddette costruzioni, di tipologia varia ed eterogenea, venivano erette in modo da poter osservare direttamente certi punti del paesaggio circostante, punti che fin da epoche lontanissime avevano rivestito un particolare interesse da parte delle popolazioni locali, specialmente dal punto di vista calendariale, e quindi anche sacro e religioso. Gli esempi sono innumerevoli e ben noti: dai tipici osservatori-santuari megalitici diffusi in tutta l’Europa mesolitica e neolitica, all’orientamento del tempio greco diretto ad Est (concetto di tradizione dorica e in seguito ampiamente recuperato dal Cristianesimo antico e medievale), fino ai magnifici e colossali templi di pietra delle civiltà dell’America centrale e meridionale, eretti in linea con particolari posizioni del Sole e degli altri astri (ad esempio il pianeta Venere, particolarmente considerato nella cultura Maya, o la stella Capella della costellazione dell’Auriga, la cui levata al solstizio d’Inverno era attesa dagli Zapotechi di Monte Albán per iniziare la semina del mais).
È il caso di ricordare e considerare una volta di più, infatti, come l’umanità primordiale vedesse e vivesse il legame profondo, pressoché simbiotico tra i cicli dei fenomeni celesti e il regolamento della vita e dell’attività umana. La vita dell’agricoltore e dell’allevatore è necessariamente regolata dalla conoscenza dei ritmi cosmici, fin dai tempi (se non da prima ancora) delle civiltà stanziali del Neolitico (complessivamente situato tra il 9000 a.C. circa fino al III millennio a.C., ma la periodizzazione varia alquanto a seconda dell’area mondiale e delle rispettive culture): l’attenta osservazione delle potenze naturali celesti e terrestri, legate all’alternarsi delle stagioni, deve essere seguita non solo per gli appositi lavori legati alle coltivazioni, ma anche per officiare i relativi riti, sacrifici, preghiere. Per l’uomo antico, ogni fenomeno naturale, ogni manifestazione delle forze cosmiche (non casualmente il greco χοσμος indica un «ordine» universale e interconnesso) è appunto il fenomeno di ciò che ci appare, e che in realtà si trova molto più oltre; sempre in greco il verbo φαίνω, ovvero «apparire», «fare apparire», «manifestare», mantiene la stessa radice lessicale di φως: la luce che fa apparire, che svela ciò che illumina, come ricordano tanti indimenticabili brani dell’opera di Platone. È sempre a ciò che si riferisce un’altra criptica e bellissima immagine, quella del Fuoco universale di Eraclito, definito πύρ e anche λόϒος del Cosmo, che si manifesta nel suo continuo, ordinato espandersi e ritrarsi.
Anche la grande letteratura antica, infatti, testimonia puntualmente e in infiniti casi questo concetto, che ritroviamo ad esempio al centro delle opere di Esiodo (Le opere e i giorni), Arato di Soli (i Fenomeni e pronostici, poema didascalico dedicato appunto agli eventi astronomici e meteorologici), Marco Manilio (gli Astronomica) e Virgilio (le Georgiche), solo per restare nell’ambito della cultura classica.
Naturale, quindi, che la naturale concezione del mondo come un terribile e meraviglioso spettacolo foriero di profondi significati e scandito da ritmi precisi sia stata assolutamente tipica e radicata anche presso le antiche culture del Nordest d’Italia, che hanno espresso questa visione attraverso l’erezione dei tumuli artificiali noti tradizionalmente con i termini di motta, mutera o montiron (plurale montironi) in area veneta, e con quello di gradisca in ambito friulano.
Si tratta di collinette costruite in terra battuta, solitamente di altezza media dai due ai dieci metri e di larghezza variabile, talvolta anche di un centinaio di metri, la cui costruzione si rivela una tradizione ripresa in vari momenti della lunga storia di queste terre, ma la cui origine si perde nell’oscurità dei tempi primigeni.
Sulle culture venete preistoriche e protostorichePare che fin da tempi lontanissimi l’antica terra veneta si sia rivelata florida e ospitale per i vari popoli che vi si sono insediati nel corso dei millenni; questo grazie alla ricchezza delle acque, la fertilità della terra e gli abbondanti territori di caccia, incentivi fondamentali per una vita meno dura e per lo sviluppo delle comunità. Le più antiche tracce di una attività umana nella regione sono state rinvenute in provincia di Verona, nei siti di Quinzano, Riparo Tagliente, Torbiera di Barbarago e Grotta di Fumane, che hanno restituito reperti risalenti al Paleolitico medio e inferiore.
Decine di millenni più tardi, nel Veneto neolitico, si sviluppano numerosi e importanti siti della cosiddetta civiltà dei vasi “a bocca quadrata”, cultura ampiamente diffusa in tutta l’Europa dell’epoca. Nell’Età del Bronzo Antico (collocabile all’incirca tra la fine del III millennio e il 1500/1200 a.C.) si ha la comparsa della cultura di Polada, una civiltà palafitticola diffusa nell’Italia settentrionale dell’epoca e particolarmente radicata in Veneto nelle zone del Lago di Garda, dei Colli Euganei e nella Valle dell’Adige. Gli agricoltori di Polada utilizzano le tecniche lavorative tipiche dell’epoca, come l’uso dell’aratro e degli animali da traino; è in quest’epoca che il cavallo diviene un animale da allevamento molto importante nel territorio, tanto che nei secoli seguenti i cavalli veneti diverranno molto apprezzati e richiesti presso i popoli limitrofi e soprattutto nel mondo greco e romano. Successivamente si manifesta la cultura dei castellieri, caratterizzata appunto dalla diffusione di abitati fortificati, costituiti da pietre a secco accatastate, posti in cima alle colline nelle zone pedemontane (valli alpine e valle dell’Adige), che saranno riutilizzati e manomessi in epoca romana e altomedievale.
Originata dalla precedente cultura terramaricola diffusa in Emilia, Lombardia e Veneto occidentale, è approssimativamente tra il XI e il IX/VIII secolo a.C. che si sviluppa la cosiddetta cultura protovillanoviana, che nel giro di qualche secolo avrebbe poi originato, o almeno mantenuto delle considerevoli influenze, sulle culture tirrenica ed etrusca che introducono intorno al IX secolo l’uso del ferro.
Tra VIII e VII secolo compare invece la celebre civiltà atestina o paleoveneta, cultura proveniente dall’Europa orientale che parla una lingua indoeuropea vicina al latino e utilizza un proprio alfabeto (mutuato da quello etrusco) di cui si hanno iscrizioni databili dal VI secolo.
La civiltà degli Atestini/Paleoveneti, o Veneti in senso stretto poiché proprio loro per primi si sarebbero fregiati di questo nome (che significa probabilmente «i vincitori»), ha lasciato numerose e rilevanti tracce di un alto livello artistico e tecnologico: elaborate ceramiche, situle, vasi, figurine votive scolpite in metallo o bronzo offerte presso importanti santuari sono stati ritrovati nelle aree di Vicenza, Abano, Lagole nel Cadore, fino a certe zone dell’attuale Friuli (come provano reperti rinvenuti nell’area di San Vito al Tagliamento). Tra le sedi urbane più importanti della civiltà paleoveneta c’è Este, ovvero l’antica Ateste, seguita dagli antichi nuclei di Vicenza, Treviso, Asolo, Oderzo e Altino, e naturalmente Padova, fondata da Antenore transfuga da Troia secondo una tradizione riportata dal patavino Tito Livio (la leggenda si ricollegherebbe alla teoria della provenienza dei Veneti dall’Est, forse dall’Illiria o più probabilmente dalla Paflagonia).
La cultura paleoveneta fiorisce anche attraverso le vive attività commerciali intraprese con gli abitanti dei territori confinanti, come i Reti a nord, gli Euganei diffusi dall’Istria al Garda e le varie popolazioni germaniche d’oltralpe, fino alle comunità etrusche stanziate nella Pianura Padana presso il Po e perfino con la Grecia arcaica e la civiltà cipriota (attraverso la laguna e le principali vie fluviali come l’Adige, il Brenta, il Sile e il Livenza). Tra il VI e il III secolo si verificano progressivamente contatti commerciali, nonché scontri, tra i Paleoveneti e i popoli di cultura celtica diffusi tra la Pianura Padana, il Friuli e le Alpi orientali. Nel corso del I secolo a.C., la forte pressione dei Celti nel territorio determinerà l’alleanza e l’amicizia tra Paleoveneti e Romani, che dopo le vittorie sulle popolazioni galliche locali (Insubri, Gesati, Carni, Boi), estenderanno ai nuovi alleati i benefici della cittadinanza romana con la Lex Roscia del 49 a.C. Pochi decenni dopo, il Veneto diviene ufficialmente la X Regio augustea, in seguito Venetia et Histria, entrando definitivamente nell’orbita di Roma.
La centralità culturale delle motte nel Veneto antico: dimore funerarie, osservatori-santuari e altro ancoraIl senso del Sacro degli antichi Veneti non si esprime in vere e proprie costruzioni templari, ma all’aperto, in ambienti naturali come boschi, campi e le varie zone legate alla presenza dell’acqua (fiumi, laghi, sorgenti). Il culto autoctono più importante e diffuso è quello della dea Reitia, multiforme principio femminile di fecondità e salute legata alle acque e agli animali, ma anche alla rigenerazione e quindi alla morte. Ad essa si usava consacrare offerte come piccoli ex voto bronzei raffiguranti parti del corpo risanate o da guarire, oppure un particolare tipo di tavolette votive. Molto sentito era il culto dei defunti, ai quali veniva riservata la pratica tipicamente indoeuropea della cremazione seguita dal seppellimento delle urne cinerarie in apposite tumulazioni, per l’appunto quelle che in seguito verranno denominate motte, accompagnate da monili e oggetti personali.
L’erezione dei tumuli artificiali era infatti volta anche e soprattutto a questa funzione funeraria, ed è interessante notare come la tradizione delle motte venete e friulane dimostri una evidente analogia con svariate culture del mondo antico. Molto più a nord, infatti, le società norrene praticarono la medesima tradizione nell’ambito delle ritualità funebri, come prova ad esempio il sito archeologico di Gamla Uppsala, in Svezia, caratterizzato dalla presenza di grandi tumuli funerari contenenti ceneri inumate, risalenti all’epoca di Vendel (VI secolo d.C. - fine dell’VIII). Allo stesso modo, il ruolo di ultime dimore era attribuito ai tumuli eretti dalla preistoria fino all’Età del Ferro in varie zone dell’area mongola e siberiana (espressione delle cosiddette culture Kurgan), proprio come avveniva fino a pochi secoli fa presso vari popoli nativi del Nord America; è significativo, inoltre, che nell’antichissimo massiccio montuoso di Snowdonia, nel Galles nordoccidentale, la vetta del monte sacro delle tradizioni locali porti il nome di Yr Widdfa, che significa nientemeno che «tumulo sepolcrale».
La storia e la religiosità delle genti venete sono quindi rappresentate anche dalla vasta diffusione di questi manufatti, testimonianza plurimillenaria di una usanza atavica (di cui rimane traccia anche nel toponimo della località di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, il cui riferimento sarebbe da ricercare proprio nell’esistenza di una antica fortificazione militare romana e preromana posizionata su uno dei suddetti tumuli). Di grande interesse sono le possibili etimologie di questo nome tradizionale: «mutera» e «motta» risalirebbero probabilmente all’antica forma indoeuropea *mut, indicante appunto un rilievo del terreno (ed è notevole come il termine sembri ricollegarsi al latino mater e al tedesco mutter, forse per un sottile ma preciso riferimento alla terra come principio di fecondità e maternità, e quindi di rinascita dopo la morte). Del resto, si ritrova lo stesso significato in termini antico-germanici come il frisone mot, il bavarese mott e lo svizzero motte. Altre suggestive e particolari analogie linguistiche riportano al sostrato culturale indoeuropeo: mentre in gaelico troviamo l’espressione pressoché identica mota, ovvero «collina», si nota una certa assonanza con il nome di Mide (e soprattutto Meath, l’attuale forma anglicizzata con cui esso è tramandato), ovvero l’antico regno situato nella regione centrale dell’Irlanda celtica. René Guénon, in Il Re del Mondo, sottolinea inoltre come, oltre a significare letteralmente «nel mezzo di» denotando una somiglianza con il latino medium, il nome della contea irlandese indicherebbe l’esistenza di una pietra di grandi dimensioni eretta a Ushnagh, località che, evidentemente non a caso, occupa il centro della regione.
Tornando a noi, la presenza delle antiche motte è ampiamente distribuita nelle zone di pianura del Veneto centrale, orientale e nordorientale, grosso modo corrispondenti all’area dell’attuale provincia di Treviso (la medievale Marca Trevigiana, comprendente importanti centri dalle antiche origini come Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto) e dell’entroterra rurale tra Venezia e Padova (ad esempio nelle località di Scorzè, Martellago, Massanzago, Noale, San Pietro in Gu’), senza dimenticare importanti esemplari nell’area del Vicentino e del Veronese, fino a sconfinare in Trentino-Alto Adige e in Friuli dove sono particolarmente numerose le motte e i castellieri di datazione preistorica.
Le rispettive edificazioni dei numerosissimi siti risalgono, come si è accennato, ad epoche molto diverse e a motivazioni altrettanto varie: tumuli funerari (secondo le ricerche dello studioso e speleologo friulano Lodovico Quarina, vissuto tra XIX e XX secolo, le motte diffuse tra Veneto orientale e Friuli adibite alla funzione tombale assommerebbero a ben 314), osservatori astronomici volti alla contemplazione dei movimenti celesti in momenti topici dell’anno come i solstizi e gli equinozi, nonché postazioni difensive, specialmente se circondate da strutture apposite come aggeri o terrazzamenti. Alcune di esse sono di datazione preistorica, altre protostoriche e ricollegabili soprattutto alla cultura atestina poi assimilata dalla romanizzazione, mentre altre ancora sono di molto successive risalendo all’epoca medioevale o addirittura moderna, essendo state realizzate soltanto qualche secolo fa. Le motte di età più recente, infatti, sono spesso resti di quelle tipiche “ricostruzioni del paesaggio” volte ad arricchire i giardini di certe ville venete, progettate da architetti del XVII e XVIII secolo (come nel caso della mutera sita in Villa Toderini a Codogné, presso Conegliano), mentre altre fungevano da ghiacciaia naturale per conservare le provviste di carne isolate termicamente in una cavità scavata all’interno della collinetta.
I primi studi storico-scientifici sulle motte e i castellieri più antichi conosciuti in Veneto e Friuli risalirebbero già al XVIII secolo, grazie all’opera dell’archeologo Gian Domenico Bertoli, in seguito proseguiti da studiosi come Carlo De Marchesetti (1850-1926), il già citato Quarina, il cui pionieristico lavoro ha portato inoltre alla suddivisione in tipologie di “tombe coniche” e “tombe mammellonari”, e altri ancora. Ma è soprattutto dalla seconda metà del Novecento, grazie a discipline specialistiche e relativamente nuove come l’archeoastronomia (fondata dall’astronomo inglese Norman Lockyer a inizio XX secolo) e l’archeologia del paesaggio (sviluppata soprattutto dagli anni Sessanta e Settanta), che è proseguita una nutrita e autorevole serie di ricerche sugli antichi tumuli veneti.
Prendiamo ora in considerazione, per una breve panoramica su alcuni dei casi più importanti e rappresentativi, alcune delle più celebri motte distribuite nella provincia di Treviso.
La caratteristica di questi siti, che certifica con evidenza la loro grande antichità, è quella di dimostrare delle connotazioni sacrali legate tanto alla ritualità funeraria quanto all’orientamento astronomico e alle osservazioni celesti. Tra gli esemplari più interessanti ve ne sono di situati nelle zone rurali presso frazioni del comune di Oderzo (centro urbano molto antico il cui territorio ha restituito numerosissime vestigia romane e preromane), come la motta di Colfrancui, quella di Prà dei Gai e quella di Campomolino.
[caption id="attachment_47715" align="alignright" width="300"] Mutera di Colfrancui[/caption]
Mutera di Colfrancui[/caption]
La mutera di Colfrancui, come è appunto chiamata secondo l’espressione locale, è una delle più importanti della zona dell’Opitergino per la particolarità della sua disposizione e per le numerose funzioni che ha assunto nel corso dell’antichità. L’edificazione del tumulo, in terra battuta e di forma tipicamente conica, risale all’epoca paleoveneta e allo stato attuale raggiunge l’altezza di circa 5 metri. Nei primi anni Ottanta, una campagna di scavo riportò alla luce dei frammenti di vasellame e lo scheletro di un cavallo in buono stato (oltre a stabilire che la collinetta venne riutilizzata in epoca romana come fornace): reperti che indicherebbero quindi la funzione tombale della struttura, forse riservata a persone di alto lignaggio. Inoltre, l’area che circonda la motta è delimitata da due lunghi e bassi terrapieni rettilinei oltre i quali due canali di scolo convogliano le acque piovane, ciò evidentemente per finalità volte a qualche rito propiziatorio (il quale ci rimane totalmente ignoto) basato sui due elementi principalmente legati alla fertilità, l’acqua e la terra. Alla fine degli anni Settanta, uno dei maggiori studiosi italiani e internazionali di archeoastronomia, il professor Giuliano Romano (1923-2013), svolse una ricerca sulla struttura dell’area della motta che ha confermato le particolari misure astronomiche secondo le quali essa è orientata. I due terrapieni sono disposti, rispettivamente, uno proprio verso la levata del Sole nel solstizio d’inverno da una parte, e sul solstizio estivo dall’altra; l’altro rilievo, invece, è diretto sulla levata della Luna in corrispondenza della sua periodica massima distanza dall’eclittica, ovvero ogni 18,6 anni (periodo legato al fenomeno detto retrogradazione dei nodi lunari, la cui manifestazione è un percorso più ampio del solito e un culmine molto alto sull’orizzonte da parte del satellite).
La stessa programmatica posizione per osservare questa congiunzione lunare si è riscontrata presso una delle quattro piccole motte site in località Colbertaldo (le quali sono peraltro chiaramente edificate secondo l’orientamento solare nei giorni dei Solstizi e degli Equinozi), nel comune di Vidor presso il Montello, a nord di Treviso: si tratta di un orientamento alquanto particolare ed interessante, volto all’osservazione di questa singolare congiunzione lunare durante la quale, probabilmente, si riteneva maggiore la potenza magica dell’astro notturno.
Nei pressi di Ponte di Piave è invece raggiungibile la mutera in località Campomolino (frazione di Gaiarine), che “svetta” tra le vigne dei campi di una proprietà privata. Documenti locali datati 1464 e 1533 confermano all’epoca la presenza della collinetta artificiale, così come le mappe topografiche del Catasto Napoleonico-Austriaco risalenti al 1830, ma non si è ancora giunti a stabilire se essa fungesse da fortino difensivo o da strumento di osservazione astronomica, né tantomeno a dedurre un’età approssimativa per la sua origine. Alcuni scavi nei pressi della collinetta diretti nei primi anni Ottanta dal professor Marco Tonon (in seguito divenuto direttore del Museo di Scienze Naturali di Brescia), coadiuvato dal già citato professor Romano, hanno permesso il ritrovamento di alcuni cocci e frammenti risalenti all’Alto Medioevo, forse di epoca longobarda, che non dimostrano un utilizzo funerario della struttura precedente a tale periodo.
Tornando nel comune di Oderzo, a non molti chilometri di distanza, troviamo la mutera presso il fiume Rasego, in località Prà dei Gai. Il piccolo tumulo (di poco più di un metro di altezza) è circondata da un terrapieno, denominato castelir nel dialetto locale, presso il quale scavi archeologici hanno restituito reperti in ceramica risalenti all’Età del Bronzo. Come nel caso della motta di Colfrancui siamo di fronte a un tipo di “santuario astronomico”, e specificamente volto all’osservazione solstiziale: sulla parte meridionale del rialzamento circostante la motta, è possibile ammirare la levata del Sole la mattina del solstizio invernale. È curioso e interessante notare come la chiesetta bassomedievale di Borgo Servi, ubicata a circa un chilometro di distanza da Prà dei Gai in prossimità di Portobuffolè, denoti a sua volta un orientamento dell’abside proprio in direzione della levata eliaca del solstizio d’Inverno, a dimostrazione di come questa antichissima tradizione fosse mantenuta nell’architettura sacra delle campagne venete ancora nel XIV secolo dopo Cristo.
[caption id="attachment_47714" align="alignright" width="300"] Chiesetta di Borgo Servi presso Portobuffole[/caption]
Chiesetta di Borgo Servi presso Portobuffole[/caption]
Notevole in questo senso è anche il sito delle cosiddette Motte di Sotto, situate tra la località di Castello di Godego (TV) e quella di San Martino di Lupari (PD), raggiungibili sulla Treviso-Vicenza pochi chilometri dopo Castelfranco Veneto. Il luogo è stato oggetto nel corso del Novecento degli studi di Alessio de Bon, di Ludovico Quarina e del celebre ricercatore Cino Boccazzi, che in una campagna di scavo nel 1953 ritrovò dei cocci risalenti probabilmente all’Età del Ferro. In realtà il nucleo più antico della costruzione risale all’incirca al XIV secolo a.C. e si tratta perlopiù di un antico castelliere della tarda e media Età del Bronzo, ovvero ciò che rimane di un vero e proprio villaggio arginato a forma di grande parallelogramma i cui lati misurano una lunghezza superiore a circa 200 metri. Fatto singolare e significativo, il castelliere è disposto in modo asimmetrico rispetto al tracciato della centuriazione romana che appare ancora oggi evidente nella topografia delle strade e dei campi della zona. Ciò dimostra, probabilmente, un evidente rispetto dei Romani nei confronti delle antiche strutture civili, già vetuste di secoli ai tempi della romanizzazione del territorio veneto. Non è tutto: anche in questo caso, dall’analisi dei resti dell’antico villaggio arginato delle Motte di Sotto ritornano gli orientamenti astronomici solstiziali.
È stato dimostrato che i due aggeri circostanti, posti ad Est e ad Ovest, puntano quasi esattamente da una parte ove leva il Sole al giorno del solstizio invernale, dall’altra dove tramonta in occasione di quello estivo. Nonostante le non buone condizioni della struttura, sono tuttavia ancora evidenti la precisione e la preparazione nell’ambito dell’osservazione celeste da parte di coloro che abitarono il Veneto dell’Età del Bronzo: l’elevazione dell’aggere era infatti strategica per individuare le date fondamentali dell’anno agricolo, tramite l’osservazione delle levate e dei tramonti solstiziali all’orizzonte.
Per comprendere questo concetto molto diffuso, quasi sistematico nell’edificazione delle motte antiche e preistoriche concentrate nelle aree rurali del Nordest, è il caso di ricordare quanto l’evento del solstizio invernale, con la sua apparente e temporanea morte del Sole seguita dalla lunga rinascita verso l’equinozio di Primavera, fosse profondamente atteso e magnificato dalle varie tradizioni dei popoli europei (e non solo, come si è accennato per quanto riguarda le civiltà mesoamericane). Ad esempio presso i Celti era indicato come «Alban Arthuan» (la rinascita del dio Sole), per i Germani era «Yule» e in Scandinavia «Jul» (la Ruota dell’anno o Ruota solare), senza ovviamente tralasciare il Dies Natalis Solis Invicti romano (apice del periodo festivo dei Saturnalia nella seconda metà di dicembre) e la nascita di Mithra, importante divinità della Tradizione Indo-iranica assimilata e “naturalizzata” in quella di Roma imperiale.
La preistoria e la protostoria europea hanno lasciato numerosissime testimonianze di luoghi adibiti a templi astronomici che, da quanto si è riscostruito, erano dedicati proprio all’osservazione dello spettacolo offerto dal tramonto o dalla levata del Sole in questo particolare momento cosmico, la cui importanza simbolica e rituale era assolutamente centrale nella visione dell’uomo. L’esempio più arcinoto rimane il complesso megalitico di Stonehenge, in Gran Bretagna (che dimostra ben 24 orientamenti astronomicamente significativi), ma si possono citare luoghi affini e altrettanto importanti come il sito di Newgrange in Irlanda e Kermario in Francia, oppure il complesso megalitico del monte Croccia, in Basilicata, frequentato dalle popolazioni locali dal Neolitico fino ai primi secoli avanti Cristo. Si attribuisce un impiego magico-rituale legato al giorno del solstizio anche alle numerose incisioni preistoriche a carattere esplicitamente solare, come quelle che caratterizzano i siti paleolitici di Bohuslän e Nämforsen in Svezia, o il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri sito a Capo di Ponte in Valcamonica (Lombardia), i cui reperti datano dal Neolitico all’Età del Bronzo.
Gli stessi Reti, antica popolazione preindoeuropea diffusa tra l’attuale Trentino Alto-Adige, la Svizzera e l’Austria, che come si è detto entrarono in contatto con i Veneti, praticavano riti propiziatori a base di roghi di sterpi per aiutare il percorso della rinascita solare in occasione del solstizio. Si tratta chiaramente della stessa usanza tramandata nella cerimonia del Panevìn veneto e del Pignarûl friulano, ovvero l’accensione, in periodo solitamente post-natalizio, dei falò notturni a scopo scaramantico e divinatorio (attraverso le ceneri o la direzione del fumo), diffusa nel Nordest italiano fino all’Emilia occidentale. Da ciò che si è ricostruito, come nel caso delle Motte di Sotto di Oderzo o quella sita a Colfrancui, numerose mutere paleovenete e gli annessi “castellieri”, spesso ad esse precedenti di secoli, rientrano in questa tipologia di osservatori solstiziali. Potremmo citare anche il caso del cosiddetto castelar di Volpago, purtroppo in parte demolito, che ci riporta sulle pendici del Montello. Dalla chiesa parrocchiale di Giavera del Montello (probabilmente costruita anch’essa su un antico castelliere), posta a poca distanza, si può ancora oggi osservare il tramonto del Sole nel solstizio d’Inverno, proprio in coincidenza del castelliere di Volpago.
[caption id="attachment_47713" align="alignright" width="300"] Mutera di Campomolino al crepuscolo[/caption]
Mutera di Campomolino al crepuscolo[/caption]
Concludiamo questa breve rassegna di alcune tra le più importanti mutere della campagna trevigiana (oltre a rimandare ovviamente alla corposa e documentata bibliografia relativa, di cui indichiamo più in basso qualche titolo significativo), rimarcando che questi importanti monumenti dell’antichità veneta non possono che essere rispettati e salvaguardati: di tante motte e castellieri, oggi, rimangono infatti ben poche tracce non tanto a causa dell’incuria e del passare dei secoli, ma soprattutto per un apposito sventramento a causa dei lavori legati alla nuova edilizia e alle modifiche della viabilità. È il caso ad esempio del grande aggere di Veronella Alta, località tra Vicenza e Verona in cui è ubicato il suddetto tracciato dell’Età del Bronzo Antico (ciò che rimane del solco primigenio circostante un antico villaggio), la cui originaria forma perfettamente ovale è sfigurata ormai da vari decenni, ma si potrebbero indicare altri esempi nel territorio trevigiano, come il citato castelliere di Volpago, e oltre.
Oltre a essere parte della deturpazione (ma si dice “rimodernamento!”) di una delle campagne più splendide d’Italia, che nell’ultimo mezzo secolo è stata ampiamente ricoperta di asfalto e cemento in vilipendio alla salute dei cittadini e alla bellezza estetica del paesaggio naturale, la demolizione degli antichi monumenti veneti denuncerebbe né più né meno che uno sradicamento della nostra più antica cultura autoctona, un’offesa alla meraviglia e al rispetto che i nostri avi nutrivano verso la natura e l’universo, stabilendo un ideale punto di contatto fra la terra e il cielo. Non certo una novità, in un’epoca in cui si tende troppo spesso a dimenticare che, da che mondo è mondo, un albero non può crescere e mantenersi saldo senza le proprie radici.
Bibliografia consultata: AA.VV. Manuale di cultura veneta. Geografia, storia, lingua e arte, a cura di Manlio Cortelazzo, Regione del Veneto / Marsilio, Venezia 2004. AA.VV. Popoli Italici. L’Italia prima di Roma, Giunti, Firenze 2006. AA.VV., Primo seminario sulle ricerche archeoastronomiche in Italia, in Giornale di astronomia, voll. 12-13, 1986-1987. AA.VV., Venetkiens. Viaggio nella terra dei veneti antichi, Marsilio, Venezia 2013. Fabio Calabrese, L’Italia megalitica, pubblicato su www.ereticamente.net in data 23 marzo 2020. Loredana Capuis, I Veneti. Società e cultura di un popolo dell’Italia preromana, Longanesi, Milano 1993. René Guénon, Il Re del Mondo, Adelphi, Milano 1977. Silvano Lorenzoni, I Veneti preromani nel contesto europeo, pubblicato su www.centrostudilaruna.it in data 1 gennaio 2000. Paola Moscati, Ogni cosa a suo posto. Sole, Luna, costellazioni e altri corpi celesti: esiste davvero un rapporto con l’archeologia?, in Archeo n.191 anno XVII, De Agostini – Rizzoli, Milano, gennaio 2001. Saba Mariani Sparvoli, I Comuni della Marca Trevigiana, Editoriale Del Drago, Milano 1991. Giuliano Palmieri, Treviso dalla preistoria all’età romana, in AA.VV., Treviso Nostra. Ambiente Storia Arte Tradizioni, Associazione Tarvisium, Treviso 1980. Simone Pedron, Simone Deola, Le motte. Un’ipotesi intrigante per l’entroterra veneziano, pubblicato su Il Rivolo. Associazione culturale a Rio San Martino di Scorzè in data 26 gennaio 2010. Giuliana Poli, Il Solstizio d’Inverno tra Mithra ed Ekate, pubblicato su www.ereticamente.net in data 22 dicembre 2016. Giuliano Romano, Michele Notarangelo, Enio Vanzin, L’uomo e il cosmo. Attraverso antiche testimonianze venete e vecchi strumenti d’osservazione, Società Industrie Tipolitografiche s.r.l., Treviso 1997. Giovanni Sessa, Tempo e cosmo. Il significato occulto del calendario, pubblicato su www.centrostudilaruna.it in data 16 febbraio 2015.

 La filosofia evoliana è ultrattualista, sorse quale tentativo di superamento del limite meramente gnoseologico incontrato dall’attualismo. L’atto puro del pensatore di Castelvetrano per Evola non è mai compiutamente realizzato, è entità di conoscenza, ma non potenza attiva. Attraverso il recupero di Fichte, nota Donà, nella contrapposizione di Io e non-io, l’idealista magico avverte qualcosa che non ci: «limita affatto definitivamente» (p. 17), oltre la quale è possibile riconoscere un’ulteriorità cui tendere. Siamo chiamati da questo oltre e ciò rende evidente: «il suo far già parte della mia (nostra) esperienza» (p.18). Tutto quel che è, esiste in quanto posto dall’Io: l’incontro con il mondo innesca lo sforzo. Il limite agisce da motore dell’Io, permettendogli di essere, a tutti gli effetti, atto sempre all’opera. L’Io gentiliano tale situazione l’aveva conosciuta, mentre Evola vuole renderla reale, fattiva. Va mostrato, nelle cose, che l’oggetto non è altro da noi! Allo scopo esso va trasfigurato ma, si badi, la sua trasfigurazione è possibile a condizione che l’Io stesso si metamorfizzi. Se l’azione trasmutante si fosse manifestata solo nei confronti del mondo, Evola sarebbe rimasto all’interno della prospettiva della Sinistra hegeliana, al prassismo di Marx. Il filosofo romano è ben più radicale, sa che l’Io: «in quanto incondizionato, non può venire identificato con alcuna forma» (p. 21), deve negare ogni norma inconfutabile, sottrarsi ad ogni imperativo, anche quando a vincolarlo: «dovesse essere la stessa incondizionata libertà» (p. 22).
La filosofia evoliana è ultrattualista, sorse quale tentativo di superamento del limite meramente gnoseologico incontrato dall’attualismo. L’atto puro del pensatore di Castelvetrano per Evola non è mai compiutamente realizzato, è entità di conoscenza, ma non potenza attiva. Attraverso il recupero di Fichte, nota Donà, nella contrapposizione di Io e non-io, l’idealista magico avverte qualcosa che non ci: «limita affatto definitivamente» (p. 17), oltre la quale è possibile riconoscere un’ulteriorità cui tendere. Siamo chiamati da questo oltre e ciò rende evidente: «il suo far già parte della mia (nostra) esperienza» (p.18). Tutto quel che è, esiste in quanto posto dall’Io: l’incontro con il mondo innesca lo sforzo. Il limite agisce da motore dell’Io, permettendogli di essere, a tutti gli effetti, atto sempre all’opera. L’Io gentiliano tale situazione l’aveva conosciuta, mentre Evola vuole renderla reale, fattiva. Va mostrato, nelle cose, che l’oggetto non è altro da noi! Allo scopo esso va trasfigurato ma, si badi, la sua trasfigurazione è possibile a condizione che l’Io stesso si metamorfizzi. Se l’azione trasmutante si fosse manifestata solo nei confronti del mondo, Evola sarebbe rimasto all’interno della prospettiva della Sinistra hegeliana, al prassismo di Marx. Il filosofo romano è ben più radicale, sa che l’Io: «in quanto incondizionato, non può venire identificato con alcuna forma» (p. 21), deve negare ogni norma inconfutabile, sottrarsi ad ogni imperativo, anche quando a vincolarlo: «dovesse essere la stessa incondizionata libertà» (p. 22). Non solo il jazz, ma le produzioni Dada, movimento artistico nel quale Evola svolse un ruolo teorico-pratico di primo piano, testimoniano la medesima tendenza a sintonizzarsi sulla vita nova, l’eterna primavera dionisiaca. La negazione Dada per Evola è sintonica a quella dell’idealismo magico, è l’Io stesso: «che si realizza in un “potere di arbitrio assoluto”» (p. 84), in pura indifferenza. Diversamente dal precedente hegeliano, in Evola la potenza negatrice non si trasforma in strumento di un’affermazione superiore, in un nuovo universale positivo, ma indica la «pura libertà». Essa ci dice che tanto il fare in un certo modo, quanto il non fare, sono la medesima cosa. La Gioconda o un biglietto di tram, hanno la stessa valenza artistica, perché Dada attribuisce allo spettatore tratto demiurgico. Ricorda Donà, nel capitolo dedicato al confronto Evola-Jünger, che il filosofo-mago agisce-senza-agire, consapevole della presenza in lui di una forza che pur presentandosi come volontà, non lo è. Essa si dà nella «prova» dell’amore, nella quale l’individuo assoluto si mostra capace di amare: «ognuna delle alterità istituite dalla sua stessa volontà» (p. 35).
Non solo il jazz, ma le produzioni Dada, movimento artistico nel quale Evola svolse un ruolo teorico-pratico di primo piano, testimoniano la medesima tendenza a sintonizzarsi sulla vita nova, l’eterna primavera dionisiaca. La negazione Dada per Evola è sintonica a quella dell’idealismo magico, è l’Io stesso: «che si realizza in un “potere di arbitrio assoluto”» (p. 84), in pura indifferenza. Diversamente dal precedente hegeliano, in Evola la potenza negatrice non si trasforma in strumento di un’affermazione superiore, in un nuovo universale positivo, ma indica la «pura libertà». Essa ci dice che tanto il fare in un certo modo, quanto il non fare, sono la medesima cosa. La Gioconda o un biglietto di tram, hanno la stessa valenza artistica, perché Dada attribuisce allo spettatore tratto demiurgico. Ricorda Donà, nel capitolo dedicato al confronto Evola-Jünger, che il filosofo-mago agisce-senza-agire, consapevole della presenza in lui di una forza che pur presentandosi come volontà, non lo è. Essa si dà nella «prova» dell’amore, nella quale l’individuo assoluto si mostra capace di amare: «ognuna delle alterità istituite dalla sua stessa volontà» (p. 35).





 La luminosa statuaria greca dei vari Fidia, Prassitele, Policleto e di altri ancora, è lì ad offrirci una luminosa testimonianza di quel clima culturale. Ma il messaggio di Platone, non è rimasto né inascoltato, né isolato. L’inizio del declino della civiltà classica, rappresentato dalle conquiste di Alessandro Magno e dall’inizio dell’Età Ellenistica, assisterà ad un ulteriore sviluppo delle istanze platoniche, attraverso tutta quella serie di autori comunemente definiti “neoplatonici”, a partire da Plotino in poi, passando attraverso i vari Giamblico, Porfirio, Proclo, Prisco ed altri ancora. Allievo di Ammonio Sacca, presso la scuola di Alessandria e successivamente influenzato da Filone di Alessandria e Numenio di Apamea, Plotino apporterà all’edificio ideologico platonico un apporto di portata tale, da segnarne in modo decisivo l’intero percorso attraverso i secoli a venire. Due sono gli elementi centrali in tutta la narrazione plotiniana e che caratterizzeranno anche quella neoplatonica successiva. Il primo è rappresentato dal tema dell’emanazione che, già in nuce nella narrazione platonica, qui conosce la propria definitiva esplicitazione ed inquadramento in un ben determinato sistema metafisico. Il secondo, è quello legato all’idea di un “Uno” da cui l’intera realtà discende, stavolta però, caratterizzato da una quanto mai incolmabile distanza dal mondo della materia, tanto da far asserire la propria “non esistenza”, poiché quest’ultima sarebbe una proprietà tutta connaturata al mondo della materia. E pertanto, il sistema plotiniano si presenta come un tutto armonico, un vero e proprio sistema di interrelazioni, al cui vertice sta un Uno , la cui irreconciliabilità con il mondo della materia, fa sì che quest’ultimo discenda e derivi da questo per indiretta “emanazione”.
La luminosa statuaria greca dei vari Fidia, Prassitele, Policleto e di altri ancora, è lì ad offrirci una luminosa testimonianza di quel clima culturale. Ma il messaggio di Platone, non è rimasto né inascoltato, né isolato. L’inizio del declino della civiltà classica, rappresentato dalle conquiste di Alessandro Magno e dall’inizio dell’Età Ellenistica, assisterà ad un ulteriore sviluppo delle istanze platoniche, attraverso tutta quella serie di autori comunemente definiti “neoplatonici”, a partire da Plotino in poi, passando attraverso i vari Giamblico, Porfirio, Proclo, Prisco ed altri ancora. Allievo di Ammonio Sacca, presso la scuola di Alessandria e successivamente influenzato da Filone di Alessandria e Numenio di Apamea, Plotino apporterà all’edificio ideologico platonico un apporto di portata tale, da segnarne in modo decisivo l’intero percorso attraverso i secoli a venire. Due sono gli elementi centrali in tutta la narrazione plotiniana e che caratterizzeranno anche quella neoplatonica successiva. Il primo è rappresentato dal tema dell’emanazione che, già in nuce nella narrazione platonica, qui conosce la propria definitiva esplicitazione ed inquadramento in un ben determinato sistema metafisico. Il secondo, è quello legato all’idea di un “Uno” da cui l’intera realtà discende, stavolta però, caratterizzato da una quanto mai incolmabile distanza dal mondo della materia, tanto da far asserire la propria “non esistenza”, poiché quest’ultima sarebbe una proprietà tutta connaturata al mondo della materia. E pertanto, il sistema plotiniano si presenta come un tutto armonico, un vero e proprio sistema di interrelazioni, al cui vertice sta un Uno , la cui irreconciliabilità con il mondo della materia, fa sì che quest’ultimo discenda e derivi da questo per indiretta “emanazione”. Per un paradossale processo di eterogenesi dei fini, proprio laddove si voleva anelare allo spirito, si finisce con il vivere appieno l’immediatezza materiale, nell’ attesa di una catarsi spirituale sempre più eterea e lontana, spalancando così le porte all’attuale fase di meccanicistico materialismo. Quello dell’emanazionismo è il classico specchio per le allodole al quale, oggidì, cedono, in ispecial modo, tutte quelle forme di sapere che, nel contrapporsi allo scientismo materialista, aspirano alla conoscenza (ed al dominio, sic!) dell’essenza della realtà, attraverso un processo a tappe (iniziazione…) che deve coinvolgere tutte le forze spirituali di coloro che, a tali saperi si avvicinino. Stiamo parlando di tutte quelle tipologie di conoscenza che, ad oggi, possiamo definire “esoteriche” e che in Oriente trovano i propri riferimenti in ben definite e vitali tradizioni religiose, come nel caso del Tantra Yoga di ambito Hindu o del Buddhismo tibetano, solo per citare alcuni esempi. In ambito occidentale, di converso, il pensiero “esoterico” non fa riferimento ad una precisa e vitale tradizione religiosa, bensì a tutto quel fiume carsico di conoscenze, frutto delle elaborazioni e delle sintesi ellenistiche, rappresentato in primis da Gnosi ed Ermetismo, su cui si sono innestati i filoni dell’ idealismo magico e del vitalismo a partire dal 18° secolo.
Per un paradossale processo di eterogenesi dei fini, proprio laddove si voleva anelare allo spirito, si finisce con il vivere appieno l’immediatezza materiale, nell’ attesa di una catarsi spirituale sempre più eterea e lontana, spalancando così le porte all’attuale fase di meccanicistico materialismo. Quello dell’emanazionismo è il classico specchio per le allodole al quale, oggidì, cedono, in ispecial modo, tutte quelle forme di sapere che, nel contrapporsi allo scientismo materialista, aspirano alla conoscenza (ed al dominio, sic!) dell’essenza della realtà, attraverso un processo a tappe (iniziazione…) che deve coinvolgere tutte le forze spirituali di coloro che, a tali saperi si avvicinino. Stiamo parlando di tutte quelle tipologie di conoscenza che, ad oggi, possiamo definire “esoteriche” e che in Oriente trovano i propri riferimenti in ben definite e vitali tradizioni religiose, come nel caso del Tantra Yoga di ambito Hindu o del Buddhismo tibetano, solo per citare alcuni esempi. In ambito occidentale, di converso, il pensiero “esoterico” non fa riferimento ad una precisa e vitale tradizione religiosa, bensì a tutto quel fiume carsico di conoscenze, frutto delle elaborazioni e delle sintesi ellenistiche, rappresentato in primis da Gnosi ed Ermetismo, su cui si sono innestati i filoni dell’ idealismo magico e del vitalismo a partire dal 18° secolo.


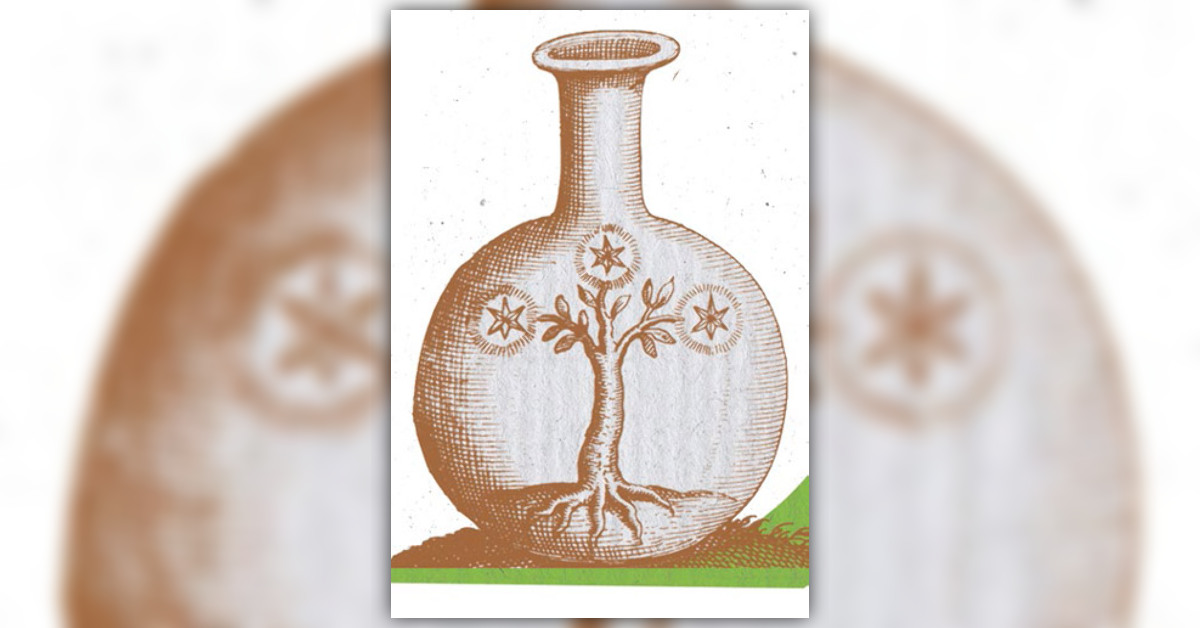
 Presso le culture sciamaniche primordiali, ad esempio, l’uso di super-medicine e di funghi allucinogeni era un privilegio riservato agli «dèi», cioè ai diretti discendenti della stirpe originaria. Lo stesso uomo-Adamo, prototipo dell’«escluso» dal beneficio, non fece in tempo ad allungare le mani sul prezioso frutto dell’Albero della Vita che subito venne cacciato dal Paradiso Terrestre. Una sorte toccata ad altri personaggi leggendari, segno che in un dato periodo le trasgressioni erano all’ordine del giorno. Tra questi vi fu Adapa, il figlio che Ea-Enki «aveva fatto mortale» a causa di un’unione ibrida. Il suo mito si trova in un testo del XIV secolo a.C. ritrovato ad El-Amarna, in Egitto. Vagamente nominato come «uno degli Dèi», il mezzosangue in realtà non era un «dio» ma un super-dotato fisico con un’intelligenza fuori del comune. Tante qualità non sottrassero comunque alla derisione degli appartenenti alla Prima Razza, che si divertirono a fargli passare sotto il naso la droga di lunga vita senza dargliene neppure una goccia.
Presso le culture sciamaniche primordiali, ad esempio, l’uso di super-medicine e di funghi allucinogeni era un privilegio riservato agli «dèi», cioè ai diretti discendenti della stirpe originaria. Lo stesso uomo-Adamo, prototipo dell’«escluso» dal beneficio, non fece in tempo ad allungare le mani sul prezioso frutto dell’Albero della Vita che subito venne cacciato dal Paradiso Terrestre. Una sorte toccata ad altri personaggi leggendari, segno che in un dato periodo le trasgressioni erano all’ordine del giorno. Tra questi vi fu Adapa, il figlio che Ea-Enki «aveva fatto mortale» a causa di un’unione ibrida. Il suo mito si trova in un testo del XIV secolo a.C. ritrovato ad El-Amarna, in Egitto. Vagamente nominato come «uno degli Dèi», il mezzosangue in realtà non era un «dio» ma un super-dotato fisico con un’intelligenza fuori del comune. Tante qualità non sottrassero comunque alla derisione degli appartenenti alla Prima Razza, che si divertirono a fargli passare sotto il naso la droga di lunga vita senza dargliene neppure una goccia. degli islandesi, uno dei popoli meno meticciati della Terra, è presente un gene (battezzato «Matusalemme») che incide in modo significativo sulla durata media della vita di un essere umano. Non si sa come, né perché. Secondo la scienza popolare mangiare mele aumenterebbe l'aspettativa di vita del 10%. Quella ufficiale sottolinea invece la presenza di un moscerino della frutta che va matto per le mele, la Drosophila melanogaster, il quale sarebbe il portatore di un gene capace di raddoppiare la durata della sua vita. Il discorso non vale ovviamente per le mele insapori e inodori del supermercato, che sembrano (o forse sono) fatte di plastica, ma riguarda le «mele antiche», originarie, che potrebbero avere avuto particolari proprietà in grado di produrre effetti benefici sugli organismi viventi che le ingerivano. Siamo in presenza di una rivisitazione dell’adagio popolare “una mela al giorno toglie il medico di torno”? D’altronde, se venisse fuori che gli Antichi erano al corrente di «dettagli scientifici» a noi ignoti bisognerebbe riscrivere la Storia, e nessuno sembra intenzionato a farlo. Assumerebbero un nuovo significato anche tanti racconti tradizionali, a partire da quello legato alla mela del peccato di Eva, che altrimenti sembra una favola per bambini, ma i nostri remoti antenati non avevano l’abitudine di raccontare favole ai bambini.
degli islandesi, uno dei popoli meno meticciati della Terra, è presente un gene (battezzato «Matusalemme») che incide in modo significativo sulla durata media della vita di un essere umano. Non si sa come, né perché. Secondo la scienza popolare mangiare mele aumenterebbe l'aspettativa di vita del 10%. Quella ufficiale sottolinea invece la presenza di un moscerino della frutta che va matto per le mele, la Drosophila melanogaster, il quale sarebbe il portatore di un gene capace di raddoppiare la durata della sua vita. Il discorso non vale ovviamente per le mele insapori e inodori del supermercato, che sembrano (o forse sono) fatte di plastica, ma riguarda le «mele antiche», originarie, che potrebbero avere avuto particolari proprietà in grado di produrre effetti benefici sugli organismi viventi che le ingerivano. Siamo in presenza di una rivisitazione dell’adagio popolare “una mela al giorno toglie il medico di torno”? D’altronde, se venisse fuori che gli Antichi erano al corrente di «dettagli scientifici» a noi ignoti bisognerebbe riscrivere la Storia, e nessuno sembra intenzionato a farlo. Assumerebbero un nuovo significato anche tanti racconti tradizionali, a partire da quello legato alla mela del peccato di Eva, che altrimenti sembra una favola per bambini, ma i nostri remoti antenati non avevano l’abitudine di raccontare favole ai bambini. Ci si sente «più umani», facendosi carico del proprio destino di mortali? E se la morte non fosse un dramma bensì una liberazione, come pensavano gli antichi più antichi? Su un punto tutte le tradizioni convergono: l’uomo non perse subito l’immortalità, da intendersi come estrema longevità, ma se la giocò strada facendo a causa di un temperamento instabile e allergico a qualsiasi tipo di regola. Non doveva mischiare il sangue della Prima Razza con quello di stirpi geneticamente inferiori, ma lo fece. Non doveva sperperare il patrimonio sapienziale ereditato dai Padri fondatori, ma lo disperse ai quattro venti. Non doveva allontanarsi dalla legge di corrispondenza che collega ogni cosa nell’Essenza universale, ma la dimenticò coscientemente con i risultati catastrofici che conosciamo. Il risultato fu l’insorgenza di una duplice realtà: da una parte «noi», la stirpe umana, dall’altra tutto quello che stava «al di fuori di noi», cioè il mondo. Sul cambio di prospettiva pesò una serie di fattori, il primo dei quali fu il graduale venir meno delle capacità percettive della specie. Facoltà basilari, visto che niente è in possesso di una vera e propria esistenza al di fuori della nostra percezione sensoriale animale. Neppure Spazio e Tempo, che sono modalità cognitive animali, possiedono realtà indipendenti, essendo semplici schemi interpretativi che appartengono alla logica mentale del nostro organismo animale, il quale può essere paragonato a un software che modella le percezioni in oggetti multidimensionali.
Ci si sente «più umani», facendosi carico del proprio destino di mortali? E se la morte non fosse un dramma bensì una liberazione, come pensavano gli antichi più antichi? Su un punto tutte le tradizioni convergono: l’uomo non perse subito l’immortalità, da intendersi come estrema longevità, ma se la giocò strada facendo a causa di un temperamento instabile e allergico a qualsiasi tipo di regola. Non doveva mischiare il sangue della Prima Razza con quello di stirpi geneticamente inferiori, ma lo fece. Non doveva sperperare il patrimonio sapienziale ereditato dai Padri fondatori, ma lo disperse ai quattro venti. Non doveva allontanarsi dalla legge di corrispondenza che collega ogni cosa nell’Essenza universale, ma la dimenticò coscientemente con i risultati catastrofici che conosciamo. Il risultato fu l’insorgenza di una duplice realtà: da una parte «noi», la stirpe umana, dall’altra tutto quello che stava «al di fuori di noi», cioè il mondo. Sul cambio di prospettiva pesò una serie di fattori, il primo dei quali fu il graduale venir meno delle capacità percettive della specie. Facoltà basilari, visto che niente è in possesso di una vera e propria esistenza al di fuori della nostra percezione sensoriale animale. Neppure Spazio e Tempo, che sono modalità cognitive animali, possiedono realtà indipendenti, essendo semplici schemi interpretativi che appartengono alla logica mentale del nostro organismo animale, il quale può essere paragonato a un software che modella le percezioni in oggetti multidimensionali.
 Tali elementi sono passati attraverso un lungo processo di elaborazione mitica, connesso ai presupposti della forte ereditarietà totemica. Se il millenario vassallaggio ieri si è sviluppato grazie al predominante antropocentrismo, giustificato dalla volontà di predazione e da ragioni di sopravvivenza, oggi lo spettro del crescente impoverimento della diversità biologica porta alla ribalta tardivi ravvedimenti, timori favoriti dalla logica del destino comune. Tra le due categorie viventi, la teorizzata comune provenienza originaria ha permesso il sussistere di atteggiamenti solidali, fondati su relazioni non esclusivamente strumentali e utilitaristiche bensì suscitati da spontanei sentimenti affettivi. Come è noto l’essere umano ha da sempre esercitato, anche nei confronti dei suoi simili, comportamenti ambivalenti, improntati alla prepotenza, alla riduzione in schiavitù ma anche all’amore. Conseguentemente numerosi casi attestano che il passaggio all’addomesticamento animale abbia visto il sorgere di una spontanea alleanza, il nascere di una affezione reciproca non disgiunta dal sacrificio. Gli esempi sono disparati: il pastore e il suo cane, il cacciatore e il segugio, il nobile e il falcone, il mandriano e gli armenti, il mulo e il montanaro, la massaia e il pollame e così via. Specialmente oggi per combattere la solitudine esistenziale viene consigliata la terapeutica compagnia di amici-animali. Assistiamo giornalmente al propagarsi di nuove iniziative promosse da un associazionismo animalista che combatte con determinazione e reclama, anche in piazza, trattamenti meno crudeli e comprensivi da riservare a questi compagni di viaggio. Infatti qua e là permangono ancora forti sacche di resistenza favorite, più che da larvate forme di razzismo biologico, da un mai sopito prometeico egoismo e da un edonismo economico, non più giustificabili dall’ormai acquisito incontrastato predominio antropico esteso a tutto il pianeta. La malvagità gratuita dell’uomo non trova più attenuanti nella necessità biologica ma nei precedenti biblici, derivati dall’aggressività di Caino. Sebbene ogni comportamento di prepotenza gratuita verso il mondo animale vada condannato occorre altresì considerare che comprensione non significa equiparazione. La matrice comune che ha portato alla coabitazione non pregiudica il fatto che la natura e le esigenze prospettiche siano diverse. Alla stessa stregua non si ravvisa odio nel leone che sbrana la sua preda. Un tempo esistevano strette connessioni tra divinità e animale soggetto all’arte venatoria. Nelle società tradizionali (7), dal paleolitico fino quasi alla contemporaneità, il cacciatore non uccideva per piacere ma per difesa, per sfamarsi e in modo non superiore alle proprie necessità (8). In questo serbava coscienza d’aver compiuto un atto di bisogno al tempo stesso trasgressivo (9). Il sacrificio serviva a consolidare il rapporto con la divinità per l’animalicidio (10). Da qui la consuetudine di offrire agli Esseri Supremi un pezzo di ogni animale ucciso in quanto ...i sacrifici cruenti, praticati sia dai coltivatori sia dai pastori, ripetono in fin dei conti l’uccisione della selvaggina da parte dei cacciatori (11). La finalità era quella di attutire il senso di colpa, potersi riconciliare con lo spirito della preda e riequilibrare la stabilità dell’ordine naturale che era stato infranto.
Tali elementi sono passati attraverso un lungo processo di elaborazione mitica, connesso ai presupposti della forte ereditarietà totemica. Se il millenario vassallaggio ieri si è sviluppato grazie al predominante antropocentrismo, giustificato dalla volontà di predazione e da ragioni di sopravvivenza, oggi lo spettro del crescente impoverimento della diversità biologica porta alla ribalta tardivi ravvedimenti, timori favoriti dalla logica del destino comune. Tra le due categorie viventi, la teorizzata comune provenienza originaria ha permesso il sussistere di atteggiamenti solidali, fondati su relazioni non esclusivamente strumentali e utilitaristiche bensì suscitati da spontanei sentimenti affettivi. Come è noto l’essere umano ha da sempre esercitato, anche nei confronti dei suoi simili, comportamenti ambivalenti, improntati alla prepotenza, alla riduzione in schiavitù ma anche all’amore. Conseguentemente numerosi casi attestano che il passaggio all’addomesticamento animale abbia visto il sorgere di una spontanea alleanza, il nascere di una affezione reciproca non disgiunta dal sacrificio. Gli esempi sono disparati: il pastore e il suo cane, il cacciatore e il segugio, il nobile e il falcone, il mandriano e gli armenti, il mulo e il montanaro, la massaia e il pollame e così via. Specialmente oggi per combattere la solitudine esistenziale viene consigliata la terapeutica compagnia di amici-animali. Assistiamo giornalmente al propagarsi di nuove iniziative promosse da un associazionismo animalista che combatte con determinazione e reclama, anche in piazza, trattamenti meno crudeli e comprensivi da riservare a questi compagni di viaggio. Infatti qua e là permangono ancora forti sacche di resistenza favorite, più che da larvate forme di razzismo biologico, da un mai sopito prometeico egoismo e da un edonismo economico, non più giustificabili dall’ormai acquisito incontrastato predominio antropico esteso a tutto il pianeta. La malvagità gratuita dell’uomo non trova più attenuanti nella necessità biologica ma nei precedenti biblici, derivati dall’aggressività di Caino. Sebbene ogni comportamento di prepotenza gratuita verso il mondo animale vada condannato occorre altresì considerare che comprensione non significa equiparazione. La matrice comune che ha portato alla coabitazione non pregiudica il fatto che la natura e le esigenze prospettiche siano diverse. Alla stessa stregua non si ravvisa odio nel leone che sbrana la sua preda. Un tempo esistevano strette connessioni tra divinità e animale soggetto all’arte venatoria. Nelle società tradizionali (7), dal paleolitico fino quasi alla contemporaneità, il cacciatore non uccideva per piacere ma per difesa, per sfamarsi e in modo non superiore alle proprie necessità (8). In questo serbava coscienza d’aver compiuto un atto di bisogno al tempo stesso trasgressivo (9). Il sacrificio serviva a consolidare il rapporto con la divinità per l’animalicidio (10). Da qui la consuetudine di offrire agli Esseri Supremi un pezzo di ogni animale ucciso in quanto ...i sacrifici cruenti, praticati sia dai coltivatori sia dai pastori, ripetono in fin dei conti l’uccisione della selvaggina da parte dei cacciatori (11). La finalità era quella di attutire il senso di colpa, potersi riconciliare con lo spirito della preda e riequilibrare la stabilità dell’ordine naturale che era stato infranto. Prima ancora che i pedigree costituissero una regolare consuetudine il colono e la casalinga chiamavano per nome o con un vezzeggiativo ogni capo posseduto. A questi riservavano la precedenza e le solerti attenzioni riguardanti l’accudimento e l’alimentazione. Solo secondariamente venivano esaudite le esigenze parentali e quelle personali. A tali comportamenti non seguivano contrapposizioni nel considerare il sereno rapporto di convivenza con compagni con cui si divideva la quotidianità. Una esistenza ricca di gioie, speranze ma anche e soprattutto di privazioni e fatiche. Dal benessere di questi collaboratori dipendeva la sopravvivenza stessa dell’uomo e della famiglia. La salute dell’animale (da traino, da latte, da guerra) spesso era connessa con la vita dell’ambulante, del contadino, del cavaliere e conseguentemente la salute dell’intero gruppo familiare. La responsabilizzazione rendeva il padrone un alleato. Era invalso l’uso secondo cui la provvida regiùra (padrona di casa) chiamava con nomi di fantasia ogni gallina del pollaio. Allo stesso modo il mungitore e il cavallante battezzavano con famigliarità mucche e cavalli per i quali nutrivano sincero affetto. Questo sentimento era ben documentato negli ex-voto dei santuari locali (Pallavicina, Marzale, Misericordia, S. Maria della Croce, Ariadello, Caravaggio). Ancora intorno agli anni ’60 le pareti di questi templi periferici erano tappezzate dai quadretti votivi. La loro presenza testimoniava l’indiscussa bontà del santo patrono. Al soccorso celeste si ricorreva in casi estremi, quando le cure empiriche non sortivano più gli effetti sperati nella salvaguardia delle greggi e dei branchi decimati dal malrossino, dall’afta epizootica, dalla tubercolosi o da altre intossicazioni. Le gallerie delle pitture votive degli ex-voto costituiscono exempla alquanto emblematici. I mandriani sono raffigurati prostrati dal dolore, inginocchiati insieme ai loro armenti, anch’essi genuflessi nell’atto di sollecitare il provvido intervento divino. Manufatti semplici ma eloquenti, spie altamente significative e commoventi di atteggiamenti consuetudinari. Il numero di questi quadretti in cui sono rappresentati soggetti animali era rilevante. In base ad una indagine condotta dal Gruppo Antropologico Cremasco (21) costituivano un quarto dell’intera campionatura.
Prima ancora che i pedigree costituissero una regolare consuetudine il colono e la casalinga chiamavano per nome o con un vezzeggiativo ogni capo posseduto. A questi riservavano la precedenza e le solerti attenzioni riguardanti l’accudimento e l’alimentazione. Solo secondariamente venivano esaudite le esigenze parentali e quelle personali. A tali comportamenti non seguivano contrapposizioni nel considerare il sereno rapporto di convivenza con compagni con cui si divideva la quotidianità. Una esistenza ricca di gioie, speranze ma anche e soprattutto di privazioni e fatiche. Dal benessere di questi collaboratori dipendeva la sopravvivenza stessa dell’uomo e della famiglia. La salute dell’animale (da traino, da latte, da guerra) spesso era connessa con la vita dell’ambulante, del contadino, del cavaliere e conseguentemente la salute dell’intero gruppo familiare. La responsabilizzazione rendeva il padrone un alleato. Era invalso l’uso secondo cui la provvida regiùra (padrona di casa) chiamava con nomi di fantasia ogni gallina del pollaio. Allo stesso modo il mungitore e il cavallante battezzavano con famigliarità mucche e cavalli per i quali nutrivano sincero affetto. Questo sentimento era ben documentato negli ex-voto dei santuari locali (Pallavicina, Marzale, Misericordia, S. Maria della Croce, Ariadello, Caravaggio). Ancora intorno agli anni ’60 le pareti di questi templi periferici erano tappezzate dai quadretti votivi. La loro presenza testimoniava l’indiscussa bontà del santo patrono. Al soccorso celeste si ricorreva in casi estremi, quando le cure empiriche non sortivano più gli effetti sperati nella salvaguardia delle greggi e dei branchi decimati dal malrossino, dall’afta epizootica, dalla tubercolosi o da altre intossicazioni. Le gallerie delle pitture votive degli ex-voto costituiscono exempla alquanto emblematici. I mandriani sono raffigurati prostrati dal dolore, inginocchiati insieme ai loro armenti, anch’essi genuflessi nell’atto di sollecitare il provvido intervento divino. Manufatti semplici ma eloquenti, spie altamente significative e commoventi di atteggiamenti consuetudinari. Il numero di questi quadretti in cui sono rappresentati soggetti animali era rilevante. In base ad una indagine condotta dal Gruppo Antropologico Cremasco (21) costituivano un quarto dell’intera campionatura.


 Con molta cura ed originalità, il testo narra e descrive a getto continuo ed in gran profusione, tutta una serie di miti ellenici ai quali, di volta in volta, conferisce degli spunti interpretativi, non senza intervallare il ritmo narrativo, immettendo qua e là, taluni spunti di riflessione “laica”, basati su vicende o aspetti della società greco-classica (come nel caso della pratica dell’omosessualità…) che,forse contrariamente alle intenzioni dell’autore, non scalfiscono minimamente quella che dell’intera narrazione mitica, rappresenta l’asse portante: e cioè la sua vocazione, integralmente archetipica e simbolica. Si inizia con la narrazione del mito del ratto di Europa, sul dorso di Zeus trasformatosi per l’occasione in un bianco toro, e via via, si procede a snocciolare le innumerevoli versione con altrettanto innumerevoli finali. Si passa poi, in crescendo alla figura di Arianna, vergine ed amante dell’eroe Teseo e di Dioniso, e delle altrettante sue versioni. Suicida per amore, a seguito dell’abbandono di Teseo o uccisa da Dioniso, dopo esser divenuta la sua amante, o intrepida combattente e baccante accanto al dio dell’ebbrezza. In un continuo crescere, il mito greco si rivela ai nostri occhi, in un’infinità di figure e di concatenarsi di eventi, tutti egualmente animati da una logica simbolica, ben lontana, pertanto, da certe interpretazioni evoluzioniste che vedono nel politeismo antico, una forma di involuta e pertanto, immatura religiosità.
Con molta cura ed originalità, il testo narra e descrive a getto continuo ed in gran profusione, tutta una serie di miti ellenici ai quali, di volta in volta, conferisce degli spunti interpretativi, non senza intervallare il ritmo narrativo, immettendo qua e là, taluni spunti di riflessione “laica”, basati su vicende o aspetti della società greco-classica (come nel caso della pratica dell’omosessualità…) che,forse contrariamente alle intenzioni dell’autore, non scalfiscono minimamente quella che dell’intera narrazione mitica, rappresenta l’asse portante: e cioè la sua vocazione, integralmente archetipica e simbolica. Si inizia con la narrazione del mito del ratto di Europa, sul dorso di Zeus trasformatosi per l’occasione in un bianco toro, e via via, si procede a snocciolare le innumerevoli versione con altrettanto innumerevoli finali. Si passa poi, in crescendo alla figura di Arianna, vergine ed amante dell’eroe Teseo e di Dioniso, e delle altrettante sue versioni. Suicida per amore, a seguito dell’abbandono di Teseo o uccisa da Dioniso, dopo esser divenuta la sua amante, o intrepida combattente e baccante accanto al dio dell’ebbrezza. In un continuo crescere, il mito greco si rivela ai nostri occhi, in un’infinità di figure e di concatenarsi di eventi, tutti egualmente animati da una logica simbolica, ben lontana, pertanto, da certe interpretazioni evoluzioniste che vedono nel politeismo antico, una forma di involuta e pertanto, immatura religiosità. L’elemento femminile, a sua volta, in quanto generatore di nuova vita, ha la funzione di sopprimere qualunque elemento sovrasti l’armonia rappresentata dal limes cosmico. E così, alla strabordante e sovrumana fisicità di Eracle, verrà posto un termine da Deianira. Lo stesso uccider mostri, è un riportar ordine ad un turbamento, che riguarda sia l’ordine microcosmico, afferente all’animo umano, che quello esterno, macrocosmico. Ben lontano, dunque, da una ingenua ed involuta interpretazione della realtà, il mito si fa atemporale e simbolica descrizione di essa, in virtù del fatto che le strutture di pensiero degli antichi erano peculiarmente differenti dalle attuali nostre. Secoli di razionalismo e di empirismo, ci hanno portato a ragionare per unilineari e consequenziali “griglie” di pensiero, che ci rivelano ogni aspetto della realtà, nella sua singolarità e non in rapporto con il Tutto.
L’elemento femminile, a sua volta, in quanto generatore di nuova vita, ha la funzione di sopprimere qualunque elemento sovrasti l’armonia rappresentata dal limes cosmico. E così, alla strabordante e sovrumana fisicità di Eracle, verrà posto un termine da Deianira. Lo stesso uccider mostri, è un riportar ordine ad un turbamento, che riguarda sia l’ordine microcosmico, afferente all’animo umano, che quello esterno, macrocosmico. Ben lontano, dunque, da una ingenua ed involuta interpretazione della realtà, il mito si fa atemporale e simbolica descrizione di essa, in virtù del fatto che le strutture di pensiero degli antichi erano peculiarmente differenti dalle attuali nostre. Secoli di razionalismo e di empirismo, ci hanno portato a ragionare per unilineari e consequenziali “griglie” di pensiero, che ci rivelano ogni aspetto della realtà, nella sua singolarità e non in rapporto con il Tutto.
 I loro maneggi per rimanere a galla toccano vette d’ilarità mai raggiunte in precedenza. Idem dicasi per la «realtà dominante», che per apparire più reale delle altre deve continuamente difendersi dagli attacchi degli oppositori, e nel fare ciò è talmente ridicola che è impossibile non sorridere davanti al susseguirsi incessante delle sue azioni maldestre. Come non pensare ai tempi remoti in cui l’uomo era disposto a «dare un occhio, o un braccio» per chi lo guidava. Nel caso in cui fosse in gioco l’incolumità e la sopravvivenza del gruppo, anche tutti e due. L’accoppiata «orbo-monco», infatti, è un classico della narrativa mitologica e tradizionale eurasiatica. Messe insieme queste figure simboleggiano le prime due funzioni sovrane della cultura indoeuropea, ovvero quella magico-giuridica (l’occhio) e quella guerriera (il braccio), nonché tutte le forme di sacrificio rituale ad esse connesse. Il monocolo più famoso d’Europa è senza dubbio il nordico Odino, ritenuto dai suoi contemporanei «colui che conosce più cose al mondo». Secondo i bardi che ne cantavano la gloria, il sovrano sapeva recitare melodie che rendevano malleabili le rocce, spostavano le pietre, calmavano le acque, aprivano i tumuli e abbindolavano i nemici in battaglia «legandoli con un laccio invisibile». Esclusa l’origine aliena del re degli Æsir, rimane percorribile solo la strada dell’iniziato, cioè del «conoscitore di tutte le cose del Primo Tempo». Inclusa la famigerata scienza sonica appartenuta ai primi dèi-civilizzatori, i quali sollevavano in aria pietre che mille uomini non sarebbero riusciti a spostare attraverso giochi di onde sonore a noi sconosciuti. Si vedano certe pratiche riconducibili ai sacerdoti Bön-po, o a quelli di On. Da vero campione di un’umanità nuova, solare e bellicosa, riunita sotto il sigillo dell’utopia e rigenerata attraverso la scienza, Odino esordì sul palcoscenico della Storia con uno «smembramento rituale», quello del gigante primigenio Ymir, la cui carcassa servì a ri-forgiare Cielo e Terra. Un gesto pregno di suggestioni sciamaniche. Ma i tempi erano molto cambiati da quando Purusha si era «diviso» in due per «liberare» i contrari necessari a dare una fisionomia all’universo. Senza contare che il grande re, in qualità di essere non-presente all’origine della Creazione, non era neppure un uomo cosmico. Per questo motivo dovette sacrificare se stesso per ottenere le rune.
I loro maneggi per rimanere a galla toccano vette d’ilarità mai raggiunte in precedenza. Idem dicasi per la «realtà dominante», che per apparire più reale delle altre deve continuamente difendersi dagli attacchi degli oppositori, e nel fare ciò è talmente ridicola che è impossibile non sorridere davanti al susseguirsi incessante delle sue azioni maldestre. Come non pensare ai tempi remoti in cui l’uomo era disposto a «dare un occhio, o un braccio» per chi lo guidava. Nel caso in cui fosse in gioco l’incolumità e la sopravvivenza del gruppo, anche tutti e due. L’accoppiata «orbo-monco», infatti, è un classico della narrativa mitologica e tradizionale eurasiatica. Messe insieme queste figure simboleggiano le prime due funzioni sovrane della cultura indoeuropea, ovvero quella magico-giuridica (l’occhio) e quella guerriera (il braccio), nonché tutte le forme di sacrificio rituale ad esse connesse. Il monocolo più famoso d’Europa è senza dubbio il nordico Odino, ritenuto dai suoi contemporanei «colui che conosce più cose al mondo». Secondo i bardi che ne cantavano la gloria, il sovrano sapeva recitare melodie che rendevano malleabili le rocce, spostavano le pietre, calmavano le acque, aprivano i tumuli e abbindolavano i nemici in battaglia «legandoli con un laccio invisibile». Esclusa l’origine aliena del re degli Æsir, rimane percorribile solo la strada dell’iniziato, cioè del «conoscitore di tutte le cose del Primo Tempo». Inclusa la famigerata scienza sonica appartenuta ai primi dèi-civilizzatori, i quali sollevavano in aria pietre che mille uomini non sarebbero riusciti a spostare attraverso giochi di onde sonore a noi sconosciuti. Si vedano certe pratiche riconducibili ai sacerdoti Bön-po, o a quelli di On. Da vero campione di un’umanità nuova, solare e bellicosa, riunita sotto il sigillo dell’utopia e rigenerata attraverso la scienza, Odino esordì sul palcoscenico della Storia con uno «smembramento rituale», quello del gigante primigenio Ymir, la cui carcassa servì a ri-forgiare Cielo e Terra. Un gesto pregno di suggestioni sciamaniche. Ma i tempi erano molto cambiati da quando Purusha si era «diviso» in due per «liberare» i contrari necessari a dare una fisionomia all’universo. Senza contare che il grande re, in qualità di essere non-presente all’origine della Creazione, non era neppure un uomo cosmico. Per questo motivo dovette sacrificare se stesso per ottenere le rune. Il celebrante saliva quindi sulla catasta di fascine e irrorava la sua spada con il sangue della vittima. Quando invece le sorti della battaglia volgevano al peggio, si cercava di tagliare il braccio destro con la spalla al re o al campione che guidava l’esercito nemico. L’arto veniva lanciato in aria e poi lasciato cadere a terra tra urla di disprezzo e grida oscene. Un’azione rituale in piena regola. Incappò in un simile incidente persino il leggendario re Nuada mac Echtain. Ucciderlo sarebbe stato controproducente perché i bardi lo avrebbero glorificato, tramandando il poema delle sue gesta per chissà quante generazioni. Mentre sfregiarlo un attimo prima del trionfo equivaleva ad umiliare con un ultimo atto d’orgoglio sia il campione che la sua stirpe, dando un gusto amaro alla vittoria. Ma in questo caso gli aborigeni Fir Bólg non avevano fatto i conti con le conoscenze sciamaniche degli invasori Túatha, i cui medici e fabbri di corte si lanciarono subito in un delicato intervento chirurgico. Il guerriero ne uscì con un braccio d'argento con tanto di mano e dita mobili, ma il regno non era più nelle sue mani. A quei tempi era inconcepibile avere un invalido sul trono. Nel mondo indoeuropeo il principio della sovranità temporale era percepito come il prolungamento di un’autorità famigliare perfettamente integra. In qualità di «padre del suo popolo», il re doveva godere di una buona salute mentale e fisica per esercitare la potestà genitoriale. Il concetto di «diversamente abile» non era ancora nato, per cui perdere una mano in battaglia, o tagliando la legna nel fienile, costituiva un motivo più che valido per lasciare lo scettro del comando e tornare a fare l’allevatore di capre. Nessun re doveva essere inoltre troppo vecchio per reggere il peso di una spada. La vecchiaia nell’Età del Metallo era una iattura da cui rifuggire, non solo per chi l’attraversava ma per l’intera comunità. I gruppi umani erano spesso in movimento e perennemente in guerra, avevano bisogno di uomini e di donne fisicamente efficienti che combattessero, lavorassero e si riproducessero con facilità. Nel gruppo quando un soggetto maschio toccava i sessant’anni di età (eventualità assai rara in tempi in cui la morte in battaglia giungeva sempre prematura), pensava lui a togliersi di mezzo, senza aspettare che i suoi figli lo facessero al posto suo. Tra le morti più onorevoli vi erano il salto rituale giù da una montagna o l’ultimo tuffo nel mare dall’alto di una roccia.
Il celebrante saliva quindi sulla catasta di fascine e irrorava la sua spada con il sangue della vittima. Quando invece le sorti della battaglia volgevano al peggio, si cercava di tagliare il braccio destro con la spalla al re o al campione che guidava l’esercito nemico. L’arto veniva lanciato in aria e poi lasciato cadere a terra tra urla di disprezzo e grida oscene. Un’azione rituale in piena regola. Incappò in un simile incidente persino il leggendario re Nuada mac Echtain. Ucciderlo sarebbe stato controproducente perché i bardi lo avrebbero glorificato, tramandando il poema delle sue gesta per chissà quante generazioni. Mentre sfregiarlo un attimo prima del trionfo equivaleva ad umiliare con un ultimo atto d’orgoglio sia il campione che la sua stirpe, dando un gusto amaro alla vittoria. Ma in questo caso gli aborigeni Fir Bólg non avevano fatto i conti con le conoscenze sciamaniche degli invasori Túatha, i cui medici e fabbri di corte si lanciarono subito in un delicato intervento chirurgico. Il guerriero ne uscì con un braccio d'argento con tanto di mano e dita mobili, ma il regno non era più nelle sue mani. A quei tempi era inconcepibile avere un invalido sul trono. Nel mondo indoeuropeo il principio della sovranità temporale era percepito come il prolungamento di un’autorità famigliare perfettamente integra. In qualità di «padre del suo popolo», il re doveva godere di una buona salute mentale e fisica per esercitare la potestà genitoriale. Il concetto di «diversamente abile» non era ancora nato, per cui perdere una mano in battaglia, o tagliando la legna nel fienile, costituiva un motivo più che valido per lasciare lo scettro del comando e tornare a fare l’allevatore di capre. Nessun re doveva essere inoltre troppo vecchio per reggere il peso di una spada. La vecchiaia nell’Età del Metallo era una iattura da cui rifuggire, non solo per chi l’attraversava ma per l’intera comunità. I gruppi umani erano spesso in movimento e perennemente in guerra, avevano bisogno di uomini e di donne fisicamente efficienti che combattessero, lavorassero e si riproducessero con facilità. Nel gruppo quando un soggetto maschio toccava i sessant’anni di età (eventualità assai rara in tempi in cui la morte in battaglia giungeva sempre prematura), pensava lui a togliersi di mezzo, senza aspettare che i suoi figli lo facessero al posto suo. Tra le morti più onorevoli vi erano il salto rituale giù da una montagna o l’ultimo tuffo nel mare dall’alto di una roccia. Avvenuta, guarda caso, proprio in concomitanza con la battaglia di Mag Tuired (in lingua gaelica, Cath Maige Tuired) con cui i Túatha conquistarono Ériu. Per i guerrieri nordici di stirpe reale vincere una sfida a fidchell era una specie di obbligo di Stato, in quanto l’intelligenza era considerata emanazione della regalità. Ma anche i re d’Oriente erano soliti scambiarsi gli enigmi tra di loro come se fossero dei doni preziosi. Complicati rompicapo venivano proposti inoltre ai pretendenti di una sposa reale poiché il matrimonio dipendeva dalle capacità intellettive del giovanotto. Gli stessi oracoli si esprimevano in modo enigmatico, e sarebbe un vero spasso poter osservare oggi senza essere veduti la faccia di un campione dell’antichità davanti ai discorsi sconclusionati della politica. Lúg vinse la partita, insinuando nella mente di Núada il pensiero che forse quel giovane brillante e lontanamente imparentato con i Fomóraig avrebbe potuto aiutarlo a sbarazzarsi per sempre dei molesti vicini. Fu riunito il Gran Consiglio nella Sala dei Banchetti della fortezza di Temáir, e dopo un acceso confronto si giunse alla decisione di cedere la regalità a Lúg a tempo determinato (tredici giorni) allo scopo di risolvere il problema. Il giorno di Samhain (il 1°novembre, quando cominciava la metà «oscura» dell’anno) gli eserciti dei Túatha e dei Fomóraig si schierarono uno contro l’altro nella piana di Mag Tuired, dove trent'anni prima i Túatha avevano sconfitto i Fir Bólg. Purtroppo Núada morì nel corso di un combattimento con Balor (re dei Fomóraig e nonno di Lúg), il quale morì a sua volta per mano del nipote che, ignaro dell’identità del reale antenato, gli fece saltare la testa con un tathlum, una palla che i guerrieri ottenevano cementando il cervello dei nemici uccisi. La vittoria non servì purtroppo a fermare il declino dei Túatha, ormai bene avviati sul viale del tramonto, che finirono per dissolversi nel rimescolamento delle stirpi di quei giorni bellicosi e raminghi. Nonostante qualche bene informato sostenga ancora oggi che i loro discendenti continuino a giocare a fidchell in un misterioso regno sotterraneo. Ma questa è un’altra storia.
Avvenuta, guarda caso, proprio in concomitanza con la battaglia di Mag Tuired (in lingua gaelica, Cath Maige Tuired) con cui i Túatha conquistarono Ériu. Per i guerrieri nordici di stirpe reale vincere una sfida a fidchell era una specie di obbligo di Stato, in quanto l’intelligenza era considerata emanazione della regalità. Ma anche i re d’Oriente erano soliti scambiarsi gli enigmi tra di loro come se fossero dei doni preziosi. Complicati rompicapo venivano proposti inoltre ai pretendenti di una sposa reale poiché il matrimonio dipendeva dalle capacità intellettive del giovanotto. Gli stessi oracoli si esprimevano in modo enigmatico, e sarebbe un vero spasso poter osservare oggi senza essere veduti la faccia di un campione dell’antichità davanti ai discorsi sconclusionati della politica. Lúg vinse la partita, insinuando nella mente di Núada il pensiero che forse quel giovane brillante e lontanamente imparentato con i Fomóraig avrebbe potuto aiutarlo a sbarazzarsi per sempre dei molesti vicini. Fu riunito il Gran Consiglio nella Sala dei Banchetti della fortezza di Temáir, e dopo un acceso confronto si giunse alla decisione di cedere la regalità a Lúg a tempo determinato (tredici giorni) allo scopo di risolvere il problema. Il giorno di Samhain (il 1°novembre, quando cominciava la metà «oscura» dell’anno) gli eserciti dei Túatha e dei Fomóraig si schierarono uno contro l’altro nella piana di Mag Tuired, dove trent'anni prima i Túatha avevano sconfitto i Fir Bólg. Purtroppo Núada morì nel corso di un combattimento con Balor (re dei Fomóraig e nonno di Lúg), il quale morì a sua volta per mano del nipote che, ignaro dell’identità del reale antenato, gli fece saltare la testa con un tathlum, una palla che i guerrieri ottenevano cementando il cervello dei nemici uccisi. La vittoria non servì purtroppo a fermare il declino dei Túatha, ormai bene avviati sul viale del tramonto, che finirono per dissolversi nel rimescolamento delle stirpi di quei giorni bellicosi e raminghi. Nonostante qualche bene informato sostenga ancora oggi che i loro discendenti continuino a giocare a fidchell in un misterioso regno sotterraneo. Ma questa è un’altra storia.
 Il linguaggio simbolico è universale e rivela sotto forma di immagini o ideogrammiqualità e proprietà invisibili di oggetti concretamente visibili. Dal culto dell’animale di potere all’animale totemico, la presenza del simbolismo animale ha caratterizzato i rituali religiosi, le pratiche magiche, l’insieme dei miti dell’intero bagaglio culturale di ogni società. Gli esseri umani hanno utilizzato le altre forme di vita come mezzo per comprendere se stessi e le leggi che regolano la vita in natura. Ancora oggi tendiamo inconsciamente a paragonarci alle altre creature. Basti pensare a quante espressioni gergali come “essere furbo come una volpe, coraggioso come un leone, veloce come un giaguaro”, siano mutuate dal comportamento animale. L’uomo associa da sempre agli animali un'idea, un valore o delle qualità particolari. I greci, gli etruschi e i romani attraverso l’ornitomanzia (la lettura del comportamento degli uccelli) interpretavano gli auspici, il buono o il cattivo presagio di un raccolto o di una battaglia. L’ornitomanzia si basava sul principio di interdipendenza tra l’Uno e il molteplice, tra macrocosmo e microcosmo. Le pratiche divinatorie non erano da considerarsi soggette al principio di causa-effetto;non erano gli uccelli a influenzare gli eventi in sé per sé. Gli uccelli avevano determinati comportamenti in quanto riflettevano nel mondo sensibile ciò che avveniva sul piano cosmico e soprasensibile.
Il linguaggio simbolico è universale e rivela sotto forma di immagini o ideogrammiqualità e proprietà invisibili di oggetti concretamente visibili. Dal culto dell’animale di potere all’animale totemico, la presenza del simbolismo animale ha caratterizzato i rituali religiosi, le pratiche magiche, l’insieme dei miti dell’intero bagaglio culturale di ogni società. Gli esseri umani hanno utilizzato le altre forme di vita come mezzo per comprendere se stessi e le leggi che regolano la vita in natura. Ancora oggi tendiamo inconsciamente a paragonarci alle altre creature. Basti pensare a quante espressioni gergali come “essere furbo come una volpe, coraggioso come un leone, veloce come un giaguaro”, siano mutuate dal comportamento animale. L’uomo associa da sempre agli animali un'idea, un valore o delle qualità particolari. I greci, gli etruschi e i romani attraverso l’ornitomanzia (la lettura del comportamento degli uccelli) interpretavano gli auspici, il buono o il cattivo presagio di un raccolto o di una battaglia. L’ornitomanzia si basava sul principio di interdipendenza tra l’Uno e il molteplice, tra macrocosmo e microcosmo. Le pratiche divinatorie non erano da considerarsi soggette al principio di causa-effetto;non erano gli uccelli a influenzare gli eventi in sé per sé. Gli uccelli avevano determinati comportamenti in quanto riflettevano nel mondo sensibile ciò che avveniva sul piano cosmico e soprasensibile. Per questo motivo, il corvo fu un animale particolarmente rispettato e venerato tanto da venire disegnato sulle bandiere di guerra e inciso sugli scudi. Nel Ragnarok, (tramonto degli Dei) prima della battaglia finale compaiono anche altri due lupi,Skoll e Hati che divoreranno Sol e Mati, (il sole e la luna) dopo averli inseguiti fin dalle origini del mondo, facendo precipitare la terra in una tenebra eterna. La guerra tra le potenze celesti e le forze oscure sarà annunciata da tre galli. Uno avviserà i giganti nello Jotunheim, un altro i morti del regno di Hel, e il gallo Víðópnir, dalla cima di Yggdrasil, avvertirà gli Dèi. Il grande albero, che contiene nei suoi rami e nelle sue radici i Nove Mondi, tremerà scuotendo l’universo con terribili terremoti che squarceranno la Terra distruggendo intere montagne. Il Dio Loki e suo figlio Fenrir, il grande lupo, si libereranno dopo una lunga prigionia e vagheranno per il mondo seminando morte e distruzione. Anche il serpente del mondo, figlio di Loki, finora confinato nelle profondità oceaniche, riemergerà dalle acque, provocando maremoti e alluvioni. Nella storia Norrena la relazione uomo-animale è particolarmente importante. Basti pensare al ruolo che hanno avuto i guerrieri Berseker e Ulfheðnar. Questa casta di sciamani-guerrieri la cui vita era completamente consacrata a Odino non portava armature, ma pellicce di orso (berseker) e di lupo (ulfheðnar.)Armati con spade e asce scatenavano la loro furia senza seguire nessuna strategia militare. Attraverso rituali che compivano prima di una battaglia, venivano pervasi da una furia sovrumana poiché ritenevano fosse lo stesso spirito di Odino a scendere dentro di loro per renderli forti come orsi o lupi. Furono proprio le storie sugli ulfheðnara contribuire alla diffusione delle leggende sui lupi mannari.
Per questo motivo, il corvo fu un animale particolarmente rispettato e venerato tanto da venire disegnato sulle bandiere di guerra e inciso sugli scudi. Nel Ragnarok, (tramonto degli Dei) prima della battaglia finale compaiono anche altri due lupi,Skoll e Hati che divoreranno Sol e Mati, (il sole e la luna) dopo averli inseguiti fin dalle origini del mondo, facendo precipitare la terra in una tenebra eterna. La guerra tra le potenze celesti e le forze oscure sarà annunciata da tre galli. Uno avviserà i giganti nello Jotunheim, un altro i morti del regno di Hel, e il gallo Víðópnir, dalla cima di Yggdrasil, avvertirà gli Dèi. Il grande albero, che contiene nei suoi rami e nelle sue radici i Nove Mondi, tremerà scuotendo l’universo con terribili terremoti che squarceranno la Terra distruggendo intere montagne. Il Dio Loki e suo figlio Fenrir, il grande lupo, si libereranno dopo una lunga prigionia e vagheranno per il mondo seminando morte e distruzione. Anche il serpente del mondo, figlio di Loki, finora confinato nelle profondità oceaniche, riemergerà dalle acque, provocando maremoti e alluvioni. Nella storia Norrena la relazione uomo-animale è particolarmente importante. Basti pensare al ruolo che hanno avuto i guerrieri Berseker e Ulfheðnar. Questa casta di sciamani-guerrieri la cui vita era completamente consacrata a Odino non portava armature, ma pellicce di orso (berseker) e di lupo (ulfheðnar.)Armati con spade e asce scatenavano la loro furia senza seguire nessuna strategia militare. Attraverso rituali che compivano prima di una battaglia, venivano pervasi da una furia sovrumana poiché ritenevano fosse lo stesso spirito di Odino a scendere dentro di loro per renderli forti come orsi o lupi. Furono proprio le storie sugli ulfheðnara contribuire alla diffusione delle leggende sui lupi mannari. Il massimo del rapporto uomo animale è quello con il cagnolinoo col gattino di casa, che il più delle volte viene sterilizzato col fine di renderlo mansueto e meno selvaggio. L’uomo medio, dentro al suo casermone di periferia, protesta contro la caccia, ma continua a mangiare Hamburger. Vive sempre meno internamente la natura, salvo poi fotografarla per gettarla in pasto ai mi piace. Eppure, la perdita del contatto con la natura, anche nei suoi aspetti più selvaggi corrisponde a una perdita di una parte di se, un allontanamento dagli istinti. Come avevano già osservato gli psicoanalisti Jung e Hilmann, la rimozione dell’istinto porta inevitabilmente all’aumentare delle nevrosi che si manifestano esternamente attraverso conflitti, malattie e guerra. Ci troviamo di fronte a un paradosso: se da un lato il barbaro, l’incivileviolento che fatica a integrarsi armonicamente in una società, non riesce a controllare le proprie pulsioni e ad addomesticare la propria natura animale vivendo ancora allo stato selvatico, l’uomo medio, nel sopprimere i propri istinti, ha aumentato paradossalmente la propria aggressività. Più cerca di diventare conciliante, buono, inclusivo a tutti i costi, più diventa aggressivo, violento, separato dall’altro. Basta aprire un social Network per rendersi conto come sentimenti di rabbia e ostilità siano all’ordine del giorno. Il processo di civilizzazione passa proprio attraverso il dialogo con le parti oscure.Si diventa civili a patto di continuare ad ascoltare il proprio animale interiore. Attraverso il dialogo con le parti istintuali e arcaiche è possibile realizzare quella complexio oppositorum che può rendere omogenee e compatibili le pulsioni e le motivazioni individuali profonde con le esigenze della vita collettiva. Oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire una sacralità animalee un rapporto autentico con la natura.
Il massimo del rapporto uomo animale è quello con il cagnolinoo col gattino di casa, che il più delle volte viene sterilizzato col fine di renderlo mansueto e meno selvaggio. L’uomo medio, dentro al suo casermone di periferia, protesta contro la caccia, ma continua a mangiare Hamburger. Vive sempre meno internamente la natura, salvo poi fotografarla per gettarla in pasto ai mi piace. Eppure, la perdita del contatto con la natura, anche nei suoi aspetti più selvaggi corrisponde a una perdita di una parte di se, un allontanamento dagli istinti. Come avevano già osservato gli psicoanalisti Jung e Hilmann, la rimozione dell’istinto porta inevitabilmente all’aumentare delle nevrosi che si manifestano esternamente attraverso conflitti, malattie e guerra. Ci troviamo di fronte a un paradosso: se da un lato il barbaro, l’incivileviolento che fatica a integrarsi armonicamente in una società, non riesce a controllare le proprie pulsioni e ad addomesticare la propria natura animale vivendo ancora allo stato selvatico, l’uomo medio, nel sopprimere i propri istinti, ha aumentato paradossalmente la propria aggressività. Più cerca di diventare conciliante, buono, inclusivo a tutti i costi, più diventa aggressivo, violento, separato dall’altro. Basta aprire un social Network per rendersi conto come sentimenti di rabbia e ostilità siano all’ordine del giorno. Il processo di civilizzazione passa proprio attraverso il dialogo con le parti oscure.Si diventa civili a patto di continuare ad ascoltare il proprio animale interiore. Attraverso il dialogo con le parti istintuali e arcaiche è possibile realizzare quella complexio oppositorum che può rendere omogenee e compatibili le pulsioni e le motivazioni individuali profonde con le esigenze della vita collettiva. Oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire una sacralità animalee un rapporto autentico con la natura.



 Anche i Greci sacrificavano giovani vergini prima della battaglia e, in caso di calamità, lapidavano a morte un mendicante trascinandolo fuori dalle mura dopo averlo nutrito e vestito sontuosamente per un anno. Credevano ingenuamente di potersi disfare delle proprie sventure insieme al poveraccio. Per favorire la partenza verso Troia della flotta bloccata da una persistente bonaccia, Agamennone giunse al punto di offrire la figlia Ifigenia. Il pietoso intervento degli dèi impedì la realizzazione del progetto, ma fu un salvataggio tra centinaia di altre stragi andate a buon fine. A quell’epoca non era infrequente il ricorso al sacrificio umano finalizzato alla «salvezza» della comunità, del regno, della guerra, della stirpe. Omero stesso non ne fece mistero. Achille uccise dodici giovani Troiani presso la pira di Patroclo e il fatto che quei giovani venissero immolati in occasione di un funerale mostra il carattere sacrificale, e non militare, dell’offerta. Non si trattava di una crudeltà bellica bensì di un rituale religioso. Sono noti anche i sacrifici dei discendenti di Atamantesul Monte Liceo. In caso di grave carestia «il dono» era spesso lo stesso re, o uno dei suoi figli, poiché il responsabile del tempo atmosferico e dei raccolti era il sovrano, che doveva pagare con la vita l’inclemenza dell’uno o la scarsità degli altri. Ancora nel VI secolo, cioè in piena età storica, nelle colonie ioniche dell'Asia Minore si celebravano sacrifici annuali pubblici a carattere purificatorio in cui la vittima (sempre meno consenziente) era un essere umano. Diffusi in tutta l’area mediterranea erano anche i culti del «re sacro» in cui il vecchio re veniva ucciso per far posto ad un giovane sovrano che doveva rappresentare la fecondità del popolo con la sua forza e la sua salute. In memoria del sacrificio originario del Gigante antropocosmico, il corpo del defunto veniva poi sottoposto allo smembramento rituale, e talvolta le sue carni finivano in pentola. Sacrifici umani erano praticati anche dai Persiani. E’ noto che il re Serse fece seppellire vivi nove giovani traci per propiziare il successo della sua campagna militare contro la Grecia, mentre la moglie Amestri sacrificava quattordici ragazzi di nobile stirpe a un dio sotterraneo.
Anche i Greci sacrificavano giovani vergini prima della battaglia e, in caso di calamità, lapidavano a morte un mendicante trascinandolo fuori dalle mura dopo averlo nutrito e vestito sontuosamente per un anno. Credevano ingenuamente di potersi disfare delle proprie sventure insieme al poveraccio. Per favorire la partenza verso Troia della flotta bloccata da una persistente bonaccia, Agamennone giunse al punto di offrire la figlia Ifigenia. Il pietoso intervento degli dèi impedì la realizzazione del progetto, ma fu un salvataggio tra centinaia di altre stragi andate a buon fine. A quell’epoca non era infrequente il ricorso al sacrificio umano finalizzato alla «salvezza» della comunità, del regno, della guerra, della stirpe. Omero stesso non ne fece mistero. Achille uccise dodici giovani Troiani presso la pira di Patroclo e il fatto che quei giovani venissero immolati in occasione di un funerale mostra il carattere sacrificale, e non militare, dell’offerta. Non si trattava di una crudeltà bellica bensì di un rituale religioso. Sono noti anche i sacrifici dei discendenti di Atamantesul Monte Liceo. In caso di grave carestia «il dono» era spesso lo stesso re, o uno dei suoi figli, poiché il responsabile del tempo atmosferico e dei raccolti era il sovrano, che doveva pagare con la vita l’inclemenza dell’uno o la scarsità degli altri. Ancora nel VI secolo, cioè in piena età storica, nelle colonie ioniche dell'Asia Minore si celebravano sacrifici annuali pubblici a carattere purificatorio in cui la vittima (sempre meno consenziente) era un essere umano. Diffusi in tutta l’area mediterranea erano anche i culti del «re sacro» in cui il vecchio re veniva ucciso per far posto ad un giovane sovrano che doveva rappresentare la fecondità del popolo con la sua forza e la sua salute. In memoria del sacrificio originario del Gigante antropocosmico, il corpo del defunto veniva poi sottoposto allo smembramento rituale, e talvolta le sue carni finivano in pentola. Sacrifici umani erano praticati anche dai Persiani. E’ noto che il re Serse fece seppellire vivi nove giovani traci per propiziare il successo della sua campagna militare contro la Grecia, mentre la moglie Amestri sacrificava quattordici ragazzi di nobile stirpe a un dio sotterraneo. Oggi la costruzione di Teotihuacan, Palenque, Tikal, Cahokia e Chaco Canyon viene attribuita con convinzione ai popoli toltechi, nei miti dei quali s’incontra appunto il ricordo nostalgico di una «patria primordiale» nordatlantica. Tuttora la comunità amerindia dei Kuna (o Guna), ridotta ormai a circa 40.000 unità, conserva nelle sue tradizioni il nome di Thule/Tula mentre sulla bandiera degli Indiani di San Blas sventola la swastica solare, da loro chiamata kikire interpretata come il simbolo della forza vitale. Proprio i Toltechi potrebbero avere esportato in Mesoamerica l’uso dei sacrifici umani, non immaginando certamente che le popolazioni amerinde avrebbero poi personalizzato il progetto, portandolo alle sue estreme conseguenze. Gli storici hanno calcolato che all’inizio del XVI secolo il numero delle vittime sacrificali in tutto l’impero azteco viaggiava al ritmo di circa duecentocinquantamila l’anno. Sembra che lo scopo di questa maniacale distruzione di vite umane fosse quello di preservare la vita del Quinto Sole, ritardando così la fine del mondo, già avvenuta quattro volte in precedenza. Interpretando in modo distorto chissà quale astruso concetto ereditato dai civilizzatori toltechi, gli Aztechi promuovevano in continuazione «guerre giuste» allo scopo di nutrire le divinità con il cuore e il sangue dei prigionieri. In effetti l’idea che l’uomo fosse il dono prediletto dagli dèi era presente tanto nella mentalità eurasiatica quanto in quella amerinda, ma il modo di realizzarla risultò completamente diverso perché nel frattempo le cosiddette «motivazioni spirituali» erano venute meno. Si racconta che Ahuitzotl, l’ottavo e più potente imperatore della dinastia azteca, “celebrò la consacrazione del tempio di Huitzilopochtli a Tenochitlán facendo condurre quattro file di prigionieri accanto a squadre di sacerdoti, le quali impiegarono quattro giorni per ucciderli. Quella volta, nel corso di un unico rito, furono trucidati in ben ottantamila”. A prescindere dal numero di squadre all’opera, fossero una, quattro o quaranta, ogni gruppo di sacrificatori era in grado di «trattare» una vittima più o meno ogni due minuti. C’erano sempre elementi imponderabili che in alcuni casi potevano far durare l’estrazione del cuore e la macellazione del resto qualche secondo in più o in meno, ma in media l’operazione richiedeva due minuti. Ne consegue che ogni squadra uccideva trenta vittime all’ora. Così si racconta, almeno. Ma per fare il verso a Manzoni: tra gente smaliziata si sa far la tara ai comunicati ufficiali. Se Giulio Cesare e i Romani si sperticarono per denigrare i popoli celti di Britannia che intendevano sottomettere e derubare della terra, i preti cristiani impegnati nella conversione di massa del Nuovo Mondo non furono da meno raccontando ogni sorta di nefandezze a carico dei «selvaggi» che pretendevano di catechizzare. Al primo posto ci furono naturalmente i popoli più avanzati, cioè gli Aztechi, che chiamavano loro stessi con il nome di «mexica», da cui il moderno nome di Messico.
Oggi la costruzione di Teotihuacan, Palenque, Tikal, Cahokia e Chaco Canyon viene attribuita con convinzione ai popoli toltechi, nei miti dei quali s’incontra appunto il ricordo nostalgico di una «patria primordiale» nordatlantica. Tuttora la comunità amerindia dei Kuna (o Guna), ridotta ormai a circa 40.000 unità, conserva nelle sue tradizioni il nome di Thule/Tula mentre sulla bandiera degli Indiani di San Blas sventola la swastica solare, da loro chiamata kikire interpretata come il simbolo della forza vitale. Proprio i Toltechi potrebbero avere esportato in Mesoamerica l’uso dei sacrifici umani, non immaginando certamente che le popolazioni amerinde avrebbero poi personalizzato il progetto, portandolo alle sue estreme conseguenze. Gli storici hanno calcolato che all’inizio del XVI secolo il numero delle vittime sacrificali in tutto l’impero azteco viaggiava al ritmo di circa duecentocinquantamila l’anno. Sembra che lo scopo di questa maniacale distruzione di vite umane fosse quello di preservare la vita del Quinto Sole, ritardando così la fine del mondo, già avvenuta quattro volte in precedenza. Interpretando in modo distorto chissà quale astruso concetto ereditato dai civilizzatori toltechi, gli Aztechi promuovevano in continuazione «guerre giuste» allo scopo di nutrire le divinità con il cuore e il sangue dei prigionieri. In effetti l’idea che l’uomo fosse il dono prediletto dagli dèi era presente tanto nella mentalità eurasiatica quanto in quella amerinda, ma il modo di realizzarla risultò completamente diverso perché nel frattempo le cosiddette «motivazioni spirituali» erano venute meno. Si racconta che Ahuitzotl, l’ottavo e più potente imperatore della dinastia azteca, “celebrò la consacrazione del tempio di Huitzilopochtli a Tenochitlán facendo condurre quattro file di prigionieri accanto a squadre di sacerdoti, le quali impiegarono quattro giorni per ucciderli. Quella volta, nel corso di un unico rito, furono trucidati in ben ottantamila”. A prescindere dal numero di squadre all’opera, fossero una, quattro o quaranta, ogni gruppo di sacrificatori era in grado di «trattare» una vittima più o meno ogni due minuti. C’erano sempre elementi imponderabili che in alcuni casi potevano far durare l’estrazione del cuore e la macellazione del resto qualche secondo in più o in meno, ma in media l’operazione richiedeva due minuti. Ne consegue che ogni squadra uccideva trenta vittime all’ora. Così si racconta, almeno. Ma per fare il verso a Manzoni: tra gente smaliziata si sa far la tara ai comunicati ufficiali. Se Giulio Cesare e i Romani si sperticarono per denigrare i popoli celti di Britannia che intendevano sottomettere e derubare della terra, i preti cristiani impegnati nella conversione di massa del Nuovo Mondo non furono da meno raccontando ogni sorta di nefandezze a carico dei «selvaggi» che pretendevano di catechizzare. Al primo posto ci furono naturalmente i popoli più avanzati, cioè gli Aztechi, che chiamavano loro stessi con il nome di «mexica», da cui il moderno nome di Messico. Zeus non mangiò per puro sfizio la prima moglie e il feto che portava in grembo, lo fece solo dopo aver saputo che Metis, dea dell’astuzia e dell’intelligenza, stava per dare alla luce il figlio che lo avrebbe spodestato, creando un nuovo mondo. In questo caso il vantaggio fu duplice: in un colpo solo il re dell’Olimpo scongiurò il pericolo della rivoluzione e inglobò le caratteristiche della consorte. Tuttavia i tempi erano molto cambiati dall’Era originaria di Kronos, la specie si era notevolmente indebolitae neppure gli dèi erano più quelli di una volta. Dopo il fiero pasto Zeus cominciò così a stare male. Venne chiamato Efesto, il fabbro divino la cui fucina si trovava nelle viscere dell'Etna, che con un colpo d’ascia gli aprì la testa dolente da cui Atena uscì fuori già adulta. Narrazioni dal forte significato iniziatico come quelle citate rivelano il più struggente dei desideri umani: radunare i pezzi sparsi, ricongiungersi all’androgino boreale, ripristinare l’unità primigenia. A questo scopo nella remota antichità ci si mangiava l’uno con l’altro, e fa specie che la nostalgia del femminino albergasse persino nell’animo di uomini-dèi bellicosi dediti all’arte della guerra. Nessun popolo si è mai cibato dei suoi simili per il semplice gusto di farlo. Sebbene non si possa escludere completamente la possibilità che durante i 100mila anni di gelo dell’ultima Era Glaciale il bisogno di acidi grassi omega-3 per il cervello, scarsamente rintracciabili in animali che non siano pesci, abbia spinto alcune tribù delle pianure e delle montagne verso il cannibalismo.
Zeus non mangiò per puro sfizio la prima moglie e il feto che portava in grembo, lo fece solo dopo aver saputo che Metis, dea dell’astuzia e dell’intelligenza, stava per dare alla luce il figlio che lo avrebbe spodestato, creando un nuovo mondo. In questo caso il vantaggio fu duplice: in un colpo solo il re dell’Olimpo scongiurò il pericolo della rivoluzione e inglobò le caratteristiche della consorte. Tuttavia i tempi erano molto cambiati dall’Era originaria di Kronos, la specie si era notevolmente indebolitae neppure gli dèi erano più quelli di una volta. Dopo il fiero pasto Zeus cominciò così a stare male. Venne chiamato Efesto, il fabbro divino la cui fucina si trovava nelle viscere dell'Etna, che con un colpo d’ascia gli aprì la testa dolente da cui Atena uscì fuori già adulta. Narrazioni dal forte significato iniziatico come quelle citate rivelano il più struggente dei desideri umani: radunare i pezzi sparsi, ricongiungersi all’androgino boreale, ripristinare l’unità primigenia. A questo scopo nella remota antichità ci si mangiava l’uno con l’altro, e fa specie che la nostalgia del femminino albergasse persino nell’animo di uomini-dèi bellicosi dediti all’arte della guerra. Nessun popolo si è mai cibato dei suoi simili per il semplice gusto di farlo. Sebbene non si possa escludere completamente la possibilità che durante i 100mila anni di gelo dell’ultima Era Glaciale il bisogno di acidi grassi omega-3 per il cervello, scarsamente rintracciabili in animali che non siano pesci, abbia spinto alcune tribù delle pianure e delle montagne verso il cannibalismo.






 Il tramonto delle grandi narrazioni ideologiche novecentesche, accompagnato ad un progressivo e globale appiattimento delle coscienze al modello tecno-economico, ha sicuramente incrementato e favorito la ricerca di nuove forme di coscienza che né la piatta e conforme narrazione liberal democratica, né la atea religiosità a buon mercato occidentali, riescono a dare. Il problema di questa forma di conoscenza, sta nell’infinità degli aspetti della realtà, che essa va a toccare e diviene quindi soggetta a quanto mai facili interpolazioni o ad interpretazioni tali, da finire con il porre ad un qualsivoglia attento osservatore la classica domanda, su quale possa essere la reale utilità a fini pratici o lo scopo di tali conoscenze. Ed in una civiltà come la nostra, unicamente incentrata sull’aspetto pratico, su quella “praxis”, che è conoscenza settoriale ed al contempo manipolativa della realtà, la “vexata quaestio” sull’utilità di qualunque tipo di conoscenza che non sia solo ed unicamente legata a questo aspetto, è quanto mai urgente e merita una adeguata risposta. Cominciamo con il dire che, in base alla premessa a cui abbiamo poc’anzi accennato, riguardante la natura della nostra civiltà, la domanda non può riguardare solo ed unicamente la conoscenza di tipo iniziatico o esoterico, ma anche tutti quegli aspetti del conoscere slegati dal freddo empirismo materialista che oggidì costituisce la base dell’attuale visione del mondo tecno economica. E pertanto, la nostra domanda andrà giocoforza andare ad interessare implicitamente anche ambiti diversi da quello iniziatico, quali quelli rappresentati dalla filosofia, dall’arte o dalla stessa riflessione religiosa, solo per citarne alcuni…
Il tramonto delle grandi narrazioni ideologiche novecentesche, accompagnato ad un progressivo e globale appiattimento delle coscienze al modello tecno-economico, ha sicuramente incrementato e favorito la ricerca di nuove forme di coscienza che né la piatta e conforme narrazione liberal democratica, né la atea religiosità a buon mercato occidentali, riescono a dare. Il problema di questa forma di conoscenza, sta nell’infinità degli aspetti della realtà, che essa va a toccare e diviene quindi soggetta a quanto mai facili interpolazioni o ad interpretazioni tali, da finire con il porre ad un qualsivoglia attento osservatore la classica domanda, su quale possa essere la reale utilità a fini pratici o lo scopo di tali conoscenze. Ed in una civiltà come la nostra, unicamente incentrata sull’aspetto pratico, su quella “praxis”, che è conoscenza settoriale ed al contempo manipolativa della realtà, la “vexata quaestio” sull’utilità di qualunque tipo di conoscenza che non sia solo ed unicamente legata a questo aspetto, è quanto mai urgente e merita una adeguata risposta. Cominciamo con il dire che, in base alla premessa a cui abbiamo poc’anzi accennato, riguardante la natura della nostra civiltà, la domanda non può riguardare solo ed unicamente la conoscenza di tipo iniziatico o esoterico, ma anche tutti quegli aspetti del conoscere slegati dal freddo empirismo materialista che oggidì costituisce la base dell’attuale visione del mondo tecno economica. E pertanto, la nostra domanda andrà giocoforza andare ad interessare implicitamente anche ambiti diversi da quello iniziatico, quali quelli rappresentati dalla filosofia, dall’arte o dalla stessa riflessione religiosa, solo per citarne alcuni… Come abbiamo già detto, in quanto correlato della religione o della filosofia, il sapere esoterico si pone l’obiettivo di pervenire ad una definizione dell’essenza intima della realtà, arrivandone a manipolare le energie, al fine di promuovere la crescita interiore del miste. Una crescita che , è bene ricordarlo, si differenzia dall’afflato mistico e fideistico, in quanto frutto di un percorso di attiva ricerca e sperimentazione sull’ “io”. Che poi, questa ricerca porti il miste ad identificarsi sic et simpliciter con la divina “energheia” o esso stesso ad assurgere a Nume, questo non può che dipendere dal tipo di dottrina preso in esame e dall’individuo che ne segue la pratica. Resta il fatto che, questa forma di sapere, al pari di quello filosofico, andando a disceverare l’essenza intima, “occulta” della realtà, costituisce un potente stimolo delle facoltà intellettuali di un individuo, una vera e propria modalità di potenziamento di queste ultime. Il sapere filosofico, nella sua valenza di “mathesis universalis”, costituito da una doppia valenza razionale-descrittiva e pratico-manipolatoria, arriva a toccare le corde più intime della sostanza dell’Essere potenziando le facoltà intellettuali e rendendo più completo chi, allo studio di tali discipline si avvicini. Ben lontana, quindi, da tutto il ciarpame spiritista e superstizioso da quattro soldi, la sapienza ermetica, ad oggi, potrebbe andare a costituire un valido supporto a quella scienza ad oggi messa in evidente difficoltà, davanti ai propri limiti teoretici e pratici. Una forma di sapere meccanicistico, priva di anima, non è in grado di risolvere i gravi problemi, che il mondo globale ci va presentando perché ne è essa stessa la causa, avendo indissolubilmente legato i propri destini a quelli dell’economia.
Come abbiamo già detto, in quanto correlato della religione o della filosofia, il sapere esoterico si pone l’obiettivo di pervenire ad una definizione dell’essenza intima della realtà, arrivandone a manipolare le energie, al fine di promuovere la crescita interiore del miste. Una crescita che , è bene ricordarlo, si differenzia dall’afflato mistico e fideistico, in quanto frutto di un percorso di attiva ricerca e sperimentazione sull’ “io”. Che poi, questa ricerca porti il miste ad identificarsi sic et simpliciter con la divina “energheia” o esso stesso ad assurgere a Nume, questo non può che dipendere dal tipo di dottrina preso in esame e dall’individuo che ne segue la pratica. Resta il fatto che, questa forma di sapere, al pari di quello filosofico, andando a disceverare l’essenza intima, “occulta” della realtà, costituisce un potente stimolo delle facoltà intellettuali di un individuo, una vera e propria modalità di potenziamento di queste ultime. Il sapere filosofico, nella sua valenza di “mathesis universalis”, costituito da una doppia valenza razionale-descrittiva e pratico-manipolatoria, arriva a toccare le corde più intime della sostanza dell’Essere potenziando le facoltà intellettuali e rendendo più completo chi, allo studio di tali discipline si avvicini. Ben lontana, quindi, da tutto il ciarpame spiritista e superstizioso da quattro soldi, la sapienza ermetica, ad oggi, potrebbe andare a costituire un valido supporto a quella scienza ad oggi messa in evidente difficoltà, davanti ai propri limiti teoretici e pratici. Una forma di sapere meccanicistico, priva di anima, non è in grado di risolvere i gravi problemi, che il mondo globale ci va presentando perché ne è essa stessa la causa, avendo indissolubilmente legato i propri destini a quelli dell’economia.
 Per queste ragioni possiamo considerare la Geometria sacra come un’impronta marcata della divinità. Questa ‘scienza’ è un sapere funzionale che porta a capire come è strutturata la matrice determinante in cui Dio esercita la sua funzione primaria, vale a dire come la ‘forza creatrice’ genera, forma e plasma ogni cosa nel creato pur rimanendo sempre attiva e produttiva in ogni punto del Cosmo. Cioè costantemente viva e presente in questa interminabile emanazione in cui l’Universo continua ancora ad espandersi. La scienza oggi è in grado di dimostrare come tutto quello che esiste nell’Universo materiale sia costituito principalmente da ‘Luce’, o più precisamente ‘Energia’ (misura), e ‘Vibrazione’ (peso/frequenze/intervalli). La gravità e i legami elettromagnetici sono, pertanto, gli ‘scultori’ delle svariate simmetrie presenti in Natura. Tutte le geometrie che osserviamo nell’Universo fisico sono dunque, ancora prima di essere ‘numeri’ che offriranno forme ben precise, ‘pensiero pensato’ da una ‘Mente superna’: sono creazioni elaborate da una ‘Legge divina’ non scritta ma sempre vigente. Le incalcolabili forme presenti nel mondo fisico sono a tutti gli effetti simboli della vita sviluppatasi grazie all’intervento di una precisa logica come se questa fosse realmente guidata dalla ‘mano’ di Dio. Sono da considerarsi a tutti gli effetti un’epifanìa, cioè manifestazioni terrene della divinità creante ed emanativa. Se c’è una ‘Logica’ ci deve essere di conseguenza un Artefice, un ideatore responsabile di tutto ciò. Molte cose presenti nella manifestazione materiale, così come le antiche strutture edificate dagli iniziati ai misteri con precise proporzioni geometriche, indicano per ‘numeri’ ed ‘immagini’ l’ordine divino o il ‘codice dell’Universo’ stesso con cui Dio dà origine alle infinite cose che esistono nel regno fisico. Questo saggio non vuole limitarsi ad essere il solito trattato incentrato sugli aspetti oscuri di una o più tradizioni che tenta di svelare chissà quale verità alternativa tenuta finora nascosta, o il solito scritto che tratta di Geometria sacra in senso generico, bensì ha l’ambiziosa pretesa di mettere in funzione, con un metodo che al lettore risulterà del tutto inatteso, quelle dinamiche interiori che sembrano essere andate perdute nonostante siano da sempre operative e presenti in noi.
Per queste ragioni possiamo considerare la Geometria sacra come un’impronta marcata della divinità. Questa ‘scienza’ è un sapere funzionale che porta a capire come è strutturata la matrice determinante in cui Dio esercita la sua funzione primaria, vale a dire come la ‘forza creatrice’ genera, forma e plasma ogni cosa nel creato pur rimanendo sempre attiva e produttiva in ogni punto del Cosmo. Cioè costantemente viva e presente in questa interminabile emanazione in cui l’Universo continua ancora ad espandersi. La scienza oggi è in grado di dimostrare come tutto quello che esiste nell’Universo materiale sia costituito principalmente da ‘Luce’, o più precisamente ‘Energia’ (misura), e ‘Vibrazione’ (peso/frequenze/intervalli). La gravità e i legami elettromagnetici sono, pertanto, gli ‘scultori’ delle svariate simmetrie presenti in Natura. Tutte le geometrie che osserviamo nell’Universo fisico sono dunque, ancora prima di essere ‘numeri’ che offriranno forme ben precise, ‘pensiero pensato’ da una ‘Mente superna’: sono creazioni elaborate da una ‘Legge divina’ non scritta ma sempre vigente. Le incalcolabili forme presenti nel mondo fisico sono a tutti gli effetti simboli della vita sviluppatasi grazie all’intervento di una precisa logica come se questa fosse realmente guidata dalla ‘mano’ di Dio. Sono da considerarsi a tutti gli effetti un’epifanìa, cioè manifestazioni terrene della divinità creante ed emanativa. Se c’è una ‘Logica’ ci deve essere di conseguenza un Artefice, un ideatore responsabile di tutto ciò. Molte cose presenti nella manifestazione materiale, così come le antiche strutture edificate dagli iniziati ai misteri con precise proporzioni geometriche, indicano per ‘numeri’ ed ‘immagini’ l’ordine divino o il ‘codice dell’Universo’ stesso con cui Dio dà origine alle infinite cose che esistono nel regno fisico. Questo saggio non vuole limitarsi ad essere il solito trattato incentrato sugli aspetti oscuri di una o più tradizioni che tenta di svelare chissà quale verità alternativa tenuta finora nascosta, o il solito scritto che tratta di Geometria sacra in senso generico, bensì ha l’ambiziosa pretesa di mettere in funzione, con un metodo che al lettore risulterà del tutto inatteso, quelle dinamiche interiori che sembrano essere andate perdute nonostante siano da sempre operative e presenti in noi. Tutte le storie esposte nelle varie tradizioni religiose dove si parla di un ‘Dio personale’ che avrebbe creato il mondo e si relazionerebbe con noi, il quale addirittura in passato avrebbe anche assunto un corpo fisico per mezzo dell’incarnazione o attraverso una Sua emanazione, come insegnato nel Cristianesimo e nel Vaishnavismo di cui ci siamo occupati nei nostri precedenti lavori, sono funzionali alla conoscenza di Dio per mezzo della devozione (correnti devozionali), ma a nostro avviso l’uomo deve fare uno sforzo in più se vuole realmente conoscere la reale natura di Dio; deve riuscire, in parole povere, a trascendere (senza rinnegare) queste dinamiche sentimentali e devozionali che sono alla base di ogni dottrina monoteistica per andare incontro all’Infinito, vale a dire verso la ‘dimensione metafisica’ in cui dimora la vera essenza di Dio, Spirito Supremo. Questo è possibile capirlo mediante l’Esoterismo dove tra le altre cose è presente quella scienza di cui ci stiamo occupando in questa ricerca: la Geometria sacra. La sola visualizzazione (anche interiore – ad occhi chiusi), oltre che la contemplazione, di queste speciali figure geometriche equivale ad una efficace meditazione in cui si mettono in moto all’interno di noi ‘energie emotive’ capaci di infondere ‘sostentamento energetico’ dal regno sottile e/o metafisico. Si tratta della stessa produzione emotiva che è connessa a quei ‘Principi universali’ di cui l’essenza creante dell’Anima mundi risulta essere realmente ‘Principio’ e ‘Causa’ incessantemente operosa di tutto ciò che ci circonda. I desideri sani, i ‘pensieri creanti’, sono ‘atti di luce’ che forgiano la nostra realtà, ossia sono capaci di purificare la nostra Mente e generare nuove concezioni esistenziali. Una volta riconquistate queste nozioni, secondo il processo di ‘anamnesi’, le ‘verità primordiali’ (archetipi) che sono alla base dell’intera esistenza sboccerebbero in noi come un giardino all’albeggiare di una nuova primavera
Tutte le storie esposte nelle varie tradizioni religiose dove si parla di un ‘Dio personale’ che avrebbe creato il mondo e si relazionerebbe con noi, il quale addirittura in passato avrebbe anche assunto un corpo fisico per mezzo dell’incarnazione o attraverso una Sua emanazione, come insegnato nel Cristianesimo e nel Vaishnavismo di cui ci siamo occupati nei nostri precedenti lavori, sono funzionali alla conoscenza di Dio per mezzo della devozione (correnti devozionali), ma a nostro avviso l’uomo deve fare uno sforzo in più se vuole realmente conoscere la reale natura di Dio; deve riuscire, in parole povere, a trascendere (senza rinnegare) queste dinamiche sentimentali e devozionali che sono alla base di ogni dottrina monoteistica per andare incontro all’Infinito, vale a dire verso la ‘dimensione metafisica’ in cui dimora la vera essenza di Dio, Spirito Supremo. Questo è possibile capirlo mediante l’Esoterismo dove tra le altre cose è presente quella scienza di cui ci stiamo occupando in questa ricerca: la Geometria sacra. La sola visualizzazione (anche interiore – ad occhi chiusi), oltre che la contemplazione, di queste speciali figure geometriche equivale ad una efficace meditazione in cui si mettono in moto all’interno di noi ‘energie emotive’ capaci di infondere ‘sostentamento energetico’ dal regno sottile e/o metafisico. Si tratta della stessa produzione emotiva che è connessa a quei ‘Principi universali’ di cui l’essenza creante dell’Anima mundi risulta essere realmente ‘Principio’ e ‘Causa’ incessantemente operosa di tutto ciò che ci circonda. I desideri sani, i ‘pensieri creanti’, sono ‘atti di luce’ che forgiano la nostra realtà, ossia sono capaci di purificare la nostra Mente e generare nuove concezioni esistenziali. Una volta riconquistate queste nozioni, secondo il processo di ‘anamnesi’, le ‘verità primordiali’ (archetipi) che sono alla base dell’intera esistenza sboccerebbero in noi come un giardino all’albeggiare di una nuova primavera Nelle pagine che seguono cercheremo di andare al di là di tutto ciò per conoscere meglio quei ‘Mondi lontanissimi’ di cui parleremo in quest’opera; gli stessi che, nonostante tutto, per qualche oscura ragione sono da sempre raggiungibili dalla Mente del libero pensatore. Con il termine ‘Mondi’ facciamo riferimento a determinati modiche ha la nostra psiche di concepire la realtà circostante. Sono differenti ‘dimensioni interiori’ con cui possiamo interagire eccezionalmente. I ‘Mondi’, oltre a rappresentare concreti piani di realtà che nel corso della storia svariati mistici hanno sperimentato, visionato, e certe volte persino visitato, sono un complesso di ‘fenomeni’ e ‘funzioni psichiche’ che consentono al nostro ‘Io’ di formarsi un’esperienza di sé e dell’oggettività in modo progressivo. Anche la concezione di Aldilà non indica necessariamente una dimensione oltre la vita, ma una regione percettiva della Mente che conduce i nostri pensieri fuori dall’idea comune. Si tratta, in sostanza, di una visione diversa del ‘Mondo’ e di ciò che viene comunemente accettato come concezione normale di realtà. A nostro avviso, tutte le strade, così come tutti i ‘Mondi’ da noi presentati in questa ‘ricerca del profondo’, portano chiaramente a Dio. Attraverso il ‘pensiero’, ebbene, è possibile avvicinare e concepire la dimensione spirituale ed energetica del Divino senza l’intercessione di nessun potere ‘temporale’ e ‘spirituale’ proprio perché tutto ciò che ci circonda altro non è che una proficua ed incessante ‘emozione’ di Dio. Secondo la Fisica l’energia posseduta o liberata da uno o più corpi può essere dovuta a varie cause: al movimento (energia cinetica), alla posizione (energia potenziale), a deformazioni (energia elastica), all’agitazione termica (energia termica), a reazioni chimiche (energia chimica) o nucleari (energia nucleare), a una corrente elettrica (energia elettrica), etc. Essa può, con maggiore o minore spontaneità e difficoltà, trasformarsi da una forma nell’altra seguendo i due principi della conservazione e della degradazione dell’energia.
Nelle pagine che seguono cercheremo di andare al di là di tutto ciò per conoscere meglio quei ‘Mondi lontanissimi’ di cui parleremo in quest’opera; gli stessi che, nonostante tutto, per qualche oscura ragione sono da sempre raggiungibili dalla Mente del libero pensatore. Con il termine ‘Mondi’ facciamo riferimento a determinati modiche ha la nostra psiche di concepire la realtà circostante. Sono differenti ‘dimensioni interiori’ con cui possiamo interagire eccezionalmente. I ‘Mondi’, oltre a rappresentare concreti piani di realtà che nel corso della storia svariati mistici hanno sperimentato, visionato, e certe volte persino visitato, sono un complesso di ‘fenomeni’ e ‘funzioni psichiche’ che consentono al nostro ‘Io’ di formarsi un’esperienza di sé e dell’oggettività in modo progressivo. Anche la concezione di Aldilà non indica necessariamente una dimensione oltre la vita, ma una regione percettiva della Mente che conduce i nostri pensieri fuori dall’idea comune. Si tratta, in sostanza, di una visione diversa del ‘Mondo’ e di ciò che viene comunemente accettato come concezione normale di realtà. A nostro avviso, tutte le strade, così come tutti i ‘Mondi’ da noi presentati in questa ‘ricerca del profondo’, portano chiaramente a Dio. Attraverso il ‘pensiero’, ebbene, è possibile avvicinare e concepire la dimensione spirituale ed energetica del Divino senza l’intercessione di nessun potere ‘temporale’ e ‘spirituale’ proprio perché tutto ciò che ci circonda altro non è che una proficua ed incessante ‘emozione’ di Dio. Secondo la Fisica l’energia posseduta o liberata da uno o più corpi può essere dovuta a varie cause: al movimento (energia cinetica), alla posizione (energia potenziale), a deformazioni (energia elastica), all’agitazione termica (energia termica), a reazioni chimiche (energia chimica) o nucleari (energia nucleare), a una corrente elettrica (energia elettrica), etc. Essa può, con maggiore o minore spontaneità e difficoltà, trasformarsi da una forma nell’altra seguendo i due principi della conservazione e della degradazione dell’energia.