![]()
“Santo Santo Santo è il signore degli eserciti Tutta la terra è piena della sua gloria” (Isaia 6,5)
Presso i rivi di Ruben grandi furono le risoluzioni del cuore! Perché tu sei rimasto tra gli ovili ad ascoltare il flauto dei pastori?
Dai cieli si combatté. Combatterono le stelle dai cerchi loro.
Maledite Meroz, dice l’angelo dell’Eterno;
perché non vennero in soccorso dell’eterno, in soccorso dell’Eterno insieme coi prodi
(Canto di Deboràh)
Di recente hanno suscitato un certo sgomento le immagini, proposte in mondovisione, che colgono l’attuale pontefice Francesco 1° mentre si getta ai piedi dei tre capi politici riuniti in sede di trattative per la risoluzione dei problemi determinati dalla endemica conflittualità nel Sud Sudan, invocando egli, con questo suo gesto estremo e plateale, la fine di ogni ostilità. Estraiamo da un giornale l’inizio della cronaca dell’evento “In ginocchio Papa Francesco ha baciato i piedi al presidente della Repubblica del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit, e ai vice presidenti designati presenti, tra cui Riek Machar e Rebecca Nyandeng De Mabio. Un gesto inatteso e commovente per chiedere la pace nel Paese al termine dei due giorni di ritiro spirituale per le autorità civili ed ecclesiastiche”
Qualunque cosa si pensi del sorprendente comportamento del vicario di Pietro (o di Cristo a seconda le epoche), sorprendente perché nel corso della storia è accaduto che fossero i regnanti a buttarsi ai piedi del papa e non il contrario, l’impressione che ne ricava è che il cristianesimo sia una religione non solo pacifica (il che potrebbe essere ovvio) ma pacifica a tal punto da potersi definire pacifista, contrariamente all’Islam, ad esempio, in cui all’uomo che muore in battaglia per il suo ideale di fede spetta di diritto lo status di martire.
Questo supposto pacifismo concepito quasi come se esso fosse coessenziale al cristianesimo praticamente non è mai esistito, la pace di Cristo è ontologicamente diversa dalla pace tra gli uomini e non sono solo episodi di belligeranza stranoti, quali la riconquista del Santo Sepolcro, a dar conto dello stato di (quasi) permanente conflitto dell’armata terrena di Dio, specchio riflesso di quella angelica, identicamente intransigentemente combattiva. Si tratta di una tradizione dispiegata in diverse epoche che conferiva allo scontro armato un ruolo speciale nel processo di salvezza, identificando la morte sul campo di battaglia con il martirio e quindi come una via privilegiata per raggiungere la vita eterna.
Tutta la emblematica vicenda delle crociate è, infatti, piuttosto malvista dall’orientamento ecclesiale attuale, come dimostra la stessa dichiarazione del pontefice richiamata in prosieguo nel testo. Infatti la Chiesa contemporanea, quella post conciliare, vorrebbe costruire ponti (neanche levatoi) per ogni dove in nome del nuovo dogma della “non divisività” e vorrebbe d’altronde risolvere le feroci dispute d’allora riducendo le stesse a mere contingenze temporali a una sorta di malattia infantile del cristianesimo.
Già da tempo si è introdotta come elemento di mitigazione storica la felice definizione di “pellegrinaggi armati” per “mimetizzare” le crociate, definizione tra l’altro coerentemente applicabile solo alla liberazione del Santo Sepolcro.
Per controvertire tale generalizzazione sembra che basti pensare alla ferocia manifestata dalle truppe assedianti nelle crociate albigesi e in quelle baltiche, o, ancora, lo spaventoso massacro e saccheggio perpetrato a Costantinopoli nel 1204 contro i cristiani d’Oriente, una crociata che distrusse pressoché Costantinopoli. Tutti questi episodi, citati alla rinfusa, sono tutt’altro che secondari della storia, anzi ne hanno determinato il corso e non appaiono affatto inquadrabili nel’astratta categoria dei “pellegrinaggi”, ancorché armati, e quindi non sono eventi da archiviare solertemente, quasi come se fossero errori di una gioventù definitivamente tramontata.
Durante la seconda guerra mondiale Stalin si chiedeva ironicamente quante divisioni avesse il papa, facendo finta di ignorare, lui che poi avrebbe fatto portare in giro per tutta la Russia assediata dai nazisti l’icona miracolosa della Theotokos del Kazan, che nella storia della cristianità non era stato il solo elemento umano a partecipare alla battaglia, a dirigerla, a guidarla, ma erano le stesse forze sovrannaturali a intervenire con lo scopo, non di dividere miracolosamente le parti, manifestandosi ai belligeranti nella loro potenza, quanto piuttosto a partecipare, parteggiando, alle ferocissime pugne schierandosi apertamente con i cristiani fino al punto di sovvertire la sorte di battaglie che parevano segnate o comunque compromesse.
[caption id="attachment_46309" align="aligncenter" width="625"]
![]()
Icona della Vergine del Kazan. Vittorio Messori in un suo articolo fa uno straordinario portrait delle vicende belliche durante l’assalto nazista alla Russia e del ruolo assunto dall’intervento, supposto divino, della Vergine del Kazan. Tutta la storia russa è intersecata dall’intercessione mariana nei campi di battaglia. Riproduciamo a tale scopo un brano di Nuccio d’Anna dall’articolo: La straordinaria vicenda dell’icona della Madonna di Kazan. “Quasi un secolo dopo, nel 1709, in occasione dell’invasione svedese che minacciava di cancellare la tradizione ortodossa russa a favore del protestantesimo rivoluzionario, la zar Pietro il Grande vinse gli occupanti svedesi nella memorabile battaglia di Poltava il cui successo fu unanimemente attribuito alla presenza nel campo di battaglia dell’icona della Madonna di Kazan che ormai i Russi consideravano la custode dell’identità spirituale della Nazione. Così l’icona fu portata nella cattedrale di San Pietroburgo e ancora un secolo dopo, durante la terribile invasione napoleonica condotta all’insegna del nichilismo rivoluzionario che minacciava di distruggere le basi della loro tradizione spirituale, i Russi continuarono ad attribuire la loro vittoria sugli invasori alla speciale protezione divina mediata dall’icona della Madonna di Kazan. “[/caption]
Se si dice, come si dice, che è Dio a guidare la storia – ciò è in sostanza la teologia della storia - si deve parimenti accettare che, al di là di fatti più o meno leggendari o comunque enfatizzati, che la storia umana occidentale, è d’impronta inequivocabilmente espansiva e colonialista ed è cosparsa di eventi sanguinari generato dall’impulso “religioso”. In questa cornice “suprematista” in mille circostanze furono coinvolte in modo massiccio le popolazioni civili in ogni continente e tutto ciò, secondo la evocata teologia, dovrebbe corrispondere a un preordinato piano di salvezza di Dio che giustificherebbe l’esistenza di questo scorrere degli eventi, traendosi infine da essi il bene dal male.
Questa milizia in terra del resto costituirebbe, come accennato, una sorta di riflesso nello specchio di vicende celesti. L’angelologia è improntata alla più intransigente belligeranza. Il capo delle armate celesti è quel San Michele arcangelo, appena prima presentato, che schiaccia il demonio sotto il suo piede ed egli stesso è ritenuto partecipare su un altro piano a un combattimento escatologico che si compie da tempo immemorabile tra i “figli della luce” e i “figli delle tenebre”, in conformità a paralleli riscontrabili in molteplici tradizioni.
Se esiste, come probabilmente esiste, un ecumenismo contemplativo, non è meno vero che esiste (o è esistito) un ecumenismo cavalleresco di cui forse è esemplare la narrazione del Parsifal di Wolfram von Echembach.
Esso però riguarderebbe il comportamento esemplare di pochi individui (degli iniziati in sintesi che partecipano a una cavalleria trasversalmente iniziatica) mentre gli eventi accennati sconvolsero soprattutto gli inermi che furono oggetto di infiniti supplizi da parte di orde inferocite che di cavalleresco e di spirituale non avevano un bel nulla.
La convocazione belligerante coinvolgerebbe più piani di cui quello angelico ne è solo l’intermedio e, tuttavia, detti piani sono ritenuti come intercomunicanti, tanto che vi sono molti passaggi dell’Antico Testamento in cui il testo ci narra dell’intervento diretto delle schiere angeliche, armate di tutto punto, che, dal piano sottile nel quale risiedono, intervengono in favore del popolo eletto in situazioni per esso critiche.
[caption id="attachment_46310" align="aligncenter" width="625"]
![]()
In questo quadro di Dosso Dossi dal titolo San Michele con il demonio e l’Assunta tra gli Angeli ambientato in quello che sembra un paesaggio terrestre si mostra la relazione tra il combattimento di San Michele con Satana mentre in alto è raffigurata tra la Vergine regina degli angeli[/caption]
L’intervento dell’armata di Dio comunque è solo un aspetto di questo combattimento totale perché. se san Michele è un archistratega, “il Generale”, così nominato in molte circostanze nelle cronache di queste lontane epoche, è proprio quella Regina Pacis, che sembra possedere una caratteristica tra tutte dominanti, ovvero quella del furore bellico e della risolutezza dell’azione.
La Theotokos – lo si vedrà - era descritta come addirittura presente fisicamente nei combattimenti e si comportava come una dea pagana che infervorava le schiere e rovesciava di sua mano i nemici tanto da meritarsi sul campo l’appellativo che oggi può apparire - non solo insolito - ma addirittura blasfemo di “crudele”, appellativo attribuitole da un pio cronista cattolico.
Una parte preponderante di queste riflessioni sarà dedicata al rapporto stabilitosi tra la Theotokos e il potere imperiale a Bisanzio dove l’imperatore, in qualità di rappresentante di Cristo in terra, era considerato persona sovraumana e le sue immagini partecipano di questa sacralità. Esse lo presentificavano nelle varie regioni dell’impero come persona sacra. L’imperatore d’Oriente è un “uomo” che partecipa di una particolare elezione che lo distingue e a cui si riconosce l’omaggio di quella proscinesi, che fu interdetta ai cristiani d’occidente, in cui in realtà si faceva omaggio al genio e non all’uomo, come se egli fosse una deità. In tal modo l’imperatore entra in uno strettissimo rapporto di sudditanza gerarchica con il suo generale, ovvero Maria stessa.
La Vergine gode, rispetto alle schiere angeliche, di un status privilegiato che la pone al di sopra degli stessi angeli e arcangeli, che invece sono maggiormente protagonisti nella sfera occidentale dell’influenza celeste sulle battaglie terrestri, un’impostazione che trova scaturigine nel kumranico Rotolo della guerra e che può essere collocato all’inizio di questa lunga tradizione di angeli guerrieri almeno nell’ambito delle “religioni del Libro”.
La Vergine, la Theotokos, non verrà mai rappresentata in armi, perché la sua arma è la verginità, anzi di più, è la sua prodigiosa maternità virginale che le conferisce una potenza d’irresistibile efficacia. Singolarmente, infatti, come Athena, come le Amazzoni, come le Vestali, la verginità è connessa a un potere sovrannaturale che si dispiega efficacemente in battaglia, una sorta di “virilità femminile”. Con ciò si rende possibile un confronto con la stessa Giovanna d’Arco, una semplice contadinotta che si trova infusa di questo potere pressoché soprannaturale che la farà sempre trionfare in battaglia mantenendo Ella la sua illibatezza.
Ci fermiamo qui e attenendoci al nostro titolo affronteremo il delicato tema che ci siamo proposti di trattare in un’ottica piuttosto discorsiva e il più possibile equilibrata, consci che sarebbe necessaria piuttosto una più vasta pubblicazione per sviscerare adeguatamente l’argomento nelle sue numerose sfaccettature e nelle sue complesse implicazioni.
Il combattimento celeste
La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti.
(Efesini 6,12)
V’è un punto dal quale è necessario principiare e che si sostanzia nella riflessione che segue: il primo dei combattimenti fra schiere di contrapposta costituzione si svolge in cielo e coinvolge le brulicanti compagini angeliche che si fronteggiano con quelle demoniache in un conflitto, venuto in essere all’origine del tempo e che solo alla fine del tempo si concluderà.
Un conflitto che, detto guénonianamente, coinvolge più piani della manifestazione compreso quello umano che è chiamato in causa ed è invitato a offrire il suo contributo, anche attraverso il martirio, al fine di condurre a conclusione vittoriosa l’epica lotta contro i figli delle tenebre.
Il mondo arcangelico e angelico è fortemente gerarchico ed il suo “capo” è, come detto, l’archistratega Michele. Dei sette arcangeli riconosciuti dalla tradizione biblica il cristianesimo ne ha confermati solo tre (Michele, Gabriele e Raffaele) e malgrado un quarto, Uriele, goda di una sorta di status particolare, essendo posto quasi in un limbo che sta tra ortodossia e eterodossia, questi è tuttora escluso dal novero degli arcangeli come parimenti lo sono Sealtiele, Geudiele e Barachiele e ciò nonostante gli sforzi di molti competenti studiosi che si sono spesi per rivitalizzare la tradizione dei “sette spiriti” inspiegabilmente accantonata.
Michele e Gabriele sono arcangeli e congiuntamente santi provvisti di un armamentario da combattimento, la spada l’archistratega Michele, la lancia Gabriele. Uriele a propria volta è dotato di una spada fiammeggiante ed è riconosciuto da diverse tradizioni come l’arcangelo che protegge l’accesso al paradiso terrestre ormai precluso alla coppia primordiale e alla sua discendenza. La spada di fuoco, secondo alcune leggende ebraiche raccolte da Arturo Graf sul tema, è fatta girare vorticosamente dall’arcangelo davanti l’ingresso al paradiso, un tema che richiama strettamente quello delle simplegadi, perché esiste comunque una fessura intemporale in grado di permettere il passaggio “all’eletto” dal “quadrato” al “cerchio". In ogni caso precisa lo studioso Dalmazio Frau “I sette grandi arcangeli che abbiamo avuto modo di osservare sono tutti guerrieri e combattenti, ma alcuni di loro come MikaEl, GabriEl, e UriEl, lo sono in misura ancora maggiore” (D. Frau 2014,108)
Discendendo di piani non è dimenticare che anche la gerarchia angelica è formata da schiere combattenti, variamente conformate, ma non è negli intendimenti questo lavoro procedere a un’indagine particolareggiata su questo esercito celeste, su ciò si consulti il citato testo del Frau in cui l’autore ha preso in esame le schiere degli angeli combattenti (l’armata di Dio) propone l’emblematica immagine di una classe angelica (i Principati) schierati come pronti al combattimento, essa è tratta da un dipinto di Guariento di Arpo e qui la riproduciamo.
[caption id="attachment_46311" align="alignleft" width="274"]
![]()
I Principati in schieramento da battaglia[/caption]
Come in cielo così in terra
“Non c’è legge che vieti al cristiano di colpire con la spada. Il Vangelo raccomanda ai soldati la moderazione e la giustizia. Ma non dice affatto loro: gettate le armi e rinunciate alla milizia” (San Bernardo: Epistole)
A specchio del cielo qui sulla terra anche il cristiano si trova quindi a sostenere, in primis per dovere, la personale battaglia spirituale interiore contro le tentazioni diaboliche e quindi contro il peccato che scaturisce dall’assecondare le inclinazioni perverse che dalle tentazioni scaturiscono. Oltre a questa lotta interiore e quotidiana il male si mostra, o si mostrerebbe anche personificato e quindi fisicamente presente nel mondo (di cui il demonio è il principe) e quintessenziato da compagini di avversari di Cristo contro le quali, alla fine, è necessario confrontarsi sul piano del combattimento materiale, quando la possibilità della rettificazione e/o conversione spirituale è fallita.
Per questo nei secoli si rese necessaria la creazione di vere e proprie milizie di “monaci guerrieri” che si opponessero alle schiere avversarie come gli angeli si oppongono ai demoni.
Andando in ordine sparso e in via assolutamente descrittiva e non esaustiva, richiameremo in questa circostanza l’istituzionalizzazione di alcuni di tali ordini cavallereschi improntati a questo spirito e quindi gli Ospitalieri di San Giovanni (cavalieri di Rodi e di Malta); i cavalieri teutonici voluti dal Gran Maestro Alberto di Hoenzollern e, per ultimo, sebbene sia cronologicamente intermedio ai due appena citati, il celeberrimo Ordine dei Templari che ha fatto scorrere, come banalmente si dice, i classici fiumi d’inchiostro.
[caption id="attachment_46312" align="alignright" width="230"]
![]()
Il sigillo del gran Maestro dei Cavalieri teutonici rappresenta la Vergine con il bambino in braccio esprimendo così fortemente la saldezza del tema mariano della maternità verginale unito all’intransigente comportamento bellico. Maria accetta il sacrificio di Suo figlio per la salvezza del mondo, come la madre del soldato deve accettare la morte del figlio che conduce la sua lotta contro le tenebre su questo piano di esistenza.[/caption]
Si tratta di un ordine fortemente voluto da San Bernardo e ben delineato nei suoi intendimenti e nei suoi scopi nello scritto bernardiano De laude Novae Miliziae. Qui si prescrive la più rude disciplina e un’arditezza persino superiore a quella richiesta al comune cavaliere. S’impone, infatti, di attaccare il nemico quand’anche si sia in palese inferiorità numerica “vivi e morti siamo del Signore; gloriosi i vincitori beati i martiri”.
La strategia, come si vede, è sottomessa alla fede
Con Bernardo (e con Maometto) s’introduce quindi il concetto di “guerra santa”, intesa come rito di purificazione congiuntamente esteriore ed interiore; il santo propone il termine “malicidio” come scopo finale di questa lotta, inteso come opera di eliminazione dei malfattori, portatori del male stesso; difatti il cavaliere se uccide “lavora per Cristo” mentre se muore lavora “per sé” e quindi per la propria salvezza.
Qualcuno ha voluto, forse troppo disinvoltamente, accostare il testo del De laude alla Bhagavad Gita; personalmente pensiamo che tale avvicinamento sia errato nella sua principialità. L’avversario di Arjuna, descritto nella Bhagavad, non reca nessun tratto malefico, anzi tutt’altro, egli è un nobile di vasta sapienza, la cui individualità però deve essere percepita come se fosse pressoché “fantasmica”, per questo, finalisticamente, la battaglia della Bhagavad costituisce un mezzo per conoscere la Realtà ultima. L’individualità genera attaccamento al “nome - forma” e questi legami stringono emotivamente Arjuna al suo avversario impedendogli di compiere quello che si prospetta come suo “dovere”, ovvero procedere e avanzare oltre i limiti insostanziali del predetto “nome - forma”.
Se si è spesa qualche parola in più per san Bernardo e per i Templari lo è per rimarcare come, conformemente al carattere intransigente del “santo di Dante”, parimenti di questi è nota la devozione alla Vergine, tanto che Dante attribuì a san Bernardo una preghiera alla madre di Dio, i cui versi sono davvero da considerarsi tra i più noti, toccanti e sapienti scritti su di Lei.
Così infatti esordisce il Canto XXXIII del paradiso: "Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'etterno consiglio”.
Non diversamente, per conseguenza necessaria, l’ordine dei Templari fu votato direttamente alla Vergine. Così veniva appellata infatti Maria nella liturgia: Regina Militum, Regina Fratrum Templi, Regina Conventi ab albis stolis, Regina Sancti Ordinis Templi, Auxilium Templariorum, come d’altronde si riconnetteva a Maria l’inizio stesso dell’ordine nella storia: “Nostra Signora è stata l’inizio del nostro Ordine, e in Lei e in Suo onore sarà, a Dio piacendo, la fine della nostra vita, quando Dio vorrà che ciò accada».
La sacralità attribuita ai cavalieri templari (si è parlato di gnosi templare) e al carattere della loro particolare investitura trova quasi un corrispettivo nella sacralità delle loro armi che, come narra Henry Corbin, quando questi primi cavalieri si acquartierarono nel Tempio di Salomone, furono deposte sugli altari quasi fossero oggetti liturgici
[caption id="attachment_46313" align="aligncenter" width="625"]
![]()
Affresco di Pietro Lorenzetti, nella basilica di San Domenico a Siena, San Giovanni Battista presenta un cavaliere alla Madonna col Bambino benedicente.[/caption]
Inciso
"Se tu vai con la tua fede come una bandiera, come le crociate, e vai a fare proselitismo, quello non va", -
See more at: RAINEWS
Nel corso del perenne confronto tra Cristianesimo e Islam accadde che le due fedi si sono scontrate più volte in maniera oltremodo pugnace, segnando un percorso piuttosto sanguinoso di rapporti che tuttora perdura (almeno da parte di un “certo” Islam). L’Islam è stato in diverse circostanze in condizione di invadere l’Occidente e la storiografia cristiana annovera tre tappe fondamentali e topiche del baluardo bellico che appose il cristianesimo a tale invasione: la battaglia di Poitier, la battaglia navale di Lepanto e quella di Vienna.
In tutti e tre i casi i maomettani, secondo la tradizione storiografica propria della teologia della storia, furono valorosamente fermati con le armi e, congiuntamente, con l’intervento d’un fattore soprannaturale che determinò l’esito dello scontro.
Più interessante per i nostri fini è quanto accade a Lepanto, battaglia la cui vittoria la storiografia cristiana ascrive al diretto intervento della Vergine schieratasi invisibilmente sul campo di battaglia in favore di uno dei contendenti (ancorché Ella venga tributata di onori soprannaturali da entrambe e parti).
In effetti le cronache riportano il verificarsi di alcuni eventi cui è stato attribuito carattere di soprannaturalità come il verificarsi di un improvviso cambio di vento che favorì la coalizione cristiana portandola alla vittoria. L'annuncio dell’evento giungerà a Roma ventitré giorni dopo, portato da messaggeri del principe Colonna, ma si narra che il giorno stesso della battaglia san Pio V ne ebbe in visione la percezione proprio nell'ora di mezzogiorno e glorificò la circostanza con questa disposizione: "sono le 12, suonate le campane, abbiamo vinto a Lepanto per intercessione della Vergine Santissima", dando così congedo agli astanti.
S’instaurò allora la tradizione cattolica di sciogliere le campane di tutte le chiese alle 12 in punto. Papa Pio V, proprio per effetto di tale intercessione, decise significativamente di dedicare il giorno 7 ottobre a Nostra Signora della Vittoria aggiungendo il titolo Auxilium Christianorum (Aiuto dei cristiani) alle Litanie Lauretane, successivamente la festa fu trasformata da Gregorio XIII in Nostra Signora del Rosario, sempre con la motivazione di celebrare l'anniversario della vittoria ottenuta per intercessione dell'augusta Madre del Salvatore, Maria.
D’altronde a ciò si può aggiungere che chi è di Roma o conosce Roma sa dell’esistenza di una chiesa denominata santa Maria della Vittoria, ovvero di quell’edificio che ospita, tra le altre cose, la stupefacente statua dell’estasi (transverberazione) di Santa Teresa del Bernini. Tale dedicazione è successiva a quella originale, conferita a san Paolo, ed è stata mutata proprio per celebrare un’altra vittoria militare ottenuta dalle truppe cristiane nella battaglia della montagna bianca (presso Praga) nella Guerra dei trent’anni che vide appunto una temporanea vittoria delle truppe cattoliche su quelle protestanti.
Prodromi
“Io non conosco altro compagno di battaglia sulla terra, o protezione nei pericoli, o guerriero invincibile nelle insidie, che te, Theotokos tutta pura! Per questo cado sulle mie ginocchia e grido a te, Signora del mondo: sii sempre la mia custode”
(citazione da Bisseraq V. Pentcheva: Icone e potere, pag 132)
Com’è noto nella battaglia che segnò praticamente il declino del paganesimo a Ponte Milvio, Costantino ebbe la precisa manifestazione del favore divino di questo nuovo credo venuto dal Medio Oriente con il sogno visione che precedette la battaglia. Qui vide un segno, ossia il segno della croce che fu interpretato come comunicazione dell’elargizione del favore divino nell’imminente scontro. Questo evento, ancorché presuntivamente agiografico, segnerà la coincidenza della croce come strumento del supplizio di Cristo e insieme come strumento di lotta al male che comporta anzi impone anche il supremo sacrificio del milite
Le crociate baltiche (Maria sovrana di tutte le terre)
“...imperversò la nemica disumanità al di sopra di ogni misura e senza limitazioni in modo tale che, dimentichi di ogni cristiano ritegno macellarono uumini come bestiame”
(dalla cronaca di Lamperto della battaglia di Homburg)
L’argomento delle crociate baltiche è molto meno noto di quello delle crociate in Terrasanta, eppure, oltre a costituire studio appassionate in sé per la densità degli eventi che contrassegnarono la circostanza, è l’ambito nel quale, forse con maggiore evidenza, s’intreccia il tema che ci si propone di mettere in mostra, ossia la profonda relazione che lega Maria all’azione militare e il suo merito per la vittoria ottenuta su quei popoli europei ancora “pagani” che, alla fine, furono forzatamente costretti a convertirsi.
Asciuttamente si dirà che tali impegni militari non scaturirono affatto da esigenze difensive ma da una precisa volontà aggressiva, all’epoca perfettamente giustificata per esigenze di propagazione della fede in tutta Europa, come lo sarà successivamente in altri continenti, certamente non disgiunta da inevitabili e conseguenti risvolti “economici” sicuramente non ignoti ai belligeranti, come ha ben mostrato lo storico Eric Christiansen nel suo classico testo dedicato a questa invasione dell’estremo nord dell’Europa.
Nel 1147 papa Eugenio III, emanando la bolla Divina dispensazione, autorizzò la “guerra santa” nei confronti dei popoli slavi che abitavano la parte nord ed est della Germania, equiparando questa crociata, nei meriti e nei benefici, a quella che nello stesso periodo si combatteva in terra santa contro i musulmani per la liberazione del Santo Sepolcro e a quella che si combatterà nella stessa Costantinopoli nel 1204.
Tali interventi militari, vista la manifesta riottosità delle locali popolazioni a convertirsi, furono denominati crociate del nord o crociate baltiche, o, altrimenti, crociate livoniane. Esse naturalmente non sono state affatto “pellegrinaggi armati” per il semplice ed evidente motivo che non c’erano luoghi santi da proteggere. La Livonia è una regione geografica che comprende gli attuali stati di Lettonia, Estonia, e Lituania ed altri territori ancora, una superficie tutt’altro che trascurabile dell’Europa continentale nordica.
Queste invasioni durarono diversi decenni, in quanto organizzate tra lo spirare del dodicesimo secolo e l’inizio del tredicesimo coinvolgendo pesantemente, con razzie, decimazioni e deportazioni forzate, le popolazioni che occupavano i territori affacciantisi sul mar Baltico, azioni di estrema crudezza che furono puntualmente annotate, a loro vanto, dai vincitori.
Come si diceva nelle decorse pagine, diversamente a quanto avvenuto in quelle di Terra Santa, queste crociate si proposero fin da subito l'obiettivo della conversione coattiva dei conquistati, che vennero quindi battezzati successivamente alla sconfitta militare dei loro eserciti da parte di questi crociati, che erano principalmente tedeschi, danesi e svedesi.
Artefici del successo e protagonisti di queste cruentissimi episodi furono i Cavalieri Portaspada che appartenevano a un ordine appositamente creato nella circostanza a specchio di quello templare. L’Ordine dei Cavalieri Portaspada, conosciuto in latino sotto il nome di Fratres militiae Christi ed in tedesco come Schwertbrüder, venne infatti fondato dal vescovo Alberto di Riga nell’anno 1202, ovvero dal fondatore stesso della città.
[caption id="attachment_46314" align="alignright" width="236"]
![]()
Questa miniatura riproduce l’abbigliamento bellico del vescovi guerrieri che ebbero grande influenza nelle vicissitudini guerresche dell’epoca[/caption]
Non è quindi solo una frase ad effetto quella con cui si afferma che i Portaspada siano stati i Templari del Nord. Tale ordine monastico-cavalleresco, si ispirava apertamente a quello dei Templari, sia per la simbologia, sia per le regole interne, ed era nato al solo fine di promuovere e proteggere l’opera di cristianizzazione nell’area pagana del mar Baltico. I Portaspada adottarono come distintivo, cucito sopra il loro mantello bianco, una spada rossa sotto una croce rossa. A soli due anni di distanza dalla sua fondazione, ovvero nel 1204, papa Innocenzo III riconobbe ufficialmente lo statuto dell’Ordine.
[caption id="attachment_46315" align="alignleft" width="179"]
![]()
Sigillo dei Portaspada come si vede spada e croce sono emblematicamente unite tal ché l’una (la spada) sembra quasi il riflesso allungato della sovrastante croce[/caption]
Si può affermare che la spada è la croce che portano i cavalieri nella loro lotta contro il male, la via attiva del combattimento spirituale, complementare alla via contemplativa con frequenti travasi da una dimensione all’altra, basti pensare alla nota vicenda di San Galgano e della ormai famosissima spada confitta nella roccia.
La via sufica, per sconfinare in un ambito prossimo, accosta, con ulteriore forza le due vie, l’attiva e la contemplativa, che possono ben essere praticate congiuntamente, così come ci si può riferire a certe linee del buddismo cinese (schaolin). Proprio l’investitura cavalleresca mostra il carattere di suggello ricevuto dal miles Christi che veniva toccato dal dorso della spada dal suo investitore mentre questi pronunciava queste parole: “Sei creato cavaliere in nome di Dio, San Michele e San Giorgio”.
Come si vede l’investitura avveniva invocando tre piani: Dio stesso, San Michele quale capo della milizia celeste e, ulteriormente, da S. Giorgio santo militare per eccellenza, dopo ciò “seguiva una messa che consacrava il nuovo membro della cavalleria umana”.
Dalmazio Frau richiama un passaggio di uno scritto di Raimondo Lullo in cui l’equipollenza tra spada e croce è pienamente confermata da queste parole: “Al cavaliere si da la spada, che nella forma è simile alla croce, per significare che, come Gesù Cristo vinse sulla croce la morte nella quale eravamo incorsi per il peccato di nostro padre Adamo, così il cavaliere dovrà con la spada sterminare i nemici della croce. E poiché la spada ha due tagli e la cavalleria è fatta per mantenere la giustizia, che consiste nel dare a ciascuno il suo, per questo la spada vuole dire che, per mezzo di essa, il cavaliere deve mantenere la Cavalleria e la Giustizia” (D. Frau: 2014, 79)
Abbandoniamo le interessanti vicende storiche di questi cavalieri per concentrarci sul punto essenziale del discorso. Dopo la sottomissione di queste popolazioni alla fine delle ostilità e per precisione il 2 febbraio 1207, nei territori conquistati, venne istituito uno “stato ecclesiastico” detto Terra Mariana che fu assimilato a un principato del Sacro Romano Impero. Tale principato nel 1205 era stato proclamato da papa Innocenzo III possedimento della Santa Sede. La classe politica precedente fu sostituita da nobili invasori e dalle loro corti, stranieri che nulla avevano a che fare con quegli ampi territori e per conseguenza, de facto, le popolazioni locali furono colonizzate e persero ogni autonomia. Un caso di “quasi” sostituzione etnica.
A questo punto ci si può domandare: perché “terra mariana”? La risposta può essere semplice e si trova nelle cronache dell’epoca tra cui la principale testimonianza è offerta dal cronista ecclesiastico Enrico di Lettonia autore del Cronicon Livoniae. Questo scritto raccoglie la testimonianza diretta degli eventi descritti e quindi è di particolare valore per la conoscenza del tema mariano che stiamo esaminando, in quanto proprio l’atteggiamento intransigente di Maria, in quei lidi, costituì, contribuendo in primis alla vittoria il suo presunto diretto intervento, uno strumento assai persuasivo di propaganda per la conversione dei locali e, ulteriormente, per ottenere la sottomissione ai nuovi signori stranieri che li avrebbero dominati in futuro.
Enrico, infatti nei suoi scritti, la invoca come “la Maria Stella” e la prega affinché “vegli sempre sulla sua Livonia” e descrive come essa sia “la signora del mondo e sovrana di tutte le terre” e per questo sollecita la Vergine affinché protegga “costantemente il suo paese”, d’altronde questa è l’investitura che ha la Regina del Cielo. ad essa spetta il compito di dominare su tutti i re della terra. Il commentatore fa notare come soprattutto la Vergine abbia “punito tanti re che hanno combattuto contro la Livonia”.
Secondo le brutali osservazioni di questo cronista ecclesiastico Maria uccide e massacra coloro che non piegano il ginocchio e si sottomettono al giogo di Cristo e per meglio esaltarne le caratteristiche scrive: “Vedi la madre di Dio com’è mite verso i suoi, che in Livonia l’hanno servita con fedeltà e come protegge sempre da tutti i nemici, e come è crudele verso coloro che invadono il suo paese, o coloro che in questo paese cercano di ostacolare la fede e l’onore di suo figlio. Vedi quanti potenti re ha punito. Vedi quanti principi e anziani dei popoli infedeli ha cancellato dalla terra, quanto spesso ha concesso ai suoi la vittoria suo nemici ![...] Guardate e ricordate voi principi russi, pagani danesi, e voi anziani di qualunque popolo, temetela, la mite madre misericordiosa, onorate la Madre di Dio, riconciliatevi con lei che si vendica in modo così crudele dei suoi nemici, non attaccate più il suo paese, affinché sia per voi una madre colei che finora è stata sempre la nemica dei suoi nemici e ha sempre recato a coloro che danneggiano i suoi in Livonia un danno ancor più grande” (K. Deschner: 2006, 126)
Come ognun può constatare dalle parole di Padre Enrico risulta evidente come Maria non si limiti semplicemente a sostenere le sue truppe infondendo a esse un coraggio e un valore superiore al comune, quanto piuttosto intervenga direttamente nell’azione bellica risultando determinante per l’esito positivo dello scontro.
Questi spunti, in estrema sintesi, mostrano che tipo di legame affettivo stringe il cristiano in armi, alias il crociato, con la Regina del Cielo, di cui egli è figlio più d’ogni altro, in quanto il crociato è disposto al sacrificio in similitudine con il sacrificio del Cristo.
Ora nella seconda parte si esaminerà come viene vissuta la figura mariana nell’oriente cristiano sempre riguardata la figura in rapporto al tema bellico.
Oriente Cristiano: Maria, vergine madre e signora della guerra
“Sorgente di vita dei Romani, Vergine, madre del Logos divino tu sola marci in battaglia come combattente al fianco degli imperatori [nati] nella camera di Porpora. Essi ricevono la corona da te, perché ti ricevono nella camera di porpora come scudo invincibile contro ogni cosa…Perché essi ti ricevono come potenza che conduce alla vittoria contro i nemici”
(Acclamazione alla Theotokos)
Titolo forte ma affatto provocatorio che certamente contrasta con l’attributo di “signora della pace” che nella contemporaneità le è più consueto, e che, per conseguenza, sembrerebbe in totale contraddizione con esso, titolo comunque perfettamente giustificato dalla narrazione fin qui esposta e da quanto s’esporrà nelle pagine successive.
Il tema della verginità come fonte di potere
Prima di procedere ulteriormente è necessario stabilire una collocazione precisa agli eventi che si andranno a menzionare e così mostrare come lo stabilirsi del potere centrale a Costantinopoli da parte dell’imperatore bizantino abbia prodotto una decisa frattura tra la mentalità tra Occidente e quella dell’Oriente che ha successivamente verosimilmente determinato, addensandosi le difformità, la separazione delle due chiese, culminando questa divaricazione nello scisma del 1054.
In Oriente, permanendo un impero che durerà fino alla conquista ottomana di Costantinopoli, si stabilisce un consolidamento tra Chiesa e forma politica che in Occidente, con il tramonto e la fine del dominio imperiale romano e la deposizione di Romolo Augustolo, verrà meno, condannando perciò questa parte dell’ecumene cristiano a un lungo periodo di oscurità, destino che invece non toccherà a Costantinopoli che, contrariamente, vivrà anni splendidi, anche se contrassegnati da una costante belligeranza con vari popoli e culture ad esso viciniori.
Partiamo, per fissare un punto di svolgimento, dal quarto concilio ecumenico di Calcedonia (451) che fu convocato e presieduto dall’Imperatore. Con esso si pose definitivamente fine alla controversia riguardante la natura del Cristo, enunciando il dogma delle due nature perfette, inseparabili ma distinte, (fusione senza confusione) secondo la formula divenuta ufficiale e respingendo quindi come eretiche le prospettazioni monofisite dall’archimandrita greco Eutiche per il quale la natura di Cristo sarebbe stata solo divina. Questo risultato si armonizza con le conclusioni dogmatiche assunte dal Concilio di Efeso in ordine alla natura creaturale della Madonna chiamata a dare vita biologica all’Incarnato definendo compiutamente il suo ruolo nel disegno di salvezza.
L’arbitrato dell’imperatore, in una disputa così delicata, potrebbe destare stupore osservando le cose da un punto di vista odierno e laico, tuttavia è necessario tenere in debito conto dello stretto rapporto, già in precedenza richiamato, che univa il potere imperiale a Cristo, un potere che dopo queste fissazioni dogmatiche, uscirà ben consolidato. L’imperatore, infatti, era concepito come un diretto rappresentante di Cristo in terra e da questi riceveva l’incarico di amministrare un impero ritenuto fondato e governato dallo stesso Salvatore.
Per questa sua suprema unzione il popolo salutava l’imperatore chiamandolo “santo” e conseguentemente tutto ciò che riguardava la sua persona era sacro, così come la sua immagine. Il suo ritratto era considerato equivalente, seppur non identico, alla sua persona, e, in determinate circostanze, questa ritratto dello stesso riceveva i medesimi onori come se l’imperatore fosse fisicamente presente alla circostanza. Per conseguenza quando il “simulacro” sostituiva il basileus nelle cerimonie, che si svolgevano lontano da Costantinopoli, il popolo lo acclamava, come se fosse davvero presente, al grido di “santo” e gli si dava altresì l’appellativo di “sacro” e di “divino”.
Il suo ritratto veniva incensato, scortato da fiaccole e salutato mediante prosternazione (proscinesi) rendendo così un vero e proprio culto alla sua persona, in relazione alla sua funzione di garante di un ordine stabilito sovrannaturalmente.
Il sovrano, narra la Velmans, autrice delle osservazioni sovraesposte, si trovava al centro di una doppia relazione mistica, che da un lato lo univa al Cristo e dall’altro al suo ritratto. (Tania Velmans: 2009,15)
Questo simbiotico legame tra potere imperiale e crisma religioso caratterizzerà la metà orientale dell’Impero fino alla sua estinzione e troverà il suo fulcro nel culto della Vergine, espresso dalle sue rappresentazioni iconiche che si affermeranno nel tempo e la cui devozione sarà alimentata in maniera massiccia dalla promozione imperiale del culto, perché in tal modo onorando l’una s’onorava l’altro.
La primissima manifestazione di ciò si ebbe già nel quinto secolo quando fu eretta una cappella (soros) dedicata al 0culto mariano all’interno del palazzo imperiale, volendo così stabilire un legame strettissimo che perdurerà nei secoli e che farà di Costantinopoli “la città personale della madre di Dio” per effetto del culto imperiale che si era lì costituito.
Il complesso della Blacherne, continuamente “affinato” nei secoli alle esigenze politiche, può essere considerato come il cuore di questo culto in quanto il luogo era depositario della preziosissima reliquia del velo (o delle vesti) della Madonna e altresì di santissime icone. Esso comprendeva tre edifici: la chiesa di Santa Maria, la citata cappella del reliquiario (Hagia Soros) ed il bagno (Hagion Lousma) che trova fonte da una sorgente d’acqua sacra e miracolosa tuttora oggetto di culto e per questo frequentato da donne cristiane e musulmane, come altri santuari mariani dei paesi musulmani. Anch’esso era un luogo massimamente sacro diviso in più ambienti ornato con icone. L'acqua veniva versata nel bacino dalle mani di una statua marmorea della Vergine. Un'immagine di San Photinos decorava il centro della cupola. Ogni anno, il 15 agosto (festa della Dormizione) dopo l'adorazione del Maphorion (santo velo) della Vergine, l'imperatore praticava una triplice abluzione nella piscina sacra.
Il carattere regale della Madonna trovava espressione nelle varie rappresentazioni della Vergine Maria ritratta con il loros imperiale e quindi come Maria Regina (un’immagine è presente anche a Santa Maria Antiqua a Roma ed è unica in tutto l’occidente e che è stata realizzata durante il periodo di occupazione bizantina della città). Tutti questi segni di favore, benedizione e protezione saranno strumenti idonei a produrre importanti conseguenze nel campo strettamente politico.
In definitiva questo complesso, un tempo isolato la cui esistenza era dovuta all’esistenza di una fonte d’acqua miracolosa, sarà solo successivamente incorporato nelle mura di difesa divenendo il centro di un vero e proprio culto militare, promuovendosi la reliquia al ruolo di efficace protettrice della capitale d’Oriente (la seconda Roma) e in definitiva dello Stato stesso.
[caption id="attachment_46316" align="aligncenter" width="625"]
![]()
Collocazione del palazzo della Blacherne nella topografia di Costantinopoli[/caption]
Tra le varie icone conservate in loco spicca, per l’impiego protettivo cui fu destinata, quella denominata Blachernitissa. Si tratta di quel dipinto caratteristico che mostra il corpo clipeato di Cristo sovrapposto al grembo della madre. L’esposizione di questa icona miracolosa costituirà il mezzo di propaganda più efficace e di cui si farà promotore l’impero in ogni circostanza mostrando l’indissolubile legame che legava la Regina del Cielo al suo impero e alla persona o alla famiglia dell’imperatore, stabilendo così una precisa e inestricabile relazione simbiotica tra i due soggetti
[caption id="attachment_46317" align="aligncenter" width="625"]
![]()
Icona della Blachernitissa[/caption]
Tuttavia ci sia consentito un indispensabile inciso sul tema in relazione ai significati dell’immagine sacra affinché ne sia colto appieno il significato in questo ambito così vicino e, insieme, così lontano dai nostri lidi.
Siamo consapevoli che quando si parla di “propaganda” si utilizza una modalità espressiva moderno – contemporaneo poco consona a essere impiegata per rendere conto di circostanze storiche nelle quali era inimmaginabile contestare che l’autorità imperiale non derivasse dal crisma celeste; semmai si dovrebbe parlare nella circostanza di “azioni promozionali” che provocavano un accrescimento d’entusiasmo e di consenso tra le varie classi sociali.
In particolare queste cerimoniali esposizioni infiammavano l’animo del miles e comunque, rinfocolando la fede dei sudditi in ordine alla giustezza e soprattutto alla santità dell’ordine costituito, saldavano la compagine stratifica della popolazione orientandola in un’unica direzione di consenso. L'indissolubilità del legame che univa la Vergine al suo protetto si propagava infatti in scala piramidale a tutti gli abitanti dell’impero che compartecipavano per riflesso di questa protezione divina formando un unico corpo.
Tuttavia ciò non è da solo bastevole a spiegare la profondità di questa relazione e per meglio comprenderne il senso è necessario sottolineare come le sacre immagini abbiano avuto una storia simbolica ben diversa nelle due parti del mondo cristiano, come se un muro dividesse la portata di queste rappresentazioni e come l’iconografia orientale (tranne la pausa dell’iconoclasmo naturalmente) costruisse un universo a parte nella concezione dell’immagine.
Due imperi, due approcci all’immagine
“I testi ci rivelano prima delle immagini che lo spazio figurativo bizantino non poteva essere che un luogo al di là di ogni luogo o addirittura un altrove rispendente. In questo caso gli artisti si basavano sugli scritti di Platone di Plotino, dei Padri Greci e dei teologi, rappresentando uno spazio, o piuttosto un non spazio, ridotto a una superficie dorata”
(Tania Velmans)
Attraverso il matrimonio con l’imperatrice di Bisanzio Carlo Magno avrebbe voluto realizzare l’impero universale e quindi riunire in un unico corpo le due metà spezzate, ovvero saldare quella frattura tra Oriente e Occidente, prodottasi a seguito delle conosciute circostanze storiche, mai più rinsaldatasi.
Questa riunificazione non riuscì per vari motivi che non staremo qui a focalizzare e questo determinò per conseguenza l’insorgere e l’ergersi di una barriera di differenze sempre più grande tra Roma e Costantinopoli che iniziarono a seguire vie storiche completamente diversificate, fino a giungere al citato scisma del 1054. La concezione religiosa dell’arte è un esempio illuminante, e, insieme, sintomatico, di questa progressiva divaricazione.
Teofuldo, il probabile redattore dei libri Carolini, che potremmo ascrivere tra i teorici fondamentali dell’arte occidentale, affermava che l’arte sacra ha l’unico scopo di istruire il popolo ed insieme acconciamente adornare gli edifici sacri e quindi il suo utilizzo corrisponderebbe essenzialmente a una finalità didattico pedagogica (sulla qual cosa comunque nutriamo dei dubbi perché ci appare come un’eccessiva semplificazione); diversamente, nella concezione orientale, la rappresentazione sacra è immaginata e vissuta come carica di energia sacra trasmissibile in quanto la rappresentazione è intermediaria tra questo mondo e l’altro.
Questo brano da piena contezza della precedente affermazione: ”La sacralizzazione dell’immagine bizantina poggiava sulla convinzione che esistesse un legame diretto tra la rappresentazione e il rappresentato. L’immagine riceveva le emanazioni delle “energie” di coloro che rappresentava. Le si attribuiva inoltre il privilegio dell’autenticità, poiché era considerato fedele a un modello archetipico (l prototipo), ottenuto per mezzo di un miracolo per quanto riguarda Cristo, di un dipinto eseguito dal vero dalla Vergine, e di volti visti in un sogno per i santi. (Tania Velmans: 2009,9)
Questo è il primo punto da tenere presente quando si affronta l’argomento dell’esposizione della sacra icona della Vergine in varie circostanze, tra cui, quella che ci interessa nel contesto, è proprio quella della battaglia, essa, infatti, è ben più di un vessillo, in quanto piuttosto si presenta all’azione come una sorta di serbatoio di energia divina, una specie di equipollente dell’arca dell’alleanza, cui la Vergine fu effettivamente teologicamente paragonata, che si orienta contro i nemici di Cristo al fine di sconfiggerli.
La seconda circostanza che si può richiamare e che concorre a formare il quadro del ruolo dell’icona in battaglia è stavolta prettamente ideologico ed è costituito da quel lento e progressivo trasferimento dal precedente mondo classico dei contenuti iconografici di Tyche e Vittoria che passano, con piena legittimità. alla Vergine che assunse integralmente la funzione delle due dee “civiche”.
La coniazione delle monete imperiali fa da guida cronologica a questo lento processo di sostituzione che si può seguire esaminandone diacronicamente l’iconografia. Difatti, ancorché gli imperatori si dichiarino cristiani, essi ancora “giocano” con quelle divinità pagane che possono favorire la vittoria sui nemici. Il ruolo di queste entità non è solo importante, si direbbe piuttosto che rappresenta un fattore decisivo ed essenziale nell’esercizio del dominio, in quanto è solo la vittoria sul nemico che legittima il potere imperiale, rendendo pressoché ritualmente sacro lo scontro armato e con esso i suoi vincitori cristiani.
Sul campo non hanno combattuto solo gli uomini ma altre forze a loro ben superiori e si sono espresse come si fosse in un giudizio ordalico.
Le dee civiche sono riprodotte sia sul recto che sul verso delle monete spesso congiuntamente ai regnanti che ad esse si appaiano con grande familiarità e con accorgimenti “grammaticali” di accostamento formale il cui significato sintattico era perfettamente comprensibile agli utilizzatori di allora. La moneta circola in tutto l’impero (e fuori) ed è il mezzo di comunicazione più veloce e trasversale concepibile, in quanto essa viene toccata contemporaneamente da mille mani. Appare quindi ovvio che per celebrarne i successi in questa o in quell’altra campagna si mostrino gli imperatori accanto alle dee stesse a dimostrazione del favore divino che li investe.
La moneta è un “slogan televisivo” che mai s’interrompe fino alla morte di quel tale imperatore, per poi investire il successivo dello stesso potere e che quindi. a propria volta. alla prima vittoria conierà la “sua” moneta celebrativa dell’alleanza divina.
Attraverso un lento processo di trasformazione a Tyche e Vittoria si sostituì l’immagine della Vergine turrita e vittoriosa, esprimendosi così, attraverso una congrua iconografia, il carattere dichiaratamente bellico assunto dalla Theotokos. Questa sostituzione di Atena - Nike o Tyche Vittoria inaugurata nel sesto secolo con l’imperatore Giustino, subì un arresto perché, per un periodo non breve, gli imperatori mirarono ad accentuare il carattere dinastico della loro investitura e per questo furono chiamati porfirogeneti in quanto nacquero nella “camera di porpora”, una “dependance” del palazzo edificato in prossimità degli già esistenti edifici sacri della Blacherne si cuo si p vista in precedenza la collocazione sulla pianta.
[caption id="attachment_46318" align="aligncenter" width="625"]
![]()
Pallazzo del Potfirogeneta facente parte del complesso della Blacherne[/caption]
Il palazzo delle Blacherne era un palazzo imperiale che si trovava nella parte nord-ovest della città, addossato alle mura della città, dove l'aria era più salubre e dove al contempo si dominavano la campagna e il Corno d’Oro.
Lì era il luogo della reliquia più santa della Theotokos - il suo velo o la sua veste (maphorion) - che presidiava la salute della città di Costantinopoli e dell’impero tutto, in pace e in guerra.
Seppur le testimonianze cronachistiche, che si produrranno appena successivamente, mostrano la Vergine oggetto di un intenso culto sia pubblico che privato e semmai impegnata - quando le circostanze lo richiedevano - prevalentemente in una opera difensiva della seconda Roma, oggetto nei secoli delle avide incursioni di svariati popoli che volevano conquistarla, la documentazione storica lascia intendere che nel periodo immediatamente posteriore all’iconoclasmo la reliquia di Maria divenne il centro d’interesse di quello che diverrà un vero e proprio culto militare che si spingeva ben oltre l’ottica meramente difensiva della “città santa”.
La veste di Maria, da reliquia, atta alla contemplazione e quindi imbibita d’energia sovrannaturale, muto la propria natura trasformandosi in un’icona bellica portata in ogni luogo per volgere le sorti del conflitto a favore dell’Imperatore, con le stesse finalità, già sottolineate, che furono proprie dell’arca veterotestamentaria.
A questo punto si rende necessario completare il quadro con un altro fondamentale pilastro argomentativo che contribuisce a rendere perfettamente chiara l’indissolubilità del legame della Vergine con l’Impero e ne sottolinea il carattere organico e per conseguenza mostra l’unzione pressoché sacramentale che ricevevano gli imperatori nella loro attività di difesa e di conquista
Si tratta del testo dell’arcaico e notissimo inno Akathistos, che tuttora si canta nelle chiese d’Oriente, e che alla ventitreesima strofa coniuga espressamente la figura di Maria al potere imperiale che, lo si ribadisce, si legittima attraverso la vittoria militare.
Il legame della camera di porpora con il complesso monastico della Blacherne fu tuttavia storicamente rapsodico. Per conseguenza di altre vicende storiche, ovvero l’investitura di sovrani stranieri, spesso capi militari, che non potevano vantare alcuna legittima discendenza dinastica e quindi non avevano titolo per accedere alla camera di porpora, si ripristinò la pregressa equazione simbiotica che conferiva alla sola vittoria militare la legittimazione al governo, indipendentemente dalla trasmissione dinastica, in quanto si riteneva che essa era stata ottenuta per mezzo, non solo della benevolenza mariana, ma del suo stesso intervento strategico.
La Theotokos quindi riassunse in toto i compiti delle divinità civica cui era subentrata, tutto cambiò, affinché, gattopardescamente, nulla cambiasse.
Lo rende evidente il confronto tra questi due brani che descrivono due momenti storici diversi resi equiparabili dalla modalità dell’azione diretta della figura divina, pur se ciò è avvenuto in circostanze storiche assai diverse e in cui nel secondo brano ci si riferisce alla Theotokos che “sostituisce” Atena nei suoi compiti belligeranti:
“Non devo passare sotto silenzio la ragione della miracolosa salvezza della città, perché essa stimolerà la pietà in chiunque la ascolterà. Quando Alarico e il suo esercito al completo giunsero alla città egli vide la dea tutelare Atena camminare lungo le mura, con aspetto identico a quello della sua statua, armata e pronta a resistere all’assalto” (Bissera V. Pentcheva: 2018, 91)
Nel Chronicon Paschale il capo dei nemici, il Kagan degli Avari, vede la Vergine camminare sulle mura di Costantinopoli ‘L’empio Kagan disse in quel momento della guerra: Ho visto una donna dall’augusto portamento correre da sola sulle mura’” (Bissera V. Pentcheva: 2018, 90)
D’altronde non si può omettere dal ricordare che il tema del soccorso divino in battaglia, per precisione il soccorso da parte di una donna divina o della stessa dea, costituisce un tema assai arcaico e se ne trova precisa testimonianza in ambito sciamanico. Zolla fece un’importante ricerca comparativa su questo argomento i cui risultati confluirono in un testo specifico (L’amante invisibile: l’erotica sciamanica nelle religioni e, nella letteratura e nella legittimazione politica). Tuttavia, stringendo il discorso all’ambito che strettamente interessa queste note, ovvero quello della Grecia arcaica, troviamo un’interessante testimonianza di questo pattern in ambito omerico - quindi nell’Odissea - a dimostrazione d’una continuità che risaliva pressoché alla preistoria del mondo greco.
Episodio particolarmente rivelatore di questa presenza è quello che vede la disfida del camuffato Ulisse con i Proci che soccombono a questi e suo figlio. Ulisse, con Telemaco, non vincono lo scontro, con i loro troppo numerosi avversari, con l’ausilio delle sole loro forze ma grazie all’intervento diretto di Atena. Così ne scrive Leonardo Magini autore di una interessante ricerca sul tema: “E si tratta davvero di una strage miracolosa perché per due volte l’intervento di Atena manda a vuoto i colpi dei pretendenti. In altre parole è la protettrice che subentra al protetto: in un mondo prettamente sciamanico sarebbe stato lo sciamano stesso con i suoi poteri magici a deviare i colpi degli avversari, nel mondo post sciamanico è la protettrice celeste (àyami), elevata al rango di dea a svolgere quel ruolo” (Leonardo Magini: Lo sciamano di nome Ulisse pag.225))
Per effetto di ciò e a seguito dello status conferito gli imperatori bizantini cominciarono a portare la sacerrima icona della Blachernitissa nelle loro campagne militari come se Ella fosse “vivente” e pret questo ricevette la ulteriore qualifica di “arma invincibile”.
Si ribadisce che questa sua funzione non era quindi principialmente connessa alla protezione di Costantinopoli, che fu salvata molte volte mercé la protezione mariana, ma alla vittoria ottenuta nelle spedizioni militari ai confini o all’esterno del territorio.
Ulteriori testimonianze storico - archeologiche confermano l’attitudine bellica della Madonna. La troviamo infatti rappresentata in alcuni esemplari di sarcofagi dell’epoca attorniata dai cosiddetti “santi militari” che ad Ella si stringevano con particolare devozione. Questi, a volte, si mostrano rivestiti di abiti di corte (e qui di nuovo si conferma il legame con il potere imperiale), altre volte con abiti militari e quindi dotati delle relative armi che si deve ritenere fossero, a propria volta, sacralizzate; tra esse particolarmente significativa è la spada: una croce bellica.
Questa tradizione nasce dalla vittoria di Costantino su Massenzio al Ponte Milvio, ci si è accennato in precedenza quale prototipo simbolico della coniugazione croce spada. L’apparizione della croce è il segno che mostra che solo attraverso la croce si ottiene la vittoria su tutti i piani e quindi, tanto per richiamare la dichiarata equivalenza, ricordiamo l’iconografia del sigillo dei Cavalieri Portaspada che reca croce e spada insieme a dimostrazione della indissolubilità del legame che stringe il martirio di Cristo alla eventuale caduto in battaglia che si batte “per Cristo” e per la “sua salvezza”.
Bissera V. Pentcheva pone l’attenzione su un altro significativo oggetto che mostra l’evidenza di questa simbologia in cui si parifica la croce del sacrificio alla croce – arma e il suo impiego “malicida”. Si tratta di una placca d’avorio con la rappresentazione della Crocifissione presente al Metropolitan Museum of Art. Questa, mentre si drizza verso l’alto, perfora le viscere dell’Ade emblema supremo del male. La scritta accanto all’immagine inequivocabilmente annuncia. “La croce (si è) piantata nello stomaco dell’Ade.( Bissera V. Pentcheva: 2009, 138).
Scrive ancora l’autrice richiamata “La croce imperiale e gli stendardi militari andrebbero identificati con croci da processione di dimensioni considerevoli, come l’esemplare ingioiellato del tardo X secolo della Lavra del monte Athos. Nell’iscrizione posta sul retro della croce l’oggetto viene definito un’arma, con la quale i soldati di Cristo sono incoraggiati a trafiggere i loro nemici. La croce è concepita come una lancia nelle mani dei soldati. Le immagini che la decorano si riferiscono sia alla battaglia che al trionfo”. Per conseguenza si può affermare che la spada croce sia pressoché considerata un’arma liturgica dal momento che essere nemici dell’Impero è l’equivalente di essere nemici del Cristo.
Queste, sinteticamente, sono le premesse teologiche che giustificano i contenuti delle cronache dell’epoca che riferiscono come, in molte circostanze, gli assedi contro le mura di Costantinopoli naufragarono per il diretto intervento della Theotokos, affatto comprensiva versi gli avversari che provvide Lei direttamente ad annientare. Per mostrare il clima citiamo alcuni significativi esempi:
“Tu, la augusta che ha partorito il Signore potente e forte nelle battaglie combatti insieme a noi con la tua potente e forte mano contro i nemici che ci muovono guerra ...annienta ora con la tua mano potente o Signora l’esercito dei barbari che ci circonda. Noi prendiamo le armi insieme a te contro gli aspri nemici che ci muovono guerra; contro di loro ti facciamo muovere, o Pura, in prima linea, perché tu sei il Generale a capo dei cristiani”
“O Signora, quando Dio, che ha fatto ogni cosa esprime la sua volontà per mezzo di un cenno [comando], l’ordine naturale è vinto. Avendolo generato in modo sovrannaturale, tu puoi fare qualsiasi cosa tu voglia. Annienta pertanto completamente coloro che vogliono distruggere la tua città”.
(Giovanni Mauroso, vescovo di Eucatia) pag.94
“Facendo massacrare i nemici dalle mani dei soldati cristiani, essa schiacciò al suolo l’aggressione dei barbari e indebolì l’intero loro esercito… [L’intervento della Vergine] diede coraggio ai nostri [soldati] che conoscevano per esperienza il suo potere e credevano che sarebbe stata la Theomemetor a proteggere la città e a combattere…La vergine appariva dovunque vincendo senza difficoltà e instillando orrore e paura nei nemici. Da una parte dava forza ai sui servitori e li proteggeva da ogni danno mentre dall’altro distruggeva i nemici"
“Nella battaglia navale la Vergine, fece affondare uomini e navi assieme davanti al monastero della Blacherne. A causa di ciò l’intera insenatura [cioè il Corno d’oro] se non è troppo orribile a dirsi avrebbe potuto essere attraversata senza bagnarsi a causa dei corpi morti sparsi qua e là ...Si dimostrò chiaramente che la Vergine da sola aveva combattuto questa battaglia e ottenuta la vittoria” (Teodoro Sincello De obsidione Costantipolitana)
Conclusione
[caption id="attachment_46319" align="aligncenter" width="625"]
![]()
Mosaico della cupola del nartece interno della Monastero di Nea Moni (Chio) la Vergine si trova ritratta con i santi soldati e con i martiri[/caption]
Sia che la guerra sia stata interpretata come una battaglia contro i nemici mortali o contro i poteri incorporei del male, la Madre di Dio era quindi percepita come “Il Generale”, il comandante supremo, l’Arma invincibile (come l’arca dell’Alleanza) che inviava i suoi soldati fidati nel campo sostenendoli e incoraggiandoli negli scontri armati senza offrire quartiere all’avversario.
Nonostante ciò, diversamente dalle crociate baltiche ad esempio, tali scontri non furono mai concepiti a queste latitudini come “guerre sante”, seppure il conclamato intervento divino potesse giustificare tale affermazione. Solo l’imperatore Foca tentò, senza riuscirvi, di introdurre il concetto di guerra santa nel mondo bizantino, diversamente da San Bernardo, che, come detto, promosse l’idea della guerra del cristiano come lotta e sconfitta del male incarnato, rendendo così doveroso il malicidio.
E’ d’altronde parimenti vero che la salvezza del credente passava attraverso il sacrificio di sé anche nel contesto del mondo dell’oriente cristiano. Il sacrificio del Cristo è infatti idealmente legato al martirio dei soldati e il secondo è omologo al primo. La morte in battaglia, per spargimento di sangue, rappresenta il sacrificio per eccellenza e per questo tutti i guerrieri sono equiparati al Cristo morente sulla croce e tutte le Madri dei martiri si omologano alla Vergine sofferente, in quanto offrono i loro figli in sacrificio per la vittoria dell’imperatore sui suoi nemici che sono nemici del suo popolo devoto e soprattutto nemici di Cristo e del del suo regno rappresentato dal regnante e a anche qui le icone giustificano tale prospettiva tutta militare.
[caption id="attachment_46308" align="aligncenter" width="625"]
![]()
Questa immagine di Maria detta Pelagonitissa (con il figlio apparentemente giocoso tra le sue braccia) ha diversi esemplari cui fare riferimento ed è associata, ad esempio, nella chiesa di Staro Nagoticino a un San Giorgio tutto attrezzato per il combattimento. A questa immagine si può associare l’icona della vergine detta Akamachetos (invincibile) nella quale invece la posizione del bambino, proposto come un’offerta sul “cucchiaio eucaristico”, è drammaticamente statica mentre la Theotokos ha un’espressione di cordoglio. Entrambe le immagini, pur nella loro diversa formulazione, rappresentano la prefigurazione del futuro sacrificio cristico. Se in un’immagine il bambino è come “morto”, nella seconda invece è rappresentato smanioso e quindi affatto giocoso come se volesse sfuggire al suo ineludibile destino, l’espressione austera della Madre lo conferma. (cfr. Icone e Potere pagg. 110,127).[/caption]
Con ciò concludiamo questa breve escursione a volo d’uccello che ha voluto investire uno dei temi più “oltraggiosi” per la mentalità contemporanea, ovvero la possibile relazione esistente tra la spiritualità mariana e la guerra, consegnando all’eventuale incuriosito lettore il suggerimento di proseguire le sue ricerche su un tema che appare tanto urticante alla coscienza contemporanea quanto ineludibile, in questo momento di “cambio di pelle” del cristianesimo, profittando dell’abbondante bibliografia a disposizione, di cui qui si riproduce la parte utilizzata per l’occasione.
Bibliografia
Eric Christiansen Le crociate del Nord. Il Baltico e la frontiera cattolica (1100-1525), Il Mulino 2016
Henry Corbin: Nell’Islam iranico vol, IV, Mimesis, Milano Udine 2020
Karlheinz Dechner: Storia criminale del cristianesimo Tomo VII Ariele, 2006
Dalmazio Frau: L’armata di Dio, Simmetria, 2014, Roma
Leonardo Magini: Lo sciamano di nome Ulisse, Effigi, Arcidosso, 2019
Bissera V. Pentcheva Icone e potere, la Madre di Dio a Bisanzio, Jaca Book, Milano 2018
Silvano Panunzio: La Roma Eterna e la nuova Gerusalemme, Iduna, Roma 2019
Tania Velmans: La visione dell’invisibile, Jaca Book, 2009

 Religioso e teologo, ma anche filosofo e scienziato, si fa portatore di una visione filosofica che colloca l’ortodossia in un’ottica ben diversa da quella alla quale, il grande pubblico, è solitamente abituato a fare riferimento.
Religioso e teologo, ma anche filosofo e scienziato, si fa portatore di una visione filosofica che colloca l’ortodossia in un’ottica ben diversa da quella alla quale, il grande pubblico, è solitamente abituato a fare riferimento. oro stretta compenetrazione, Pavel Alexandrovic Florenskij, si immerge nello studio del simbolo quale particolare punto di connessione tra le due sfere, partendo proprio dall’arte e da quella sua particolare espressione data dall’iconologia. Ben lungi dall’essere astratte ed immobili espressioni pittoriche, le icone rappresentano il volto parlante del divino. I santi quali rappresentazioni ierofaniche dell’energeia/energia, divina, ci guardano e ci connettono direttamente alle sfere superne. L’Arte e l’artista si fanno, pertanto, veicolo della trasposizione della sostanza divina “ in terris”, divenendo il veicolo principe in grado di connettere l’osservatore al proprio archetipo vitale. Ma l’arte, in quanto rappresentazione visiva della realtà che ci circonda, è anche rappresentazione di ciò che a noi si manifesta, in modo incompleto, imperfetto ed illusorio. Pertanto, venendo meno al principio di non contraddizione che sovrintende a tutto il pensiero occidentale, Pavel Florensky ci mette innanzi al fatto dell’intima contradditorietà della realtà che ci circonda. Vivere ed accettare la contraddittorietà della realtà, è quanto il filosofo russo ci suggerisce, non senza, attraverso l’esercizio dell’Arte pura che attraverso la dionisiaca esaltazione dei sensi ci solleva verso le apollinee dimensioni delle forme pure, diretta espressione e manifestazione del divino.
oro stretta compenetrazione, Pavel Alexandrovic Florenskij, si immerge nello studio del simbolo quale particolare punto di connessione tra le due sfere, partendo proprio dall’arte e da quella sua particolare espressione data dall’iconologia. Ben lungi dall’essere astratte ed immobili espressioni pittoriche, le icone rappresentano il volto parlante del divino. I santi quali rappresentazioni ierofaniche dell’energeia/energia, divina, ci guardano e ci connettono direttamente alle sfere superne. L’Arte e l’artista si fanno, pertanto, veicolo della trasposizione della sostanza divina “ in terris”, divenendo il veicolo principe in grado di connettere l’osservatore al proprio archetipo vitale. Ma l’arte, in quanto rappresentazione visiva della realtà che ci circonda, è anche rappresentazione di ciò che a noi si manifesta, in modo incompleto, imperfetto ed illusorio. Pertanto, venendo meno al principio di non contraddizione che sovrintende a tutto il pensiero occidentale, Pavel Florensky ci mette innanzi al fatto dell’intima contradditorietà della realtà che ci circonda. Vivere ed accettare la contraddittorietà della realtà, è quanto il filosofo russo ci suggerisce, non senza, attraverso l’esercizio dell’Arte pura che attraverso la dionisiaca esaltazione dei sensi ci solleva verso le apollinee dimensioni delle forme pure, diretta espressione e manifestazione del divino. voler prendere le mosse da quanto l’arte occidentale ha sperimentato con gli effetti visivi della pittura fiamminga e della pittura italiana del Rinascimento, l’arte delle icone viene portata da Florensky ben oltre il raffinato, ma pur sempre, tecnicistico ambito illusionista, nella direzione di quel pensiero magico, il cui afflato ricompare tra le spire della sorgente Modernità, lasciando intravedere all’alienato individuo post moderno, delle inaspettate vie d’uscita. Quella che sembrava essere una rigida ed ingessata espressione religiosa, ora sembra voler seguire la direzione di quel pensiero magico che ha animato la Rinascenza in Italia ed in Occidente…Pavel Florensky è stato espressione vivente di quella Grande Russia, quel Continente dell’anima, a sua figlio di quella Grande Madre che è l’Asia, da cui ha attinto a piene mani l’afflato verso una forma di romantico misticismo, espressa nell’aspirazione dei panslavisti del primo Novecento, ad uno stato di mistici, di guerrieri e di contadini. Il sogno di un superuomo slavo, andrà però a fracassarsi sugli scogli dell’ottusità marxista di Stalin che, dopo aver fatto deportare il grande studioso in un Gulag , lo farà fucilare l’8 dicembre del ’37.
voler prendere le mosse da quanto l’arte occidentale ha sperimentato con gli effetti visivi della pittura fiamminga e della pittura italiana del Rinascimento, l’arte delle icone viene portata da Florensky ben oltre il raffinato, ma pur sempre, tecnicistico ambito illusionista, nella direzione di quel pensiero magico, il cui afflato ricompare tra le spire della sorgente Modernità, lasciando intravedere all’alienato individuo post moderno, delle inaspettate vie d’uscita. Quella che sembrava essere una rigida ed ingessata espressione religiosa, ora sembra voler seguire la direzione di quel pensiero magico che ha animato la Rinascenza in Italia ed in Occidente…Pavel Florensky è stato espressione vivente di quella Grande Russia, quel Continente dell’anima, a sua figlio di quella Grande Madre che è l’Asia, da cui ha attinto a piene mani l’afflato verso una forma di romantico misticismo, espressa nell’aspirazione dei panslavisti del primo Novecento, ad uno stato di mistici, di guerrieri e di contadini. Il sogno di un superuomo slavo, andrà però a fracassarsi sugli scogli dell’ottusità marxista di Stalin che, dopo aver fatto deportare il grande studioso in un Gulag , lo farà fucilare l’8 dicembre del ’37.

































 La Pizia prediceva un futuro che può essere cambiato, invece la Sibilla un futuro che non può essere cambiato, cioè disgrazie volute da qualche dio. Nel Libro I degli Oracoli Sibillini, vv. 1-4, è scritto che la Sibilla profetizzò cose del passato, che sono ora e che saranno nel futuro per via della empietà degli uomini. La Sibilla sta nel mondo pagano e in quello ebraico e cristiano fino al Medioevo. Nel primo parlava ispirata solitamente da Apollo, invece in quello ebraico e cristiano ispirata da YHWH, il Dio della Bibbia. Pensiamo solo alla Sibilla Cumana, ma ve ne erano molte altre. La Pizia stava a Delfi. A Delfi vi era un santuario panellenico, cioè visitato da tutta la Grecia antica, dedicato al dio Apollo. Sotto il tempio di Apollo, annesso al santuario, vi era un ipogeo nel quale stava la Pizia sopra un tripode, la quale era una donna che sentiva i messaggio del dio. Chi voleva fare una richiesta al dio, andava dalla Pizia in questo tempio. Costui faceva delle abluzioni, pagava una somma, faceva dei sacrifici. Formulava la richiesta alla Pizia, la Pizia sentiva il dio da un pozzo e dava il responso, il quale veniva trascritto dal sacerdote. Mentre la Pizia interrogava Apollo, la Sibilla ne era invasata e parlava in stato estatico.
La Pizia prediceva un futuro che può essere cambiato, invece la Sibilla un futuro che non può essere cambiato, cioè disgrazie volute da qualche dio. Nel Libro I degli Oracoli Sibillini, vv. 1-4, è scritto che la Sibilla profetizzò cose del passato, che sono ora e che saranno nel futuro per via della empietà degli uomini. La Sibilla sta nel mondo pagano e in quello ebraico e cristiano fino al Medioevo. Nel primo parlava ispirata solitamente da Apollo, invece in quello ebraico e cristiano ispirata da YHWH, il Dio della Bibbia. Pensiamo solo alla Sibilla Cumana, ma ve ne erano molte altre. La Pizia stava a Delfi. A Delfi vi era un santuario panellenico, cioè visitato da tutta la Grecia antica, dedicato al dio Apollo. Sotto il tempio di Apollo, annesso al santuario, vi era un ipogeo nel quale stava la Pizia sopra un tripode, la quale era una donna che sentiva i messaggio del dio. Chi voleva fare una richiesta al dio, andava dalla Pizia in questo tempio. Costui faceva delle abluzioni, pagava una somma, faceva dei sacrifici. Formulava la richiesta alla Pizia, la Pizia sentiva il dio da un pozzo e dava il responso, il quale veniva trascritto dal sacerdote. Mentre la Pizia interrogava Apollo, la Sibilla ne era invasata e parlava in stato estatico. Per questo ha fatto grande scalpore la ipotetica questione dei “versi satanici” del Corano. La leggenda narra che nella sura 53 (ai versi 19, 20 e in quello successivo, che sarebbe presente nei manoscritti più antichi del Corano ma espunto dagli ortodossi) Maometto fu ispirato non da Dio ma da Satana nel cantare la lode di tre dee pagane preislamiche, Allat, ‘Uzza, Manat, che erano sorelle di Allah, il dio pagano del pantheon arabo. I testi sacri sono la testimonianza di come le parole degli dei siano state considerate moltissimo nella storia di un dato popolo sacro. A volte ripetute per millenni, come i Veda, i testi sacri dell’induismo. Per trasmetterli invariati per moltissimo tempo sono state create delle tecniche apposite di recitazione: saṃhitapāṭha (con le modificazioni tra parole), padapāṭha (con parole isolate), le vikṛti (con gruppi di parole). La Bibbia ebraica ha precisi sistemi per la cantillazione che sono aggiunti al testo. Qualcosa di analogo succede anche per il Corano (lo studio della recitazione cantata del Corano è detto tajwid). Per molte tradizioni indiane i Veda sono la più importante rivelazione, avuta per intuizione-visione dai Rishi, anche se nessun testo si sofferma sulle modalità di questa conoscenza iniziale. L’attività creativa dei Rishi viene descritta dalla radice DHI, che indica sia il vedere sia il pensare: in questo modo i Rishi forse non creavano da soli le immagini poetiche ma “vedevano” quelle trasmesse loro dagli dei e che i comuni mortali non vedono (1).
Per questo ha fatto grande scalpore la ipotetica questione dei “versi satanici” del Corano. La leggenda narra che nella sura 53 (ai versi 19, 20 e in quello successivo, che sarebbe presente nei manoscritti più antichi del Corano ma espunto dagli ortodossi) Maometto fu ispirato non da Dio ma da Satana nel cantare la lode di tre dee pagane preislamiche, Allat, ‘Uzza, Manat, che erano sorelle di Allah, il dio pagano del pantheon arabo. I testi sacri sono la testimonianza di come le parole degli dei siano state considerate moltissimo nella storia di un dato popolo sacro. A volte ripetute per millenni, come i Veda, i testi sacri dell’induismo. Per trasmetterli invariati per moltissimo tempo sono state create delle tecniche apposite di recitazione: saṃhitapāṭha (con le modificazioni tra parole), padapāṭha (con parole isolate), le vikṛti (con gruppi di parole). La Bibbia ebraica ha precisi sistemi per la cantillazione che sono aggiunti al testo. Qualcosa di analogo succede anche per il Corano (lo studio della recitazione cantata del Corano è detto tajwid). Per molte tradizioni indiane i Veda sono la più importante rivelazione, avuta per intuizione-visione dai Rishi, anche se nessun testo si sofferma sulle modalità di questa conoscenza iniziale. L’attività creativa dei Rishi viene descritta dalla radice DHI, che indica sia il vedere sia il pensare: in questo modo i Rishi forse non creavano da soli le immagini poetiche ma “vedevano” quelle trasmesse loro dagli dei e che i comuni mortali non vedono (1). Gli dissero i suoi fratelli: ‘Parti di qua e va’ nella Giudea così che anche i tuoi discepoli vedano le opere che fai. Nessuno infatti agisce nel segreto, e cerca egli stesso di mettersi in mostra. Se tu fai queste cose, manifèstati al mondo’ “. Il verbo greco periepatei significa precisamente “girovagava” e indica che Cristo era un profeta itinerante. La festa delle Capanne era una festa di pellegrinaggio, assieme alla Pasqua e alla Pentecoste: gli ebrei dovevano recarsi con il clan familiare a Gerusalemme (i cosiddetti “fratelli”). Giovanni 7, 8: “Salite voi alla festa. Io non salgo …”. Ma ci andrà di nascosto. Gli ebrei dicono ancora oggi “salire a Gerusalemme” sia perché la città è in alto sia perché è il luogo più alto della terra, in cui vi è la Presenza di Dio. Nella Festa delle Capanne (che dura 7/8 giorni) l’ebro pio ancora oggi costruisce una tenda, nella quale deve pernottare: il tetto deve essere fatto di palmizi di modo che, all’interno della tenda, si possano vedere le stelle. La festa ricorda il popolo ebraico nel passaggio nel deserto, quando esso dormiva nelle tende e lo faceva anche Dio. In quell’accampamento la tenda più importante era la Dimora nella quale era posta l’Arca dell’Alleanza in cui scendeva Dio in una nube e accompagnava il popolo nel viaggio nel deserto. Dio si fa pellegrino tra i pellegrini umani, entra nella storia e nella sofferenza degli uomini. In questa storia si manifesta Dio e il suo Messia, che per i cattolici sono la stessa cosa. Giovanni 1, 14: “E il Verbo si fece carne e abitò tra noi e vedemmo la sua Gloria”: il verbo greco eskēnōsen significa precisamente non solo abitare ma mettere la tenda (skēnē). Cristo entra nella nostra tenda e in essa noi vediamo la sua Nube di Gloria: Egli è il Dio degli ebrei e di tutti gli uomini.
Gli dissero i suoi fratelli: ‘Parti di qua e va’ nella Giudea così che anche i tuoi discepoli vedano le opere che fai. Nessuno infatti agisce nel segreto, e cerca egli stesso di mettersi in mostra. Se tu fai queste cose, manifèstati al mondo’ “. Il verbo greco periepatei significa precisamente “girovagava” e indica che Cristo era un profeta itinerante. La festa delle Capanne era una festa di pellegrinaggio, assieme alla Pasqua e alla Pentecoste: gli ebrei dovevano recarsi con il clan familiare a Gerusalemme (i cosiddetti “fratelli”). Giovanni 7, 8: “Salite voi alla festa. Io non salgo …”. Ma ci andrà di nascosto. Gli ebrei dicono ancora oggi “salire a Gerusalemme” sia perché la città è in alto sia perché è il luogo più alto della terra, in cui vi è la Presenza di Dio. Nella Festa delle Capanne (che dura 7/8 giorni) l’ebro pio ancora oggi costruisce una tenda, nella quale deve pernottare: il tetto deve essere fatto di palmizi di modo che, all’interno della tenda, si possano vedere le stelle. La festa ricorda il popolo ebraico nel passaggio nel deserto, quando esso dormiva nelle tende e lo faceva anche Dio. In quell’accampamento la tenda più importante era la Dimora nella quale era posta l’Arca dell’Alleanza in cui scendeva Dio in una nube e accompagnava il popolo nel viaggio nel deserto. Dio si fa pellegrino tra i pellegrini umani, entra nella storia e nella sofferenza degli uomini. In questa storia si manifesta Dio e il suo Messia, che per i cattolici sono la stessa cosa. Giovanni 1, 14: “E il Verbo si fece carne e abitò tra noi e vedemmo la sua Gloria”: il verbo greco eskēnōsen significa precisamente non solo abitare ma mettere la tenda (skēnē). Cristo entra nella nostra tenda e in essa noi vediamo la sua Nube di Gloria: Egli è il Dio degli ebrei e di tutti gli uomini.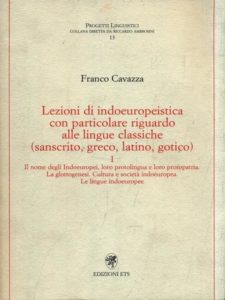 Il latino deus pare collegato alla radice indoeuropea *DEYW, legata all’idea della luce, donde anche dies, “giorno”. Il germanico Gott, god sembra associato a un’altra radice indoeuropea che veicola l’idea della bontà. Il termine nelle lingue slave deriva dalla radice indoeuropea *BHAG, “spartire”. Nelle lingue semitiche abbiamo la radice semitica che ha dato l’ebraico ‘El, ‘Elohim. Il termine arabo Allah (che non è il nome proprio di una divinità, come Zeus, ma indica il concetto generale di Dio) sarebbe derivato da quella radice con all’inizio l’articolo determinativo arabo al: Allah allora significherebbe “il dio”, Iddio. Alla base della radice semitica c’è l’idea della forza. Gli dei greci hanno a che fare con la vista: thea è “dea” in eolico (mentre in attico theos è sia maschile sia femminile) ma significa anche “visione”. Per i Greci vedere è sapere. Erano per questo detti “popolo dell’occhio”. La parola adēlon, “invisibile”, è usata dai Greci con molta parsimonia fino a Platone, in Omero compare una sola volta. I Greci aborrono l’invisibile come sinonimo di incertezza, male(4). La caratteristica degli dei omerici è quella di essere potenze e non persone, ragion per cui essi appaiono in un modo che nell’orizzonte percettivo dell’essere umano pare avere un senso coerente (quando l’eroe ferisce Afrodite, scaturisce dal corpo di lei dell’umore: Iliade V, 330-343), ma questa identità non è la sola. “Dietro la presenza degli dei aleggia sì l’immagine di splendidi esseri in forma umana, una sorta di presupposto ideale che li rende raffigurabili sulla superficie di un vaso o fa sì che il poeta possa descriverne le meravigliose apparenze; ma si è contemporaneamente ben consapevoli del fatto che il dio è altrettanto sé stesso anche quando si manifesta in forme mortali, animali, atmosferiche, o semplicemente attraverso segni e barlumi, ovvero non si manifesta affatto. Ed è proprio in questa molteplicità identitaria, nel poter essere serialmente molti, non uno solo – sé stessi e altri da sé – che risiede il privilegio divino” (5).
Il latino deus pare collegato alla radice indoeuropea *DEYW, legata all’idea della luce, donde anche dies, “giorno”. Il germanico Gott, god sembra associato a un’altra radice indoeuropea che veicola l’idea della bontà. Il termine nelle lingue slave deriva dalla radice indoeuropea *BHAG, “spartire”. Nelle lingue semitiche abbiamo la radice semitica che ha dato l’ebraico ‘El, ‘Elohim. Il termine arabo Allah (che non è il nome proprio di una divinità, come Zeus, ma indica il concetto generale di Dio) sarebbe derivato da quella radice con all’inizio l’articolo determinativo arabo al: Allah allora significherebbe “il dio”, Iddio. Alla base della radice semitica c’è l’idea della forza. Gli dei greci hanno a che fare con la vista: thea è “dea” in eolico (mentre in attico theos è sia maschile sia femminile) ma significa anche “visione”. Per i Greci vedere è sapere. Erano per questo detti “popolo dell’occhio”. La parola adēlon, “invisibile”, è usata dai Greci con molta parsimonia fino a Platone, in Omero compare una sola volta. I Greci aborrono l’invisibile come sinonimo di incertezza, male(4). La caratteristica degli dei omerici è quella di essere potenze e non persone, ragion per cui essi appaiono in un modo che nell’orizzonte percettivo dell’essere umano pare avere un senso coerente (quando l’eroe ferisce Afrodite, scaturisce dal corpo di lei dell’umore: Iliade V, 330-343), ma questa identità non è la sola. “Dietro la presenza degli dei aleggia sì l’immagine di splendidi esseri in forma umana, una sorta di presupposto ideale che li rende raffigurabili sulla superficie di un vaso o fa sì che il poeta possa descriverne le meravigliose apparenze; ma si è contemporaneamente ben consapevoli del fatto che il dio è altrettanto sé stesso anche quando si manifesta in forme mortali, animali, atmosferiche, o semplicemente attraverso segni e barlumi, ovvero non si manifesta affatto. Ed è proprio in questa molteplicità identitaria, nel poter essere serialmente molti, non uno solo – sé stessi e altri da sé – che risiede il privilegio divino” (5).









 Recentemente le indagini in campo antropologico hanno accertato fin nella protostoria dell’uomo gli innumerevoli esempi evidenziati come possibili prove atte a confermare una indiscutibile antichissima provenienza da cui sarebbe derivata la ricca aneddotica che ha finito per tipicizzare l’uomo silvestre. Tali considerazioni supportano le lontane origini di questo personaggio che in veste di compagno di strada, come un’ombra ha seguito l’evoluzione dell’umanità fin dai suoi albori.
Recentemente le indagini in campo antropologico hanno accertato fin nella protostoria dell’uomo gli innumerevoli esempi evidenziati come possibili prove atte a confermare una indiscutibile antichissima provenienza da cui sarebbe derivata la ricca aneddotica che ha finito per tipicizzare l’uomo silvestre. Tali considerazioni supportano le lontane origini di questo personaggio che in veste di compagno di strada, come un’ombra ha seguito l’evoluzione dell’umanità fin dai suoi albori.


 La tradizione religiosa del buon anacoreta è proseguita fino al XIX° sec. grazie alla presenza dei remet (eremita), laici o terziari di ordini mendicanti. Vivevano da scapoli, anziani e in solitudine, in uno stato di estrema povertà, esercitando la custodia dei santuari sparsi nella campagna. Si muovevano “andando a capo scoperto e a piedi scalzi ostentando una barba lunga e incolta. Facevano inoltre aspre penitenze e venivano tenuti in concetto di santità... alcuni si specializzavano nella raccolta di erbe medicinali dalle quali traevano misture e decotti” (M. Lunghi, L’ambiente sociale della cascina cremasca, in Gruppo Antropologico Cremasco - La Cascina Cremasca, Crema, 1987).
La tradizione religiosa del buon anacoreta è proseguita fino al XIX° sec. grazie alla presenza dei remet (eremita), laici o terziari di ordini mendicanti. Vivevano da scapoli, anziani e in solitudine, in uno stato di estrema povertà, esercitando la custodia dei santuari sparsi nella campagna. Si muovevano “andando a capo scoperto e a piedi scalzi ostentando una barba lunga e incolta. Facevano inoltre aspre penitenze e venivano tenuti in concetto di santità... alcuni si specializzavano nella raccolta di erbe medicinali dalle quali traevano misture e decotti” (M. Lunghi, L’ambiente sociale della cascina cremasca, in Gruppo Antropologico Cremasco - La Cascina Cremasca, Crema, 1987).

 Tale nome, per la legge della traslitterazione linguistica, nelle lingue nordiche perde la lettera W iniziale, la lettera T si indurisce in una D, la A diventa una I e la N finale si raddoppia. Otteniamo così in old-norse "Odinn" - Odino appunto. Odino è figlio di due giganti primordiali (che in norreno vengono definiti con la parola Jotunn al singolare, e Jotnar al plurale) di nome Borr e Bestla. Suo zio è Mimir, custode della fonte del ricordo e della conoscenza. Ma Odino non appartiene alla stirpe dei giganti, è un dio, un Ase (al plurale Asi). Insieme a lui, fanno parte della triade divina primigenia i suoi fratelli Vili e Vè. Insieme costituiscono tre concetti dalla portata enorme: "Furore, Volontà e Potenza". Nel mito, durante le fasi iniziali dell'ordinamento del cosmo, Odino (con l'aiuto di Loki, che è anch'egli uno Jotunn e detiene i segreti del fuoco e sul quale andrebbe fatto un discorso a parte) guida la rivolta degli Asi contro gli Jotnar che culmina con lo smembramento del corpo di Ymyr, il gigante primordiale. Dal cranio ne ricaveranno la volta celeste, dal cervello le nuvole, dalle ossa le montagne, dal sangue i mari e i fiumi, dai capelli le foreste e via così. E' l'atto dello stabilire il principio di un nuovo ordinamento sul caos iniziale. Successivamente, Odino, Vili e Vè mentre passeggiano sulla spiaggia al limitare del mondo appena realizzato, trovano un tronco di frassino e uno di betulla, ai quali donano i sensi, la ragione, lo spirito e il calore vitale. Li chiamano Askr ed Embla, il primo uomo e la prima donna. Li pongono nella terra di mezzo (Midgard), costruiscono un ponte arcobaleno che la collega con il mondo superiore e prendono dimora in Asgard (la terra degli Asi). Un nuovo e armonico ordine è stato stabilito e Odino si configura già come "Allfodr" (uno dei suoi numerosi appellativi), il "padre di tutti", mortali e dèi. Ma durante il suo regno, Odino non resterà mai fermo. Continua tenacemente a fare esperienze che lo accrescono, è alla costante ricerca della Conoscenza. Travestito da viandante con mantello grigio, cappello a punta e bastone (vi ricorda qualcuno?) viaggia in tutti i nove mondi conosciuti sorretti dall'Yggdrasill, l'albero del cosmo e asse dell'universo, e anche oltre come poi vedremo quando conquisterà le "Rune". Diviene così il dio dei viaggi, dei travestimenti, dell'inganno (al fine di estorcere il sapere da chi incontra), della guerra, della poesia, della magia e dell'ispirazione. E l'elenco sarebbe ancora lungo... Ad ogni esperienza che matura con sacrifico, dolore e dedizione (perché mai nulla è gratis, soprattutto sul piano spirituale) conquista un nome in più, che germoglia in lui donandogli la potenza, le capacità e la funzione che ogni nuovo nome esprime. Diviene così "il Terribile", "il Padre della Vittoria", "il Mascherato", "Barba Grigia", "il Possente Vate", "il dio dalla Potenza Magica", "Colui che acceca gli eserciti" e via dicendo.
Tale nome, per la legge della traslitterazione linguistica, nelle lingue nordiche perde la lettera W iniziale, la lettera T si indurisce in una D, la A diventa una I e la N finale si raddoppia. Otteniamo così in old-norse "Odinn" - Odino appunto. Odino è figlio di due giganti primordiali (che in norreno vengono definiti con la parola Jotunn al singolare, e Jotnar al plurale) di nome Borr e Bestla. Suo zio è Mimir, custode della fonte del ricordo e della conoscenza. Ma Odino non appartiene alla stirpe dei giganti, è un dio, un Ase (al plurale Asi). Insieme a lui, fanno parte della triade divina primigenia i suoi fratelli Vili e Vè. Insieme costituiscono tre concetti dalla portata enorme: "Furore, Volontà e Potenza". Nel mito, durante le fasi iniziali dell'ordinamento del cosmo, Odino (con l'aiuto di Loki, che è anch'egli uno Jotunn e detiene i segreti del fuoco e sul quale andrebbe fatto un discorso a parte) guida la rivolta degli Asi contro gli Jotnar che culmina con lo smembramento del corpo di Ymyr, il gigante primordiale. Dal cranio ne ricaveranno la volta celeste, dal cervello le nuvole, dalle ossa le montagne, dal sangue i mari e i fiumi, dai capelli le foreste e via così. E' l'atto dello stabilire il principio di un nuovo ordinamento sul caos iniziale. Successivamente, Odino, Vili e Vè mentre passeggiano sulla spiaggia al limitare del mondo appena realizzato, trovano un tronco di frassino e uno di betulla, ai quali donano i sensi, la ragione, lo spirito e il calore vitale. Li chiamano Askr ed Embla, il primo uomo e la prima donna. Li pongono nella terra di mezzo (Midgard), costruiscono un ponte arcobaleno che la collega con il mondo superiore e prendono dimora in Asgard (la terra degli Asi). Un nuovo e armonico ordine è stato stabilito e Odino si configura già come "Allfodr" (uno dei suoi numerosi appellativi), il "padre di tutti", mortali e dèi. Ma durante il suo regno, Odino non resterà mai fermo. Continua tenacemente a fare esperienze che lo accrescono, è alla costante ricerca della Conoscenza. Travestito da viandante con mantello grigio, cappello a punta e bastone (vi ricorda qualcuno?) viaggia in tutti i nove mondi conosciuti sorretti dall'Yggdrasill, l'albero del cosmo e asse dell'universo, e anche oltre come poi vedremo quando conquisterà le "Rune". Diviene così il dio dei viaggi, dei travestimenti, dell'inganno (al fine di estorcere il sapere da chi incontra), della guerra, della poesia, della magia e dell'ispirazione. E l'elenco sarebbe ancora lungo... Ad ogni esperienza che matura con sacrifico, dolore e dedizione (perché mai nulla è gratis, soprattutto sul piano spirituale) conquista un nome in più, che germoglia in lui donandogli la potenza, le capacità e la funzione che ogni nuovo nome esprime. Diviene così "il Terribile", "il Padre della Vittoria", "il Mascherato", "Barba Grigia", "il Possente Vate", "il dio dalla Potenza Magica", "Colui che acceca gli eserciti" e via dicendo. le Rune (le chiavi di accesso alle leggi dell'Esistenza) e il Mjollnir, il martello del dio Thor (arma usata per difendere l'ordine dal caos e simbolo di fertilità). Infine tornerà dal regno dei morti Baldr, figlio solare e luminoso di Odino che detiene i segreti delle Rune. Lo so che stiamo andando parecchio per le lunghe, ma ci siamo quasi. Fate ancora un piccolo sforzo e seguitemi fino alla fine.ì Anzi, stringiamo proprio: il terzo evento assolutamente da tenere in considerazione è proprio la morte di Baldr, figlio di Odino e divinità solare, che viene ucciso tramite un inganno ad opera di Loki. Non riuscendo in nessun modo a farselo restituire da Hel (colei che regna nel mondo di sotto), Odino prima di incendiare la prima funebre sussurra nell'orecchio del figlio i segreti delle Rune che nessuno può udire, perché sa (grazie alle profezie della veggente) che Baldr tornerà per governare nella prossima Era. Ed eccoci finalmente giunti a quello che può essere considerato il vero cuore sciamanico, iniziatico ed esoterico di tutta la mitologia nordica: la conquista delle Rune da parte di Odino tramite auto-impiccagione rituale. Ci troviamo di fronte ad uno degli argomenti - quello delle Rune - più controverso, bistrattato e desacralizato in assoluto negli ultimi anni da parte di filologi, newager, santoni improvvisati e sciamani dell'ultimo minuto. Ormai abbiamo visto di tutto, mancano solo le Rune aromatizzate all'origano per condire le pizze del Conad e siamo al completo. Purtroppo non confido che il trend migliori, ma, a maggior ragione, diventa nostro compito occuparci di divulgare correttamente il mito, perché il mito è la porta d'accesso ad una conoscenza superiore. Cosa che, detta francamente, in effetti potrebbe aiutarci a migliorarci molto come esseri umani e Uomini.
le Rune (le chiavi di accesso alle leggi dell'Esistenza) e il Mjollnir, il martello del dio Thor (arma usata per difendere l'ordine dal caos e simbolo di fertilità). Infine tornerà dal regno dei morti Baldr, figlio solare e luminoso di Odino che detiene i segreti delle Rune. Lo so che stiamo andando parecchio per le lunghe, ma ci siamo quasi. Fate ancora un piccolo sforzo e seguitemi fino alla fine.ì Anzi, stringiamo proprio: il terzo evento assolutamente da tenere in considerazione è proprio la morte di Baldr, figlio di Odino e divinità solare, che viene ucciso tramite un inganno ad opera di Loki. Non riuscendo in nessun modo a farselo restituire da Hel (colei che regna nel mondo di sotto), Odino prima di incendiare la prima funebre sussurra nell'orecchio del figlio i segreti delle Rune che nessuno può udire, perché sa (grazie alle profezie della veggente) che Baldr tornerà per governare nella prossima Era. Ed eccoci finalmente giunti a quello che può essere considerato il vero cuore sciamanico, iniziatico ed esoterico di tutta la mitologia nordica: la conquista delle Rune da parte di Odino tramite auto-impiccagione rituale. Ci troviamo di fronte ad uno degli argomenti - quello delle Rune - più controverso, bistrattato e desacralizato in assoluto negli ultimi anni da parte di filologi, newager, santoni improvvisati e sciamani dell'ultimo minuto. Ormai abbiamo visto di tutto, mancano solo le Rune aromatizzate all'origano per condire le pizze del Conad e siamo al completo. Purtroppo non confido che il trend migliori, ma, a maggior ragione, diventa nostro compito occuparci di divulgare correttamente il mito, perché il mito è la porta d'accesso ad una conoscenza superiore. Cosa che, detta francamente, in effetti potrebbe aiutarci a migliorarci molto come esseri umani e Uomini.
 Nonostante ciò bisogna ammettere che la medusa del Garbati è effettivamente un’opera d’arte, ciò è indiscutibile: riflette i movimenti di pensiero dell’epoca contemporanea, tecnicamente espone bene l’anatomia di un corpo che dopo un atto di sforzo cerca il riposo; i serpenti malvagi divengono una capigliatura morbida, il sesso scompare come a voler significare la sessualità perduta delle donne che hanno subito abusi, l’intera posa esprime la raggiunta soddisfazione per la vendetta ottenuta. Chiaramente il lavoro di Garbati si rivolge ad un mondo che ha perduto il valore del mito, anzi a malapena lo conosce e quando ne sente parlare ne riceve comunicazioni alterate. Sono numerosi infatti i testi neopagani scritti da autori profani, negli Stati Uniti d’America, che cercano di interpretare la sacralità antica cogliendo cantonate incredibili e distribuendole come interpretazioni valide ed accettabili. Tra queste va per la maggiore l’idea che molti miti rappresentino l’affermazione di società patriarcali a discapito di precedenti società matriarcali. Ovviamente tutto ciò si discosta fortemente dalla realtà storica e dai valori intrinseci del mito. Innanzitutto l’eredità di una società patriarcale ottocentesca deriva da secoli di cristianesimo, religione che nell’imporsi ha dettato nuovi comportamenti sociali, molti dei quali giustificati dalla misoginia di alcuni suoi scritti, atteggiamenti che entrarono in conflitto con la società antica, che invece dava alle donne ruoli ben diversi da quelli raccontati: basti pensare ai numerosi sacerdozi femminili del mondo antico, ai ruoli di numerose poetesse, filosofe e scienziate del mondo antico, di cui poco sappiamo a causa di una damnatio memoriae nei riguardi dei ruoli femminili applicata proprio dalle nuove società cristiane.
Nonostante ciò bisogna ammettere che la medusa del Garbati è effettivamente un’opera d’arte, ciò è indiscutibile: riflette i movimenti di pensiero dell’epoca contemporanea, tecnicamente espone bene l’anatomia di un corpo che dopo un atto di sforzo cerca il riposo; i serpenti malvagi divengono una capigliatura morbida, il sesso scompare come a voler significare la sessualità perduta delle donne che hanno subito abusi, l’intera posa esprime la raggiunta soddisfazione per la vendetta ottenuta. Chiaramente il lavoro di Garbati si rivolge ad un mondo che ha perduto il valore del mito, anzi a malapena lo conosce e quando ne sente parlare ne riceve comunicazioni alterate. Sono numerosi infatti i testi neopagani scritti da autori profani, negli Stati Uniti d’America, che cercano di interpretare la sacralità antica cogliendo cantonate incredibili e distribuendole come interpretazioni valide ed accettabili. Tra queste va per la maggiore l’idea che molti miti rappresentino l’affermazione di società patriarcali a discapito di precedenti società matriarcali. Ovviamente tutto ciò si discosta fortemente dalla realtà storica e dai valori intrinseci del mito. Innanzitutto l’eredità di una società patriarcale ottocentesca deriva da secoli di cristianesimo, religione che nell’imporsi ha dettato nuovi comportamenti sociali, molti dei quali giustificati dalla misoginia di alcuni suoi scritti, atteggiamenti che entrarono in conflitto con la società antica, che invece dava alle donne ruoli ben diversi da quelli raccontati: basti pensare ai numerosi sacerdozi femminili del mondo antico, ai ruoli di numerose poetesse, filosofe e scienziate del mondo antico, di cui poco sappiamo a causa di una damnatio memoriae nei riguardi dei ruoli femminili applicata proprio dalle nuove società cristiane. Dunque non esisteva nella teologia dei culti antichi la predominanza di un genere su di un altro, bensì si raccontava più e più volte della coesistenza dei generi e dell’unione di essi. Le sopravvivenze culturali del mondo antico, nel corso dei tempi dell’era cristiana, si manifestano nelle cosiddette scienze ermetiche ed alchemiche, dove l’obiettivo del “filosofo” praticante è quello di ritornare alla Monade riconquistando la condizione dell’androginia primordiale, frutto dell’incontro del maschio con la femmina, del Re con la Regina, del Sole con la Luna, dell’oro con l’argento, ossia dello spirito con l’anima. Ovviamente la mitologia antica era il sistema teologico di base, con il quale si cercavano di dare una serie di profondi insegnamenti etici, che celava importanti misteri relativi alla realizzazione spirituale dell’essere umano. Essa però necessitava di uno strumento fondamentale: l’interpretazione. Tramite essa si potevano conquistare le comprensioni di atteggiamenti e riti che consentissero il raggiungimento dell’aspirata realizzazione spirituale. Platone dedica particolare attenzione a questo strumento, definendolo utile e valido nel momento in cui diveniva “esoterico”, ossia quando si applicava una lettura che entrasse nel profondo e non rimanesse nell’esterno.
Dunque non esisteva nella teologia dei culti antichi la predominanza di un genere su di un altro, bensì si raccontava più e più volte della coesistenza dei generi e dell’unione di essi. Le sopravvivenze culturali del mondo antico, nel corso dei tempi dell’era cristiana, si manifestano nelle cosiddette scienze ermetiche ed alchemiche, dove l’obiettivo del “filosofo” praticante è quello di ritornare alla Monade riconquistando la condizione dell’androginia primordiale, frutto dell’incontro del maschio con la femmina, del Re con la Regina, del Sole con la Luna, dell’oro con l’argento, ossia dello spirito con l’anima. Ovviamente la mitologia antica era il sistema teologico di base, con il quale si cercavano di dare una serie di profondi insegnamenti etici, che celava importanti misteri relativi alla realizzazione spirituale dell’essere umano. Essa però necessitava di uno strumento fondamentale: l’interpretazione. Tramite essa si potevano conquistare le comprensioni di atteggiamenti e riti che consentissero il raggiungimento dell’aspirata realizzazione spirituale. Platone dedica particolare attenzione a questo strumento, definendolo utile e valido nel momento in cui diveniva “esoterico”, ossia quando si applicava una lettura che entrasse nel profondo e non rimanesse nell’esterno. Perseo deve avvalersi del cavallo Pegaso, che può nascere solo dal sangue della Medusa. Quest’ultima era una fanciulla vergine devota di Minerva, alla quale chiese di avere la Sapienza: la Dea la accontentò inviandole il Dio Nettuno, il quale le avrebbe trasmesso il sapere del mondo con un atto d’amore, ma la giovane gorgone non comprese che tutto ciò era il risultato di quanto lei aveva chiesto alla Dea bensì pensò che tutto stesse accadendo per un desiderio illecito del dio del mare, così la ragazza corse nel tempio, presso la Dea, per chiederle di fermare gli ardori amorosi del Dio. Purtroppo ciò creò una hybris, perché senza rendersene conto la ragazza credeva di sapere meglio della Dea cosa stesse accadendo, voleva mettere una divinità contro l’altra, e peccò di ingenuità: infatti richiesta la Sapienza, ebbe la presunzione di immaginare lei come dovesse avvenirne l’acquisizione, ponendosi inconsciamente al di sopra della divinità. Tutta questa incoscienza dimostra che Medusa chiese il “sapere” quando ancora non era pronta per riceverlo, dunque fu “tracotante”, e tale carenza di preparazione si dimostrò quando la ragazza ebbe paura di Nettuno. Lì sta la hybris di Medusa, nell’aver voluto tutto e subito. Questi sentimenti espressi nel comportamento di Medusa avvengono all’interno della persona: ma se tramite il proprio spirito (Perseo) si taglia la testa alla Medusa (il prodotto mostruoso di chi riceve un sapere quando ancora non ne è degno ed oltretutto disegna quanto ricevuto, creando una serie di pensieri errati rappresentati dai serpenti al posto dei capelli), allora si ottiene il cavallo alato, ossia lo strumento intellettivo che consente di vivere un Eros (che non significa sesso come insegnano i moderni, ma Amore che coinvolge tutti i corpi dell’individuo: fisico, animico, intellettivo, spirituale) sano capace di farci ascendere nei cieli. Grazie al Pegaso lo spirito dell’eroe può raggiungere l’incatenata anima pura e liberarla dal mostro delle acque (passioni) comuni. Il mostro può essere pietrificato dal mostrare la testa della gorgone decapitata: significa che l’individuo che uccide i moti passionali della tracotanza egoica e della confusione animica, non si lascia tangere dal pensiero collettivo volgare ed evita che esso divori la sua anima.
Perseo deve avvalersi del cavallo Pegaso, che può nascere solo dal sangue della Medusa. Quest’ultima era una fanciulla vergine devota di Minerva, alla quale chiese di avere la Sapienza: la Dea la accontentò inviandole il Dio Nettuno, il quale le avrebbe trasmesso il sapere del mondo con un atto d’amore, ma la giovane gorgone non comprese che tutto ciò era il risultato di quanto lei aveva chiesto alla Dea bensì pensò che tutto stesse accadendo per un desiderio illecito del dio del mare, così la ragazza corse nel tempio, presso la Dea, per chiederle di fermare gli ardori amorosi del Dio. Purtroppo ciò creò una hybris, perché senza rendersene conto la ragazza credeva di sapere meglio della Dea cosa stesse accadendo, voleva mettere una divinità contro l’altra, e peccò di ingenuità: infatti richiesta la Sapienza, ebbe la presunzione di immaginare lei come dovesse avvenirne l’acquisizione, ponendosi inconsciamente al di sopra della divinità. Tutta questa incoscienza dimostra che Medusa chiese il “sapere” quando ancora non era pronta per riceverlo, dunque fu “tracotante”, e tale carenza di preparazione si dimostrò quando la ragazza ebbe paura di Nettuno. Lì sta la hybris di Medusa, nell’aver voluto tutto e subito. Questi sentimenti espressi nel comportamento di Medusa avvengono all’interno della persona: ma se tramite il proprio spirito (Perseo) si taglia la testa alla Medusa (il prodotto mostruoso di chi riceve un sapere quando ancora non ne è degno ed oltretutto disegna quanto ricevuto, creando una serie di pensieri errati rappresentati dai serpenti al posto dei capelli), allora si ottiene il cavallo alato, ossia lo strumento intellettivo che consente di vivere un Eros (che non significa sesso come insegnano i moderni, ma Amore che coinvolge tutti i corpi dell’individuo: fisico, animico, intellettivo, spirituale) sano capace di farci ascendere nei cieli. Grazie al Pegaso lo spirito dell’eroe può raggiungere l’incatenata anima pura e liberarla dal mostro delle acque (passioni) comuni. Il mostro può essere pietrificato dal mostrare la testa della gorgone decapitata: significa che l’individuo che uccide i moti passionali della tracotanza egoica e della confusione animica, non si lascia tangere dal pensiero collettivo volgare ed evita che esso divori la sua anima.









 Chi si discosta dal pensiero conformistico dell’umanità-gregge è considerato un folle da emarginare ed isolare socialmente. E ancora: “Noi siamo assennati e sappiamo tutto ciò che è avvenuto; abbiamo dunque diritto d’irridere ogni cosa. […] Si hanno i propri svaghi del giorno, e quelli della notte; ma si tiene in gran conto la salute”. L’Ultimo uomo ha particolarmente cara la salute. Come non riconoscere in questa immagine l’attuale ossessione del genere umano per il contagio da Covid? Il suo rinunciare a diritti e libertà, fino a pochi mesi fa percepiti come intoccabili, in nome di un’immaginaria purezza? L’Ultimo uomo è colui che secondo Zarathustra, la voce narrante dietro cui si nasconde il filosofo tedesco, pensa di aver inventato la felicità. Egli è felice della sua pochezza e mediocrità, si accontenta di svaghi illusori e salutismo e non sa più “generare una stella danzante”, non sa più “che cos’è amore, che cos’è creazione, che cos’è brama, che cos’è un astro”. Nietzsche ci sta dicendo in pratica che l’Ultimo uomo non è più capace di desiderare. La parola “desiderio” deriva dalla radice latina de-sidera, che letteralmente significa “mancanza di stelle”, e allude quindi al non riuscire più ad avvertire la privazione di qualcosa che potrebbe condurre al Bene. L’Ultimo uomo pensa di vivere la migliore e la più appagante delle vite, non aspira più a qualcosa che la potrebbe completare e arricchire, ripiegato com’è nel godimento di piccoli e passeggeri piaceri che lo portano a rinunciare a volere intensamente altri orizzonti di senso e di azione. Ma desiderare che cosa? Per esempio il cambiamento e il miglioramento di sé, del genere umano e del mondo intero. Senza desiderio non c’è consapevolezza della propria condizione di schiavitù. I milioni di uomini occidentali che in questo
Chi si discosta dal pensiero conformistico dell’umanità-gregge è considerato un folle da emarginare ed isolare socialmente. E ancora: “Noi siamo assennati e sappiamo tutto ciò che è avvenuto; abbiamo dunque diritto d’irridere ogni cosa. […] Si hanno i propri svaghi del giorno, e quelli della notte; ma si tiene in gran conto la salute”. L’Ultimo uomo ha particolarmente cara la salute. Come non riconoscere in questa immagine l’attuale ossessione del genere umano per il contagio da Covid? Il suo rinunciare a diritti e libertà, fino a pochi mesi fa percepiti come intoccabili, in nome di un’immaginaria purezza? L’Ultimo uomo è colui che secondo Zarathustra, la voce narrante dietro cui si nasconde il filosofo tedesco, pensa di aver inventato la felicità. Egli è felice della sua pochezza e mediocrità, si accontenta di svaghi illusori e salutismo e non sa più “generare una stella danzante”, non sa più “che cos’è amore, che cos’è creazione, che cos’è brama, che cos’è un astro”. Nietzsche ci sta dicendo in pratica che l’Ultimo uomo non è più capace di desiderare. La parola “desiderio” deriva dalla radice latina de-sidera, che letteralmente significa “mancanza di stelle”, e allude quindi al non riuscire più ad avvertire la privazione di qualcosa che potrebbe condurre al Bene. L’Ultimo uomo pensa di vivere la migliore e la più appagante delle vite, non aspira più a qualcosa che la potrebbe completare e arricchire, ripiegato com’è nel godimento di piccoli e passeggeri piaceri che lo portano a rinunciare a volere intensamente altri orizzonti di senso e di azione. Ma desiderare che cosa? Per esempio il cambiamento e il miglioramento di sé, del genere umano e del mondo intero. Senza desiderio non c’è consapevolezza della propria condizione di schiavitù. I milioni di uomini occidentali che in questo Il processo di alienazione dell’essere umano è iniziato secoli fa e non è riconducibile solo ed esclusivamente, come sosteneva il materialismo dialettico, alla sfera terrena dell’esistenza. L’alienazione riguarda anzitutto e soprattutto il piano spirituale dell’Essere, e colpisce la capacità dell’uomo di generare “stelle danzanti”, cioè la sua innata disposizione “erotica” a volere, a lanciarsi verso mete in apparenza irraggiungibili. Oggi a dominare sono la passività, la rassegnazione, l’accontentarsi di una vita miserabile in nome di una falsa sicurezza sanitaria. L’essere umano vive sempre più isolato dai suoi simili in una bolla virtuale lontano da relazioni umane soddisfacenti. Intere sfere dell’esistenza dell’attuale umanità sono ormai avviate sulla via della virtualizzazione: il lavoro, le amicizie, la sessualità. Lo smart working, i Social Network, You Porn sono diventati la cifra attraverso cui misurare l’alienazione umana. Si tratta di un processo che il Covid ha indubbiamente accelerato, ma che era in essere ben prima della diffusione della falsa pandemia e che affonda le sue radici nella perdita della capacità di de-siderare, cioè nella perdita della capacità di entrare in contatto con altre dimensioni dell’Essere. L’Ultimo uomo è un uomo a una dimensione, un uomo che è spinto a ritenere razionale, e quindi accettabile, cioè che della società ipertecnologica non è razionale. Gli attuali processi digitalizzanti della società postmoderna con le loro false promesse di emancipazione e miglioramento della vita sia individuale che collettiva hanno trovato nell’Ultimo uomo la perfetta cavia sperimentale, il supporto umano ideale per imporsi senza resistenza in una società già scossa da una crisi economica senza precedenti.
Il processo di alienazione dell’essere umano è iniziato secoli fa e non è riconducibile solo ed esclusivamente, come sosteneva il materialismo dialettico, alla sfera terrena dell’esistenza. L’alienazione riguarda anzitutto e soprattutto il piano spirituale dell’Essere, e colpisce la capacità dell’uomo di generare “stelle danzanti”, cioè la sua innata disposizione “erotica” a volere, a lanciarsi verso mete in apparenza irraggiungibili. Oggi a dominare sono la passività, la rassegnazione, l’accontentarsi di una vita miserabile in nome di una falsa sicurezza sanitaria. L’essere umano vive sempre più isolato dai suoi simili in una bolla virtuale lontano da relazioni umane soddisfacenti. Intere sfere dell’esistenza dell’attuale umanità sono ormai avviate sulla via della virtualizzazione: il lavoro, le amicizie, la sessualità. Lo smart working, i Social Network, You Porn sono diventati la cifra attraverso cui misurare l’alienazione umana. Si tratta di un processo che il Covid ha indubbiamente accelerato, ma che era in essere ben prima della diffusione della falsa pandemia e che affonda le sue radici nella perdita della capacità di de-siderare, cioè nella perdita della capacità di entrare in contatto con altre dimensioni dell’Essere. L’Ultimo uomo è un uomo a una dimensione, un uomo che è spinto a ritenere razionale, e quindi accettabile, cioè che della società ipertecnologica non è razionale. Gli attuali processi digitalizzanti della società postmoderna con le loro false promesse di emancipazione e miglioramento della vita sia individuale che collettiva hanno trovato nell’Ultimo uomo la perfetta cavia sperimentale, il supporto umano ideale per imporsi senza resistenza in una società già scossa da una crisi economica senza precedenti. E così le centrali di potere sovranazionali, vere azionatrici delle leve di tutti i cambiamenti, spesso in peggio, che coinvolgono l’intero globo, hanno preparato astutamente da almeno un secolo il terreno per far accettare all’umanità nel modo più naturale possibile la desacralizzazione della Patria, spazzata via dalla globalizzazione a trazione neoliberista. Oggi il massimo dell’offerta sacrificale che gli ultimi uomini arrivano a concepire come forma di ubbidienza cieca a un regime sanitario totalitario, che ogni giorno che passa li priva di un pezzetto di dignità, è “state a casa”. E così, se l’Uomo nuovo del Ventennio fu lo sbocco di un’umanità temprata dalle sofferenze e dai sacrifici della guerra, che dire dell’Ultimo uomo contemporaneo se non che è lo sbocco naturale dell’ultima fase dell’Età Oscura? Ma noi, uomini e donne che non si piegano e non si spezzano di fronte all’inevitabile tracollo della civiltà, sappiamo che ad ogni Età Oscura segue ciclicamente una nuova Età dell’Oro, in cui un’umanità ripulita dalle scorie del materialismo risorgerà dalle ceneri nella sua sfolgorante bellezza. L’Uomo della prossima Età dell’Oro che verrà, come profetizzato dal poeta latino Virgilio nella IV Egloga, “riceverà la vita dagli dèi, e vedrà gli dèi/ mischiati agli eroi ed egli stesso sarà visto da essi/ e reggerà il mondo pacificato dalle virtù del Padre”. Dunque, armiamo le nostre anime di inosabile e abbeveriamoci, noi uomini e donne rimasti ancora in piedi sulle rovine della civiltà, alla fonte della Bellezza, e che il nostro ubriacarci di Essa faccia da esempio e da monito a un’umanità derelitta che ha perso se stessa e il ricordo della sua missione nell’universo, in modo che ognuno di noi, come un secolo fa il Vate, possa dire a se stesso, fiero di se stesso: “Io ho quel che ho donato”. Quel che ho donato all’ideale, alla causa, a me stesso e all’Assoluto, e che qualsiasi diavoleria il potere di questo mondo inventi, non mi sarà tolto per l’eternità, varcando così le Età, i mondi e gli ultramondi.
E così le centrali di potere sovranazionali, vere azionatrici delle leve di tutti i cambiamenti, spesso in peggio, che coinvolgono l’intero globo, hanno preparato astutamente da almeno un secolo il terreno per far accettare all’umanità nel modo più naturale possibile la desacralizzazione della Patria, spazzata via dalla globalizzazione a trazione neoliberista. Oggi il massimo dell’offerta sacrificale che gli ultimi uomini arrivano a concepire come forma di ubbidienza cieca a un regime sanitario totalitario, che ogni giorno che passa li priva di un pezzetto di dignità, è “state a casa”. E così, se l’Uomo nuovo del Ventennio fu lo sbocco di un’umanità temprata dalle sofferenze e dai sacrifici della guerra, che dire dell’Ultimo uomo contemporaneo se non che è lo sbocco naturale dell’ultima fase dell’Età Oscura? Ma noi, uomini e donne che non si piegano e non si spezzano di fronte all’inevitabile tracollo della civiltà, sappiamo che ad ogni Età Oscura segue ciclicamente una nuova Età dell’Oro, in cui un’umanità ripulita dalle scorie del materialismo risorgerà dalle ceneri nella sua sfolgorante bellezza. L’Uomo della prossima Età dell’Oro che verrà, come profetizzato dal poeta latino Virgilio nella IV Egloga, “riceverà la vita dagli dèi, e vedrà gli dèi/ mischiati agli eroi ed egli stesso sarà visto da essi/ e reggerà il mondo pacificato dalle virtù del Padre”. Dunque, armiamo le nostre anime di inosabile e abbeveriamoci, noi uomini e donne rimasti ancora in piedi sulle rovine della civiltà, alla fonte della Bellezza, e che il nostro ubriacarci di Essa faccia da esempio e da monito a un’umanità derelitta che ha perso se stessa e il ricordo della sua missione nell’universo, in modo che ognuno di noi, come un secolo fa il Vate, possa dire a se stesso, fiero di se stesso: “Io ho quel che ho donato”. Quel che ho donato all’ideale, alla causa, a me stesso e all’Assoluto, e che qualsiasi diavoleria il potere di questo mondo inventi, non mi sarà tolto per l’eternità, varcando così le Età, i mondi e gli ultramondi.

 Risale a questo periodo l’idea che lassù potesse trovarsi il «nido» delle anime? A causa di tale credenza molti sciamani «misero le ali» e aggiunsero il piumaggio al loro abbigliamento, diventando così uomini-uccello? In Siberia, nella Valle di Angara, gli archeologi hanno ritrovato un gran numero di ciondoli di avorio di mammuth, vecchi cioè di svariate migliaia di anni, ognuno modellato sotto forma di un cigno in volo con un’elaborata incisione della testa e del collo, le ali mozzate e un foro sulla coda che fungeva da apertura per il laccio con cui sistemarlo attorno al collo.
Risale a questo periodo l’idea che lassù potesse trovarsi il «nido» delle anime? A causa di tale credenza molti sciamani «misero le ali» e aggiunsero il piumaggio al loro abbigliamento, diventando così uomini-uccello? In Siberia, nella Valle di Angara, gli archeologi hanno ritrovato un gran numero di ciondoli di avorio di mammuth, vecchi cioè di svariate migliaia di anni, ognuno modellato sotto forma di un cigno in volo con un’elaborata incisione della testa e del collo, le ali mozzate e un foro sulla coda che fungeva da apertura per il laccio con cui sistemarlo attorno al collo.

 È una grazia perché diveniamo noi stessi, ma è anche una maledizione perché siamo costretti a isolarci dal gregge al quale apparteniamo. Nei primi anni di vita le connessioni cerebrali vanno incontro a un grande modellamento sulla base dell’esperienza. Ciò struttura il cervello in una maniera unica da persona a persona. Per questo abbiamo tutti idee diverse gli uni dagli altri. Spesso le idee divergenti tra persone si scontrano tra di loro anche in maniera violenta. Nei primi secoli i cristiani erano perseguitati e lo sono ancora oggi. Giustino diceva però che i cristiani sono come un albero: se è potato con il martiro ne crescono nuovi rami, cioè nuovi cristiani. L’Islam è stata una grande piaga in Europa soprattutto nel passato. Spesso lungo la costa tirrenica, ma anche in quella adriatica dell’Italia, ci sono ancora molte torri. Servivano ad avvertire la popolazione dell’arrivo dei turchi, che saccheggiavano e massacravano intere città. Addirittura papa Leone X incontrò per caso a Roma il celebre corsaro ottomano Barbarossa che era sbarcato per perlustrare il territorio in vista di una conquista, ma riuscì a fuggire con il cavallo. Barbarossa poteva rapire il papa ma non lo fece per lasciare l’onore della cosa al sultano in una successiva battaglia. Cristianesimo e Islam costituiscono un chiaro esempio di come le idee sono tra loro divergenti. Non è facile aderire alle idee che si professano e tutti se ne accorgono. Abbiamo dentro di noi un fuoco sacro quando le pensiamo ma è molto difficile essere coerenti con noi stessi. Soprato di Pafo è stato un poeta comico greco vissuto tra IV-III sec. a. C. I suoi frammenti sono tutti tramandati da Ateneo. In uno di essi Soprato voleva mettere alla prova gli stoici e la loro vita dedita alla filosofia, alla filologia e alla pazienza. Mentre arrostiscono nella tortura e ritirano la gamba che sta bruciando, dovrebbero essere venduti perché non conoscono il vero pensiero!
È una grazia perché diveniamo noi stessi, ma è anche una maledizione perché siamo costretti a isolarci dal gregge al quale apparteniamo. Nei primi anni di vita le connessioni cerebrali vanno incontro a un grande modellamento sulla base dell’esperienza. Ciò struttura il cervello in una maniera unica da persona a persona. Per questo abbiamo tutti idee diverse gli uni dagli altri. Spesso le idee divergenti tra persone si scontrano tra di loro anche in maniera violenta. Nei primi secoli i cristiani erano perseguitati e lo sono ancora oggi. Giustino diceva però che i cristiani sono come un albero: se è potato con il martiro ne crescono nuovi rami, cioè nuovi cristiani. L’Islam è stata una grande piaga in Europa soprattutto nel passato. Spesso lungo la costa tirrenica, ma anche in quella adriatica dell’Italia, ci sono ancora molte torri. Servivano ad avvertire la popolazione dell’arrivo dei turchi, che saccheggiavano e massacravano intere città. Addirittura papa Leone X incontrò per caso a Roma il celebre corsaro ottomano Barbarossa che era sbarcato per perlustrare il territorio in vista di una conquista, ma riuscì a fuggire con il cavallo. Barbarossa poteva rapire il papa ma non lo fece per lasciare l’onore della cosa al sultano in una successiva battaglia. Cristianesimo e Islam costituiscono un chiaro esempio di come le idee sono tra loro divergenti. Non è facile aderire alle idee che si professano e tutti se ne accorgono. Abbiamo dentro di noi un fuoco sacro quando le pensiamo ma è molto difficile essere coerenti con noi stessi. Soprato di Pafo è stato un poeta comico greco vissuto tra IV-III sec. a. C. I suoi frammenti sono tutti tramandati da Ateneo. In uno di essi Soprato voleva mettere alla prova gli stoici e la loro vita dedita alla filosofia, alla filologia e alla pazienza. Mentre arrostiscono nella tortura e ritirano la gamba che sta bruciando, dovrebbero essere venduti perché non conoscono il vero pensiero! Tuttavia oggi il cristianesimo e le varie religioni tendono a rinnegare il passato ed apparire più concilianti, come quando alcune religioni nel passato perseguitarono i jainisti indiani, considerati fanatici, ma oggi sembra che li lascino in pace. Anche se ci sono a volte alcuni punti in comune tra le varie religioni. Basilio Magno (Omelia I sull’Esamerone) scriveva che Dio “creò” per intendere che la sua opera creatrice non finiva con solo questo mondo. E curiosamente anche l’Islam ha una visione simile, che compare molte volte nel Corano, a cominciare dalla sura 1,1: “Lode a Allah, Signore degli universi”, rabbi l-‘ālamīna. Essere coerenti con noi stessi è una cosa molto difficile perché il mondo delle idee di rado coincide con quello della realtà materiale. La materia, la ricchezza e gli svaghi ci allontanano dai tesori interiori. Per questo Jung diceva che niente ci isola di più del potere e del prestigio. Finiamo con lo smarrire la rotta, perdiamo la nostra anima, non siamo più noi stessi. Le idee tuttavia servono per vivere. Per esempio le leggi nascono dal mondo delle idee e servono per farci vivere in pace e in libertà. Cicerone (Pro Cluentio 53. 156): “Siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi”, legum … omnes servi sumus ut liberi esse possimus. I cabalisti insegnano che le risposte sono sempre a portata di mano, ma noi non siamo disposti a riceverle. Le idee vere, quelle che ci guidano nella vita, sono intuizioni sempre presenti in noi, ma non vogliamo vederle. Abbiamo una voce interiore che ci guida sempre, che gli orientali chiamano Osservatore e gli occidentali Coscienza morale. Spesso le idee coincidono tra loro, è in buona sostanza il fenomeno della intersoggettività. Nelle varie culture si parla sempre, nell’uomo, di livello corporeo, livello mentale, livello spirituale. La mente è individuale, invece lo spirito ci apre a dimensioni collettive, transpersonali e divine. La cultura norrena presenta questa terminologia:
Tuttavia oggi il cristianesimo e le varie religioni tendono a rinnegare il passato ed apparire più concilianti, come quando alcune religioni nel passato perseguitarono i jainisti indiani, considerati fanatici, ma oggi sembra che li lascino in pace. Anche se ci sono a volte alcuni punti in comune tra le varie religioni. Basilio Magno (Omelia I sull’Esamerone) scriveva che Dio “creò” per intendere che la sua opera creatrice non finiva con solo questo mondo. E curiosamente anche l’Islam ha una visione simile, che compare molte volte nel Corano, a cominciare dalla sura 1,1: “Lode a Allah, Signore degli universi”, rabbi l-‘ālamīna. Essere coerenti con noi stessi è una cosa molto difficile perché il mondo delle idee di rado coincide con quello della realtà materiale. La materia, la ricchezza e gli svaghi ci allontanano dai tesori interiori. Per questo Jung diceva che niente ci isola di più del potere e del prestigio. Finiamo con lo smarrire la rotta, perdiamo la nostra anima, non siamo più noi stessi. Le idee tuttavia servono per vivere. Per esempio le leggi nascono dal mondo delle idee e servono per farci vivere in pace e in libertà. Cicerone (Pro Cluentio 53. 156): “Siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi”, legum … omnes servi sumus ut liberi esse possimus. I cabalisti insegnano che le risposte sono sempre a portata di mano, ma noi non siamo disposti a riceverle. Le idee vere, quelle che ci guidano nella vita, sono intuizioni sempre presenti in noi, ma non vogliamo vederle. Abbiamo una voce interiore che ci guida sempre, che gli orientali chiamano Osservatore e gli occidentali Coscienza morale. Spesso le idee coincidono tra loro, è in buona sostanza il fenomeno della intersoggettività. Nelle varie culture si parla sempre, nell’uomo, di livello corporeo, livello mentale, livello spirituale. La mente è individuale, invece lo spirito ci apre a dimensioni collettive, transpersonali e divine. La cultura norrena presenta questa terminologia: Il filosofo indiano Gautama (Nyāya Sūtra III, 2, 24) riconosceva che esistono anche alcune qualità transeunti dell’anima che però è imperitura, quindi esistono delle conoscenze che subiscono un processo di distruzione, come un suono viene distrutto da un altro suono. Ciò che è nel mondo non è ciò che è sacro e quindi appartiene ad un altro mondo. Nei trattati sui rituali vedici loke, “nel mondo”, si distingue da kratau, “relativo alla cerimonia sacrificale”. Nei Veda il composto lokāloka compare una sola volta e per indicare la contrapposizione tra ciò che è nel mondo e ciò che non lo è
Il filosofo indiano Gautama (Nyāya Sūtra III, 2, 24) riconosceva che esistono anche alcune qualità transeunti dell’anima che però è imperitura, quindi esistono delle conoscenze che subiscono un processo di distruzione, come un suono viene distrutto da un altro suono. Ciò che è nel mondo non è ciò che è sacro e quindi appartiene ad un altro mondo. Nei trattati sui rituali vedici loke, “nel mondo”, si distingue da kratau, “relativo alla cerimonia sacrificale”. Nei Veda il composto lokāloka compare una sola volta e per indicare la contrapposizione tra ciò che è nel mondo e ciò che non lo è




 tà. Non ultimo e particolarmente diffuso è il rinvio al Centro del Mondo, pilastro dell’Universo o simbolo della resurrezione continua della vegetazione, della stagione primaverile o della rigenerazione stessa dell’uomo. È evidente la ricchezza di significati che l’Albero richiama, in particolare la ciclica rinascita del Cosmo che apparentemente, ciclicamente, sembra sfiorire e morire, ma poi prontamente si risveglia e rigenera in una continuità senza interruzione di fasi crescenti e decrescenti. Per la mentalità arcaica non esiste natura senza simbolo che la richiami: l’Albero, nello specifico, non è mai venerato in quanto tale, quale che sia la sua tipologia o quale sia la cultura che ne pratichi il culto, ma sempre e solamente per quello che “rivela” di altro: superando ciò che manifesta, l’Albero diventa così oggetto religioso, carico ontologicamente di forze sacre. È, infatti, verticale, cresce, perde il fogliame e lo recupera rigenerandosi (potremmo dire che muore-risorge ciclicamente); gli antichi non potevano rimanere indifferenti o ciechi di fronte a questa realtà a cui hanno subito attribuito un carattere metaforico-simbolico. Infatti, la contemplazione delle pure funzioni biologiche e naturali della vegetazione, ad un occhio “attento” rivelava un valore mistico, perché in esse si ritrovavano le operazioni stesse dell’intero Cosmo. Per la coscienza religiosa di moltissimi popoli, va ribadito, l’Albero è l’Universo stesso: lo ripete e lo riassume mentre lo simboleggia.
tà. Non ultimo e particolarmente diffuso è il rinvio al Centro del Mondo, pilastro dell’Universo o simbolo della resurrezione continua della vegetazione, della stagione primaverile o della rigenerazione stessa dell’uomo. È evidente la ricchezza di significati che l’Albero richiama, in particolare la ciclica rinascita del Cosmo che apparentemente, ciclicamente, sembra sfiorire e morire, ma poi prontamente si risveglia e rigenera in una continuità senza interruzione di fasi crescenti e decrescenti. Per la mentalità arcaica non esiste natura senza simbolo che la richiami: l’Albero, nello specifico, non è mai venerato in quanto tale, quale che sia la sua tipologia o quale sia la cultura che ne pratichi il culto, ma sempre e solamente per quello che “rivela” di altro: superando ciò che manifesta, l’Albero diventa così oggetto religioso, carico ontologicamente di forze sacre. È, infatti, verticale, cresce, perde il fogliame e lo recupera rigenerandosi (potremmo dire che muore-risorge ciclicamente); gli antichi non potevano rimanere indifferenti o ciechi di fronte a questa realtà a cui hanno subito attribuito un carattere metaforico-simbolico. Infatti, la contemplazione delle pure funzioni biologiche e naturali della vegetazione, ad un occhio “attento” rivelava un valore mistico, perché in esse si ritrovavano le operazioni stesse dell’intero Cosmo. Per la coscienza religiosa di moltissimi popoli, va ribadito, l’Albero è l’Universo stesso: lo ripete e lo riassume mentre lo simboleggia.